15 maggio 1948, quando la Nakba infinita ebbe inizio
La Nakba (il disastro, la catastrofe, il cataclisma, scelga chi legge il termine più adeguato), continua ancor’oggi, 76 anni dopo. Se a detta dell’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite fondata nel 1949 e che doveva temporaneamente assistere i profughi palestinesi, e che ancora esiste, da quel lembo di terra chiamato Rafah, fra il confine egiziano, la Striscia di Gaza e Israele, sono già state costrette all’esodo 450 mila persone, la pulizia etnica non è ancora stata fermata.
La storia non inizia, come ci si vorrebbe far credere. il 7 ottobre 2023, ma molto prima.
La Nakba originaria viene ricordata dal popolo di Palestina, sparso per il pianeta in infinite diaspore il 15 maggio di ogni anno, ma oggi assume, col genocidio in atto, un senso particolare, soprattutto per noi occidentali che possiamo ancora osservare da lontano.
Riguarda un periodo complesso della storia contemporanea, su cui ancora si stendono veli di vergognoso silenzio, soprattutto da parte delle nazioni europee e ipocrisia da tanti cosiddetti paesi fratelli arabi.
Proviamo a ripercorrere sinteticamente la vicenda.
A partire dal 1920 e dall’assunzione del controllo di una terra chiamata già Palestina, in cui convivevano culture diverse, da parte dei britannici, la regione conobbe una crescente immigrazione di persone di religione ebraica, che avevano già lo scopo di fondare uno Stato ebraico in quell’area. Coloro che emigravano si autodefinivano “un popolo senza terra per una terra senza popolo”. Ma l’area era già abitata e i dirigenti arabi presenti condussero una opposizione marcata a tale progetto che portò a moti di rivolta animati dal nazionalismo e dal panarabismo.
Difficile oggi accettare l’idea di uno scontro fra due forme diverse di civiltà, una tradizionale e agro–pastorale, l’altra industriale, una più vicina all’Occidente, l’altra all’impero Ottomano.
Più complesse erano le relazioni e più comuni erano e divennero la condivisa condanna all’occupante britannico, che diede luogo anche ad attentati.
Fra il 1936 e il 39 si verificò quella che venne chiamata “Grande rivolta”, da parte palestinese, contro occupanti britannici e aumento della presenza ebraica a cui fece seguito tanto la repressione dell’occupante di allora quanto la reazione delle organizzazioni ebraiche che si riconoscevano nel movimento sionista.
Si pose però freno all’arrivo di nuovi arrivi di persone provenienti dall’Europa, di religione ebraica, attraverso il Libro bianco del 1939, dopo che migliaia di persone, soprattutto arabe, erano state uccise nella rivolta. Intanto si rafforzarono le organizzazioni paramilitari sioniste mentre buona parte dell’élite palestinese fu arrestata o esiliata.
Da questa fase nasce uno dei principali imbrogli storiografici: il capo del Supremo Comitato Arabo, Hājjī Amīn al-Ḥusaynī, fuggì nella Germania nazista a cercare sostegno, da cui l’accusa infamante rivolta ancora ai palestinesi di essere “complici di Hitler”.
Finita la seconda guerra mondiale, con l’orrore della Shoah, in occidente venne ripresa in considerazione, anche per il senso di colpa provocato dalla tragedia, la creazione di uno Stato di Israele e crebbe il sostegno al movimento sionista, che intanto combatteva l’occupazione britannica. La Gran Bretagna annunciò nel febbraio 1947 di voler rinunciare al mandato sulla Palestina, a fine novembre dello stesso anno l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, appena formate, votò un piano di divisione della Palestina, senza il sostegno britannico e contro il parere degli stati arabi. Il voto portò ad una guerra civile fra le comunità arabe ed ebraiche, il 15 maggio, dopo il ritiro britannico, questa si trasformò in un conflitto fra lo Stato di Israele, proclamato il giorno prima e gli Stati arabi vicini.
Fu durante tale conflitto che si verificò la Nakba. Più di 700 mila arabi palestinesi furono costretti ad abbandonare le città, i villaggi, le case. Molti conservarono la chiave di casa ma da allora è proibito loro ogni diritto al ritorno. L’esodo divenne senza prospettive, i profughi si rifugiarono in Giordania, Siria, Libano, ma anche in quella che viene ancora chiamata Cisgiordania – teoricamente oggi amministrata dall’Anp e nella Striscia di Gaza.
Nacque l’Unrwa, l’agenzia apposita per sostenere i rifugiati palestinesi. Secondo i suoi dati, nel 2015, considerando i discendenti accumulati, oltre 5 milioni di persone erano sotto la sua assistenza, spesso rinchiuse in campi profughi eterni.
Gli storiografi che cercano di interpretare tali vicende sovente partono da due posizioni difficilmente conciliabili: da una parte chi afferma che la cacciata fu inevitabile per mettere al riparo lo Stato di Israele dal rischio di nuove violenze, dall’altra chi invece – punto di vista anche di intellettuali israeliani – come questo sia stato utilizzato come alibi per impossessarsi delle terre migliori e non doversi confrontare con una popolazione militarmente debole ma numericamente in crescita. L’esodo si sviluppò in una prima ondata fra il dicembre 1947 e il marzo 1948, quando ancora non era nata ufficialmente Israele. Un periodo caratterizzato da violenze sempre più forti fra le comunità e che portò soprattutto le classi agiate arabe a lasciare le proprie terre, alcuni anche vendendo le proprie abitazioni – parliamo di quasi 100 mila persone.
Con questa prima fase comincia a sgretolarsi la struttura dello Stato palestinese: chiudono scuole, ospedali, diminuisce il commercio, si rompono anche i nessi che permettevano una connivenza. Una parte di coloro che erano partiti speravano anche di poter tornare, una volta terminati gli scontri, ma ciò non avvenne. E comincia l’esodo anche dei fallahin, (le popolazioni rurali) che vivevano nelle terre che, nel Piano di divisione della Palestina vennero assegnate ad Israele. Una fase in cui le espulsioni vere e proprie si sommano ad atti di intimidazione, a rappresaglie, ad evacuazioni forzate soprattutto sulla fascia costiera, altro che emigrazione volontaria. Fra aprile e giugno del 1948 si assiste ad una seconda ondata di espulsioni legata a quella che è chiamata Offensiva dell’Haganah (storica forza paramilitare già in campo con attentati contro l’occupazione britannica), rimasta fino ad allora in secondo piano. Da qui la data del 15 maggio, quando lo scontro, anche con i Paesi arabi confinante, si espande e almeno 300 mila palestinesi sono costretti a lasciare le proprie terre.
Un’ulteriore cacciata si realizza alla fine del 1948. Ma le violenze non si arrestano. Il nuovo Stato israeliano, fino al 1950, si preoccupa di allontanare le popolazioni arabe anche dalle proprie frontiere mediante l’espulsione in Giordania. L’allora monarca giordano accettò tale soluzione e una parte dei palestinesi ottenne la cittadinanza giordana. Ma la guerra non ebbe fine: dopo la cd guerra dei Sei giorni, numerosi palestinesi furono costretti a rifugiarsi in Giordania, circa 750 mila. Fu la seconda diaspora, la cd “Naksa”, altrettanto crudele. Circa 750 mila palestinesi si rifugiarono in Giordania, da cui, dopo essersi organizzati nell’Olp (Organizzazione per la Liberazione della Palestina), iniziarono a compiere attacchi ai confini israeliani che vennero repressi dal governo giordano.
Nel 1970, durante quello che viene chiamato il “Settembre nero”, i soldati di Hussein di Giordania attaccarono i palestinesi, ne nacque una guerra civile che durò un anno e che portò all’espulsione dell’Olp dal paese, a dimostrazione di come fra i nemici della Palestina, i diversi regimi arabi non siano stati da meno di Israele. Il resto della storia è noto: l’espansione israeliana che non si arresta – non sono ancora stabiliti i suoi confini – la sua sempre più forte caratterizzazione religiosa, “lo Stato degli ebrei”, l’annessione di fatto realizzata di Gerusalemme come propria capitale cercando di eliminare qualsiasi velleità di farne città aperta e plurale, l’intensificarsi degli insediamenti di coloni anche nei territori occupati nel 1967 e ufficialmente amministrati dai palestinesi, parliamo di circa 800mila persone che hanno sottratto alle popolazioni originarie le terre migliori, le falde acquifere e ne hanno militarizzato i confini definendo una sorta di bantustan in cui città e villaggi palestinesi sono accerchiati, ne sono la prova. Lo storico israeliano Ilan Pappè utilizza non a caso e come percorso di lunga data, il termine “pulizia etnica”, portata avanti per modificare l’assetto demografico nell’intera Palestina. In definitiva c’è un continuum di 24 ore fra la nascita dello Stato di Israele e l’inizio della Nakba, una vicenda che travalica le vicende di questi mesi ma che in queste ore va collocata, per storicizzare e dare un senso agli eventi. E come non incentrare il tutto all’interno di una lunga e irriducibile resistenza di popolo, che nei decenni si è organizzata, è stata distrutta e si riorganizza, ogni volta in forma diversa.In 76 anni si sovrappongono da una parte colonialismo a neocolonialismo, dall’altra organizzazione laica a pulsioni speculari e fondamentaliste al cui centro c’è l’odio fra popoli e l’attuale inconciliabilità ad una convivenza paritaria. Viene da domandarsi, in questo drammatico anniversario, se abbia o meno ancora senso appellarsi all’antica formula “due popoli per due Stati”, quando da una parte si urla “from the river to the sea / Palestina well be free” mentre dall’altra si dichiara senza problemi che l’espulsione di tutti i palestinesi non è impossibile. In assenza di attori internazionali in grado di convincere tutte le posizioni attorno ad un tavolo di trattative, non è sufficiente che i Paesi arabi che oggi hanno portato a richiedere il riconoscimento ufficiale all’Onu della Palestina come Stato membro – voto passato a stragrande maggioranza ma con opposizioni e astensioni che non aprono a scenari felici – dimentichino di essere anche responsabili, nei decenni passati, della mancata realizzazione di uno Stato, in primis Egitto e Giordania. Ilan Pappe, uno dei più importanti e riconosciuti storici israeliani, professore e direttore del Centro europeo per gli studi sulla Palestina e co-direttore dell’Exeter Center for Ethno-Political Studies presso l’Università di Exeter. Nella sua analisi pubblicata per il Middle East Eye ha più volte descritto gli effetti di una vera e propria condizione di oppressione che ha preso le sembianze dell’apartheid contro i palestinesi.
Dice Pappe: «Da oltre trent’anni, gli storici sono venuti in possesso di sufficiente materiale d’archivio su cui è stato tolto il segreto, principalmente israeliano, per chiarire la strategia sionista dal novembre del 1947 fino alla fine del 1948. Ho definito nella mia opera la strategia sionista dell’epoca, un piano strategico per la pulizia etnica della Palestina. Col passare del tempo, il venire alla luce di altro materiale, e i sempre crescenti e fondamentali progetti palestinesi per una Storia costruita sui racconti orali, hanno sostanzialmente evidenziato quanto fosse adeguato applicare questo termine agli avvenimenti che i palestinesi hanno chiamato la Nabka. Negli ultimi anni, una vecchia definizione di Sionismo come un movimento coloniale sostenuto da coloni è stata ripresa da studiosi che si occupano di storia della Palestina. Questo può spiegare chiaramente come la dirigenza sionista non avrebbe mai potuto accettare una Palestina divisa. Come qualsiasi altro movimento coloniale, è stato un movimento di europei emarginati nel loro continente e che dovevano rifarsi una vita altrove, generalmente in luoghi già abitati da altre genti. Come ad esempio per il genocidio dei nativi americani in Nord America, il bisogno di eliminare le popolazioni indigene è stato il segno distintivo di simili movimenti. Possedere quanta più terra possibile con quanti meno nativi possibile era già stato un tema centrale del movimento e dell’ideologia sionista fin dai suoi primordi. Il dominio britannico aveva impedito ogni significativo possesso di terra (meno del sei percento delle terre palestinesi erano di proprietà sionista nel 1948). Ma sulla terra acquistata dai sionisti, principalmente dall’élite palestinese e da proprietari terrieri che vivevano all’estero, i coltivatori locali furono etnicamente espulsi con l’approvazione delle autorità britanniche. La dirigenza sionista cominciò a pianificare la pulizia etnica della Palestina nel febbraio del 1947 e le prime operazioni ebbero luogo un anno più tardi sotto gli occhi delle autorità britanniche provviste di mandato. La dirigenza sionista aveva bisogno di affrettarsi alla pulizia etnica dei palestinesi nel febbraio del 1948, cominciando con la forzata rimozione di tre villaggi sulla costa fra Giaffa e Haifa. Gli Stati Uniti ed altri membri delle Nazioni Unite avevano già cominciato a mettere in dubbio la validità di un piano di divisione e cercavano soluzioni alternative. Il dipartimento di Stato americano propose un’amministrazione fiduciaria internazionale sulla Palestina allo scopo di dare altro tempo per ulteriori negoziati».
E ci sono alcuni fatti, ormai rimossi dalla nostra memoria coloniale europea, che non possono non essere considerati pensando al presente. Durante la Nakba le atrocità commesse dall’esercito di Tel Aviv, furono numerose, non ci fu inibizione alcuna verso le popolazioni civili. Nel massacro di al-Dawayima, fra Beersheba e Hebron (28 ottobre 1948), 455 palestinesi, la metà dei quali donne e bambini, furono assassinati dai soldati israeliani. Soltanto due zone della Palestina storica sfuggirono temporaneamente alla pulizia etnica: quella chiamata Cisgiordania, occupata quasi senza combattimenti da forze giordane ed irachene, col tacito accordo fra Israele e Giordania in cui gli abitanti ebbero il passaporto giordano, ma i cui confini e la cui amministrazione rimase incerta fino all’occupazione del 1967. La pratica dell’espulsione collettiva continuò nel tempo, anche attraverso l’abbattimento di case e di villaggi interi.
Ma parlavamo di due aree, la seconda, di fatto artificiale è la Striscia di Gaza, al confine con l’Egitto, dove vennero confinati centinaia di migliaia di profughi sradicati dalle zone meridionali della Palestina, i cui discendenti ancora vivono nei campi. Per decenni è passata la vulgata secondo cui la moderna tecnologia israeliana avrebbe provveduto a trasformare il deserto in giardino, un giardino coltivabile in cui tutti avrebbero potuto convivere in pace. E di giardini ce ne sono, di aree verdi, ma sorgono su villaggi demoliti, intorno a città da cui i palestinesi sono stati cacciati.Secondo Pappe, «Il messaggio che giunse ad Israele dal mondo fu che la pulizia etnica della Palestina, ben nota in Occidente, era accettabile; principalmente come compensazione per l’Olocausto e i secoli di antisemitismo che avevano imperversato in Europa. Quindi Israele ha continuato la sua pulizia etnica dopo il 1967, quando ancora una volta ulteriore territorio occupato portò sempre più gente “indesiderata”. Questa volta la pulizia etnica è stata incrementata, e continua anche oggi. Tuttavia, i palestinesi sono ancora lì, mettendo in mostra un’incredibile resilienza e resistenza – insieme alla continua Nabka, c’è una persistente Intifada e, fino a quando Israele non risponderà per quanto ha fatto e sta facendo, la colonizzazione continuerà, così come la lotta anticolonialista contro di lui».
Il ricordo della Nakba porta a dire che, nel genocidio in corso, il cessate il fuoco è condizione necessaria ma non sufficiente. Ci vorranno, o ci vorrebbero forse decenni, per definire un percorso che deve essere per forza restitutivo di terra, acqua e di futuro. La forma che dovrà o potrà assumere una nuova convivenza è impensabile oggi, ma non può non contemplare il diritto al ritorno dei tanti e delle tante ancora ammassati nei paesi confinanti, non può non vedere un disarmo generalizzato che apra le porte ad una ricostruzione non solo temporanea. Uno Stato binazionale, due Stati di cui è difficile immaginare la configurazione, il riconoscimento di diritti negati da troppi decenni? Impossibile oggi immaginare il futuro ma una cosa è certa. I thank pronti ad entrare a Rafah, col pretesto di sconfiggere il fondamentalismo di Hamas, non saranno mai la soluzione ma l’enfatizzazione del problema, la cacciata di nuove generazioni di profughi non porterà mai a quella sicurezza che da Tel Aviv viene richiamata come condizione indiscutibile.
La Nakba va affrontata, riconosciuta e risarcita, per i quasi 80 anni di tragedie che ha determinato e determina tutt’ora, con tutte le responsabilità dell’Europa, degli Usa e dei tanti regimi arabi che si sono succeduti nel tempo. Il mondo multipolare non avrà mai pace fino a quando su Gerusalemme potrà sventolare una sola bandiera e fino a quando i proprietari di quelle chiavi arrugginite dal tempo, non potranno ritrovare la propria porta.
Stefano Galieni
15/5/2024 https://transform-italia.it/





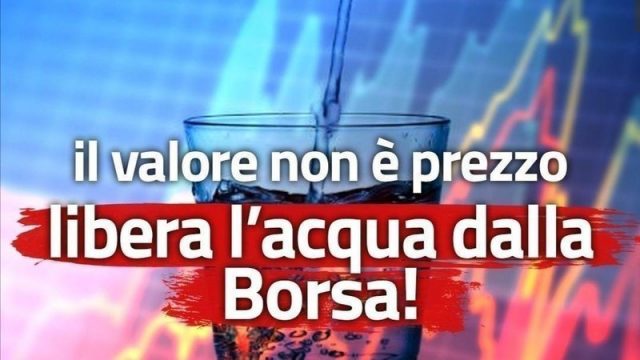




Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!