WELFARE AZIENDALE: QUESTO SCONOSCIUTO

Quando la cronaca di questo primo ventennio del nuovo secolo lascerà spazio alla storia, di certo qualcuno si chiederà quando e come si è realizzata, nel nostro Paese, la controrivoluzione liberista che ha posto fine e sconfitto la lotta di classe dei lavoratori.
Sarà allora utile rispolverare quella che oggi rappresenta l’ultima fatica[1] di Marta Fana; ricercatrice in Economia presso l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po).
Ciò consentirà di capire attraverso quale subdola scientificità siamo oggi costretti ad agire come cittadini e lavoratori; in un contesto in cui la centralità dell’impresa è ritenuta fuori discussione e il conflitto capitale-lavoro deve risultare antistorico.
Apparirà una vera e propria rivelazione scoprire perché mai il lavoro, in ossequio e in funzione di esigenze di carattere organizzativo e all’applicazione delle nuove tecnologie, ne è risultato frammentato e i lavoratori ormai separati gli uni dagli altri. Sarà allora chiaro che il lavoro subordinato di carattere quasi residuale, l’anomala esplosione del parasubordinato, il fiorire delle c.d. “Partite Iva”, del lavoro interinale e a chiamata, degli stage e tirocini, fino al lavoro gratis, erano elementi funzionali a una certa politica e al padronato al fine di lasciar credere: a) praticamente esaurito un processo evolutivo durato quasi un secolo, b) ormai implicita la scomparsa della classe lavoratrice.
Saranno, quindi, in tanti a dover riconoscere di aver assistito – da ignavi – a uno scontro fratricida tra quelli che Pietro Ichino – separandoli (in maniera subdola ed artificiosa) in lavoratori “protetti” e “paria” – aveva, in sostanza, scagliato gli uni contro gli altri. Una vera e propria “guerra tra poveri”; alla fine della quale il risultato sarebbe stato non la equiparazione dei diritti – come, strumentalmente, predicava il senatore Pd – ma, in modo molto più grave, la sostanziale riscrittura della Legislazione del lavoro italiana; con un drastico ridimensionamento delle tutele.
Così come si ricrederanno quanti – soprattutto tra gli ex giovani, ma non solo – saranno finalmente in grado di prendere atto di essere state vittime inconsapevoli di un’infame operazione finalizzata a promuovere una sorta di identificazione[2] psicologica con i propri sfruttatori. Alludo, evidentemente, a tutti quei soggetti sui quali facevano fin troppo facile presa quelle (strumentali) allusioni alla tecnologia e al progresso quali precursori della “fine del lavoro”, della scomparsa della classe lavoratrice, del superamento del rapporto tra produzioni di tipo capitalistico e classe operaia, della risoluzione del conflitto capitale-lavoro, della definitiva e irreversibile separatezza tra lavoro manuale e cognitivo, dell’esaltazione del lavoro “in rete” e “a distanza” e dei nuovi saperi.
Ci si renderà conto della caducità di quel diffuso, fallace e fittizio convincimento di “appartenenza gratificante” a una sorta di elitè che nulla avrebbe avuto più da spartire con una classe lavoratrice obsoleta e, per giunta, persino (ancora) “protetta” da norme risalenti al secolo precedente[3]. Tornerà allora alla mente quel giovane con la “24 ore” e la partita Iva, senza alcun vincolo contrattuale, lieto di essere unico e così diverso da quella massa di salariati d’altri tempi – in perenne attesa dello scatto biennale e, perché no, con la tuta unta di chissà cosa – fallacemente sicuro, nonostante l’inesistenza del “progetto” e l’incongruenza della reitera dei suoi contratti a termine, di essere assolutamente indispensabile e inscindibile dai fini aziendali.
Allo scopo, quindi, di evitare di ritrovarci ancora nella scomoda condizione di dover ammettere che “Sarebbe stato meglio vivere di rimorsi” – ed espiare la pena per gli eventuali errori – “piuttosto che di rimpianti!” – per tutto quanto si sarebbe potuto fare e non si è fatto – è opportuno sollecitare il confronto e l’approfondimento su di una questione che oggi, ai più, appare ancora come qualcosa di vago e destinato a procedere quasi in sordina; alludo a quello che gli specialisti chiamano “welfare aziendale”.
Espresso in estrema sintesi, il welfare aziendale è rappresentato da una molteplicità di servizi e iniziative – di diversa natura – di fonte contrattuale, che dovrebbero concorrere “a migliorare la qualità di vita dei lavoratori e porli nelle condizioni di potersi esprimere al massimo delle loro possibilità”. Si tratta, in sostanza, di un modello che prevede una serie di “prestazioni”, alternative al salario, cui i lavoratori possano accedere in maniera più o meno personalizzata, in base a necessità e scelte personali e/o familiari.
In questo senso, quella che negli Usa e in molti Paesi europei è una realtà già largamente consolidata da molti anni, in Italia – a parte le interessanti esperienze presenti in alcune grandi imprese – comincia ora a muovere i primi passi.
Prima, però, di entrare nel merito delle possibili proposte – attraverso le quali, in concreto, è possibile realizzare il miglioramento delle condizioni di vivibilità dei lavoratori – è il caso di fornire “qualche numero”.
Dalla lettura del “Primo Rapporto Censis-Eudaimon[4]” sul welfare aziendale, realizzato in collaborazione con Eudaimon (aziende leader nei servizi di questo tipo) e con il contributo di Credem, Edison e Michelin, si evince che solo il 17,9 per cento dei lavoratori italiani ha una conoscenza precisa di cosa sia il welfare aziendale, il 58,5 % lo conosce solo per grandi linee e il 23, 6 % ancora non sa cosa sia.
Ne hanno una conoscenza minore i lavoratori con livelli più bassi di scolarità (il 47% di quelli con al più la licenza media non sa cosa sia), quelli con redditi bassi (44,6%), i genitori single (40,3%), gli occupati con mansioni esecutive e manuali (36,7%) e le lavoratrici (30,1%).
L’indagine rileva che chi lo conosce meglio lo apprezza di più; infatti è favorevole alla sua diffusione il 74,4% di chi lo conosce in modo preciso rispetto al 43,3% di chi non ne ha conoscenza.
Anticipo subito che, a mio avviso, sarebbe folle ritenere che le aziende – tutte le aziende, dalle più piccole alle multinazionali – possano decidere di ricorrere a forme di welfare aziendale al solo scopo di migliorare le condizioni di vita dei propri collaboratori.
Se e quando vi ricorrono, lo fanno per una serie di motivi; non ultimi, oltre a un’opera di fidelizzazione, allo scopo di migliorare il “clima” nell’ambiente di lavoro e creare i presupposti affinché tutti lavorino al massimo delle loro possibilità; con conseguenti riscontri in termini di maggiore produttività.
In questo senso, da un’indagine relativa alle piccole e medie imprese – cui tornerò più avanti – emerge che il miglioramento della soddisfazione dei lavoratori e del clima interno, attraverso le opportunità offerte dal welfare aziendale, rappresenta l’obiettivo prioritario per oltre il 50% delle aziende consultate. Incentivare la produttività e contenere il costo del lavoro – attraverso gli sgravi fiscali concessi alle aziende che attuano programmi di quella natura – è prioritario per il 20% delle stesse. Migliorare l’immagine e la reputazione aziendale – in altre parole: aumentare il potere di trattenete e “attrarre” i lavoratori – rappresenta l’obiettivo prioritario del 9,2% delle aziende che vi ricorrono.
In concreto, le più diffuse forme di welfare aziendale potrebbero sommarsi e, almeno in parte, identificarsi con quelli che, una volta, erano i famosi “benefit”; presentii soprattutto nelle grandi aziende e nelle multinazionali (assistenza sanitaria integrativa, piani di risparmio, convenzioni con grandi distributori di beni e servizi, convenzioni con banche e istituti finanziari per la concessione di prestiti e mutui a tassi agevolati).
Da pochi anni a questa parte, grazie anche alle agevolazioni fiscali previste, pure nelle piccole e medie imprese, si sta diffondendo l’idea che l’offerta di prestazioni di questa natura possa concorrere a soddisfare esigenze del personale diverse dal semplice aumento di salario e, contemporaneamente, offrire vantaggi alle imprese.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che già la Legge di Stabilità 2016, come anche la successiva, aveva previsto agevolazioni fiscali a favore delle imprese e dei lavoratori coinvolti in iniziative tendenti a realizzare, in sostanza, un’efficace evoluzione dei compensi riconosciuti ai lavoratori per il raggiungimento degli obiettivi di competitività delle aziende, in programmi di welfare aziendale.
Ciò ha, naturalmente, offerto la possibilità di dare libero sfogo alla fantasia, nel senso che il ricorso all’uno piuttosto che all’altro strumento di welfare aziendale, è stato reso compatibile con il profilo, le caratteristiche e le esigenze dell’impresa e dei lavoratori coinvolti.
Allo stato, quindi, tra quanto avviato attraverso le realizzazioni di welfare aziendale e i già esistenti benefit, gli esempi si sprecano.
Quello dei “buoni pasto” è un caso sin troppo noto, che non ha bisogno di alcun commento; è sufficiente aggiungere la possibilità di servirsi della c.d. “Pass Lunch Card”, che può essere utilizzata in più locali opportunamente convenzionati.
Esiste la possibilità di acquistare libri di testo a prezzi scontati con librerie convenzionate.
Sempre grazie alle convenzioni è possibile stipulare polizze assicurative con società che offrono sconti e rateizzazioni, acquistare biglietti di ingresso per mostre, tetri e cinema a prezzi scontati, acquistare auto e pezzi di ricambi a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato classico.
Così come è possibile ricorrere alle convenzioni per garantire viaggi, vacanze e soggiorni all’estero ai dipendenti e alle loro famiglie a prezzi scontati o con il contributo dell’azienda.
Si tratta, in sostanza, di una miriade di opportunità e soluzioni che richiederebbero troppo spazio per essere indicate singolarmente.
Molto interessanti, a questo riguardo, sono i risultati emersi da un’indagine[5] promossa da Assicurazioni Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni per rilevare le principali caratteristiche che il welfare aziendale assume nelle piccole e medie imprese italiane.
Il campione oggetto della rilevazione era composto da 239 aziende con meno di 6 dipendenti (7,34% delle aziende consultate), 573 da 6 ai 9 addetti (17,6%), 865 da 10 ai 50 addetti (26,5%), 905 da 51 a 100 (27,8%) e 670 da 101 a 250 dipendenti (20,6%).
I risultati indicano che le aree (pari a 12) attraverso le quali si sviluppa, in particolare, il welfare aziendale sono rappresentate, nell’ordine, da: 1) previdenza integrativa, 2) sanità integrativa, 3) polizze assicurative, 4) sostegno economico, 5) formazione dipendenti e 6) sicurezza e prevenzione degli incidenti. Seguono, con tassi di iniziativa meno evidenti: a) il sostegno ai soggetti deboli, b) servizi di assistenza ai lavoratori e alle loro famiglie, c) iniziative legate alla cultura e al tempo libero e d) il sostegno all’istruzione dei familiari del lavoratore.
Nei settori del commercio e dei servizi il welfare aziendale si realizza, in modo particolare, attraverso la sanità integrativa e le polizze assicurative. Le aziende del settore industriale presentano, invece, tassi di intervento equivalenti in quasi tutte le aree di riferimento.
Gli studi e i servizi professionali investono in aree specifiche dei loro settori; la formazione dei dipendenti e la prevenzione degli incidenti. Nell’artigianato le ridotte dimensioni delle aziende rappresentano un ostacolo allo sviluppo del welfare aziendale; mentre nell’agricoltura un alto tasso di iniziative è rappresentato dagli strumenti di sostegno economico ai lavoratori.
Nel “Terso settore”, infine, sono presenti elevati livelli di intervento nelle aree della c.d. “conciliazione vita-lavoro”, della sanità integrativa, della cultura, ricreazione e tempo libero.
Dal rapporto emerge che la dimensione dell’azienda rappresenta il fattore che incide maggiormente sulla possibilità di strutturare un piano di welfare aziendale più complesso e ricco, dal punto di vista dell’offerta di servizi.
A titolo di esempio, riporto che le aziende che possono vantare il maggior numero di iniziative – con interventi in almeno 6 delle 12 aree presenti nel rapporto – sono il 6,8% di quelle con meno di 10 addetti e il 44,7% di quelle con un numero di addetti da 101 a 250.
Un altro importante elemento è quello relativo alla “natura” del welfare disponibile in azienda.
Sempre restando ai risultati del secondo rapporto, si rileva che circa il 75,5% delle aziende non ha ricercato il coinvolgimento delle OO.SS. nella stesura del programma di welfare aziendale. Soltanto il 2,6% delle aziende coinvolge sistematicamente il sindacato. Solo in alcune aree del Paese il 21,9% delle aziende pratica accordi sindacali su tali materie.
È altresì interessante evidenziare che le aree che attengono alla previdenza e alla sanità[6] integrativa sono quelle nelle quali prevalgono le iniziative in applicazione dei Ccnl; ciò nonostante una consistente parte delle Pmi (il 22% delle interpellate) è molto attiva nel ricorrere a forme di sanità integrativa in modo del tutto unilaterale.
Naturalmente sull’ulteriore sviluppo e diffusione di iniziative riconducibili a sempre più articolati progetti di welfare aziendale – in tutti i settori e, soprattutto, anche nelle realtà produttive più piccole – contano anche le forze politiche. L’interesse a queste (sostanzialmente) alternative quote di salario è rappresentato dalla produzione legislativa degli anni più recenti.
Non a caso, la lettera f, del 2° comma, dell’art. 51 del TUIR dichiara esenti dall’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) tutte le prestazioni:
- di carattere educativo,
- di carattere istruttivo,
- di tipo ricreativo,
- che hanno ad oggetto l’assistenza sociale e sanitaria del dipendente,
- che ineriscono al culto della religione
A queste si aggiungono i servizi di educazione e istruzione, i servizi riconducibili alle c.d. colonie climatiche, alle borse di studio conferite al dipendente o ai familiari e le prestazioni erogate a favore di familiari anziani, non auto-sufficienti o handicappati.
Inoltre, dal gennaio 2017 i premi di produzione non concorrono più a formar e il reddito complessivo del lavoratore ai fini dell’ISEE.
Non è secondario, poi, il fatto che, per le aziende, così come per i lavoratori, concordare (in sede contrattuale) forme di welfare aziendale, in alternativa alla corresponsione del classico “premio di produzione”, rappresenta – oltre all’opportunità di creare un ambiente lavorativo più sereno e motivato, con effetti positivi rispetto all’assetto organizzativo e produttivo – la possibilità di godere di notevoli sgravi fiscali.
Di conseguenza, non appare peregrino immaginare che nel breve-medio termine i lavoratori sentiranno parlare con sempre maggiore frequenza di welfare aziendale e ne subirà le conseguenze anche il confronto tra le parti sociali. Infatti, in virtù del regime fiscale agevolato applicato a così tante ipotesi di benefit, sarà arduo, per le OO.SS. di categoria – in sede di rinnovi contrattuali nazionali e/o territoriali, oltre che aziendali – sottrarsi all’accattivante ipotesi di garantire ai lavoratori consistenti sgravi fiscali sottoscrivendo accordi nei quali le prestazioni di welfare aziendale rappresenteranno un’allettante alternativa a quelli che, una volta, avrebbero rappresentato normalissimi aumenti salariali.
Non sarà un problema di poco conto.
A questo riguardo, è indispensabile evidenziare altri due punti.
Il primo è che le motivazioni che inducono le aziende a tentare di coinvolgere le parti sociali nella condivisione delle logiche del welfare aziendale non sono, di certo, dettate da un commovente spirito filantropico. Rappresentano, piuttosto, la conseguenza di una ferrea logica; di carattere esclusivamente – e non potrebbe essere altrimenti – economico. La possibilità di investire meno risorse economiche – si pensi ai notevoli sgravi fiscali concessi – e, contemporaneamente, vestire i panni del “buon padre di famiglia” che elargisce benefit e, addirittura, supplisce a vuoti e carenze presenti “fuori” del posto di lavoro.
Da non dimenticare, quindi, che la probabile esistenza – nel futuro di milioni di lavoratori italiani – di una qualunque formula di welfare aziendale, rappresenterà, non una benefica concessione del proprio datore di lavoro, quanto il frutto di contrattazione collettiva.
Il secondo, ci riporta ai numeri del Rapporto Censis-Eudaimon, rispetto ai quali ritengo degno di nota aggiungere che dallo stesso emerge un dato che dovrà indurre tutti gli attori ad approfondire la discussione circa la concreta capacità del welfare aziendale di riuscire a soddisfare le esigenze della generalità dei lavoratori. Infatti, in un passaggio del rapporto, si afferma, tra l’altro: “Il sostegno al welfare aziendale diminuisce al decrescere dei redditi dei lavoratori”.
Non a caso, i più favorevoli sono i dirigenti e i quadri (73,6%), i laureati (63,5%) e i lavoratori con redditi medi-alti (62,2%).
Come si vede, non tutto ciò che luccica è oro.
In questo quadro, esiste anche il rischio che le politiche di welfare aziendale, se rigidamente collegate alla logica del premio di produzione (di norma fissato con parametri che fanno riferimento agli inquadramenti contrattuali), finiscano con il favorire coloro che già godono di redditi più altri; a discapito di quanti avrebbero maggiore bisogno di alleviare uno stato di difficoltà oggettiva e poter, quindi, sommare allo scarso salario una serie di prestazioni in regime di welfare aziendale.
In definitiva: così come, nell’esecuzione di qualsiasi piano terapeutico, è fondamentale non sottovalutare mai le contro-indicazioni del farmaco in uso, rispetto alla questione del welfare aziendale, sarà indispensabile procedere con la massima cautela prima di lasciarsi perdutamente ammaliare dal canto delle sue sirene.
Sarà nostro impegno offrire quanto più spazio e tempo possibili a un’approfondita discussione di merito.
[1] “Non è lavoro, è sfruttamento”; Laterza Editore.
[2] Qualcosa di simile alla c.d. “Sindrome di Stoccolma”, che porta a istaurare una sorta di alleanza tra vittima e carnefice
[3] L’immaginario collettivo era particolarmente stimolato a confrontare lo” stato di precarietà” con le garanzie previste dallo Statuto; con particolare riferimento all’ art.18 e alla c.d. “giusta causa”.
[4] www.eudaimon
[5] Fonte: Rapporto Welfare Index PMi 2017
[6] L’argomento sarà adeguatamente approfondito a breve
Renato Fioretti
Esperto Diritti del Lavoro. Collaboratore redazionale Lavoro e salute
Articolo pubblicato sul numero di marzo del periodico cartaceo www.lavoroesalute.org


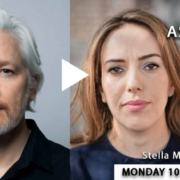







Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!