Che fine ha fatto l’università?

[Secondo contributo di Terroni d’Europa, clicka qui per la pubblicazione completa]
Prima di parlare del rapporto tra ricerca e università con il mondo del lavoro, vorrei parlare anche delle relazioni tra questo con la scuola e l’istruzione secondaria.
Qual è il legame tra autonomia, politica e istituzioni? Le trasformazioni dentro la scuola, così come quelle dentro il mercato del lavoro, rispondono fortemente alla politica e al modo in cui la politica si forma in termini di ideologia e di egemonia sui corpi, sulle leggi e sulla struttura.
Negli ultimi anni la scuola, come luogo di formazione e istruzione, è stata svuotata di senso. L’idea che sta alla base delle attuali politiche rincorre l’obiettivo della funzionalità in termini produttivi, cioè che tutti risultino impiegabili all’interno delle aziende italiane. Di conseguenza si pone attenzione, soprattutto sul piano mediatico, sul falso mito dell’inutilità delle formazioni umanistiche, a favore della funzionalità delle formazioni professionali. Per questo si è arrivati in tempi brevissimi all’obbligo dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Il problema riguarda non solo il fatto che 200 ore per i licei e 400 per gli istituti professionali vengono sottratte alla formazione, ma che vengono impiegate nello svolgimento di lavoro gratuito. Affermiamo sonoramente che non c’è nulla di formativo dentro questi progetti!
Gli studenti che frequentano ancora i licei e coloro che invece frequentano gli istituti tecnici vengono da due estrazioni sociali differenti: la scuola è un luogo dove le diseguaglianze che già esistono si riproducono e si consolidano. Anche dentro l’università questa condizione si cristallizza e diventa immutabile. Coloro che avrebbero più bisogno di istruzione, in termini di alfabetizzazione e pensiero critico (ma anche solo per acquisire le abilità di leggere il contratto di lavoro), sono soprattutto quelli che vanno nelle scuole professionali.
La retorica dietro tutto questo, cioè dietro al fatto che stiamo cominciando a lavorare a 16 anni per un obbligo interno ai percorsi formativi, si fonda sulla credenza che la scuola oggi non prepari al mondo del lavoro e non sia funzionale al mercato privato di produzione.
Il più grande accordo fatto dal Miur all’interno dell’ASL è stato siglato con McDonald’s, il secondo con Zara. La visione politica che passa attraverso ciò è che, visto che ci troviamo di fronte alla trasformazione del mondo del lavoro a causa della globalizzazione e dell’automazione (situazione a cui di fatto i governi non hanno mai posto un freno), il nostro futuro sarà ambire al massimo a lavorare come commessi. Dal punto di vista macroeconomico cosa produciamo? Una volta producevamo chimica (che poi è stata svenduta), micromeccanica, elettronica… Domani faremo i camerieri — per esempio da McDonald’s — ma ci saranno casi anche più radicali di questi. Oltretutto questo accade anche in scuole industriali, quindi istituti tecnici professionalizzanti: a Messina per esempio gli alunni vengono mandati a raccogliere le cozze. Nella provincia di Modena, dove il settore industriale e il tessuto produttivo era di qualità, ci sono stati dei consiglieri comunali che si sono vantati del fatto che gli accordi di ASL hanno permesso a molti ragazzi di andare a pulire i giardinetti degli ospedali.
Da un lato c’è un circolo vizioso rispetto alla produzione di beni pubblici, cioè nell’esempio di Modena quella risulta essere una domanda di lavori pubblici che i comuni hanno, ma che non riescono a soddisfare attraverso un lavoro salariato. Tali lavori fino a qualche mese prima erano affidati ai richiedenti asilo. È un fenomeno molto classista: non ci andranno ovviamente chi frequenta il liceo Tasso di Roma, ma la faranno gli istituti tecnici della provincia.
Dall’altro lato, preparare gli studenti a lavorare in questo modo, senza diritti e retribuzione, significa abituarli fin da subito al lavoro gratuito, oltre che a un ambiente di controllo e di ubbidienza: la scuola ti prepara ad essere disciplinato dentro i luoghi di lavoro.
In uno dei decreti delega della legge 107 la ministra Fedeli dice di trasformare la tesina, che prima era un progetto conoscitivo, nel dossier di fine ASL. In questo senso si configura uno stravolgimento del contenuto della scuola. Le scuole sono state iscritte in una logica di funzionalità del mercato, il quale — assieme al più generale futuro produttivo economico e sociale — non è nemmeno discusso in Italia. Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro risulta essere un sintomo dell’impoverimento: siamo la generazione più formata della storia d’Italia, però c’è una regressione in termini di alfabetizzazione culturale, processo che si radicalizza in qualche modo dentro l’università o in settori disciplinari come l’economia, segmenti in cui il contenuto della formazione non ha più nessun valore.
Ora arriviamo all’università, altro luogo votato al controllo e alla funzionalità produttiva. La dinamica dei tirocini curriculari ha la funzione di inserimento nel mercato del lavoro — di fatto gratuitamente e senza nessuna autonomia — giacché parlare di autonomia dentro la scuola è un conto, ma l’autonomia sul luogo di lavoro è tutta un’altra storia.
La questione dal punto di vista del contenuto dell’insegnamento universitario, cioè cosa si impara e quale tipo di cultura si acquisisce — e qui riporto la mia esperienza dentro la facoltà di economia, dove ci sono di fatto pochi eterodossi ed è molto mainstream — si riduce a un’unica bolla teorica dominante. Non adattarsi a quelle condizioni significa per forza uscire dal mondo accademico. A Bologna questo si sa bene, perché il dipartimento di economia è uno dei più mainstream in termini di job market e si avvicina tantissimo alla Bocconi.
Questa questione può essere affrontata anche in termini di spazi, perché il carico di lavoro all’università è mediamente aumentato, e contemporaneamente lo spazio curriculare è sempre più ristretto dentro determinate discipline. I piani di studio — quante ore da dedicare ad una materia piuttosto che ad un’altra — sono stabiliti in alto: per esempio in 10 anni di economia, studiando in circa sei dipartimenti d’Europa, ho fatto soltanto una lezione su Keynes.
È un problema alla luce del ruolo che si acquisisce all’interno dell’università e di come ci si forma nei confronti della società, in poche parole della posizione che si occupa a favore o contro un determinato discorso egemonico. Secondo me occorre condurre una battaglia interna, aiutando gli studenti e spronandoli a uscire dalle rigide bibliografie dei corsi di studio. Un ostacolo risiede nella coscienza degli studenti: essi sanno che non verranno valutati per quello, tutto ciò che è contro-egemonico vale zero in termini accademici.
Questa situazione causa la segmentazione della ricerca. La sfera della ricerca appare funestata da una sorta di taylorismo applicato in cui l’unica cosa importante è produrre paper su paper da pubblicare, senza preoccuparsi di portare a termine la ricerca dando un senso a quello che si sta facendo. Nel 2008 dentro i master in economics, era piuttosto diffuso che non si discutesse della crisi, figuriamoci delle sue cause. Ciò si riversa poi nel rapporto che abbiamo in termini politici in quanto cittadini: lo sviluppo delle università e la riproduzione in serie delle dinamiche dei dipartimenti afferisce a un certo tipo di egemonizzazione del pensiero dominante, nonché a un’omologazione del dibattito intellettuale. Si produce un sapere di stampo ingegneristico, ci si chiede quali siano i criteri di applicabilità di un determinato problema, di una determinata questione, ma non si mette in discussione il paradigma dominante che genere quel suddetto problema. I finanziamenti e i grant non si vincono se ci si occupa di altro o in maniera non connivente al sistema universitario.
La vera domanda è: vale la pena studiare? Anche nella teoria mainstream se ne afferma la necessità, occorre che il differenziale sia determinato dal fatto che c’è una fascia più qualificata di un’altra. La formazione formale prepara al fatto che esistano delle diseguaglianze, che vengono spiegate però in termini di bravura: se siete più bravi avrete di più. Questo è il ricatto morale della meritocrazia.
Alcuni studiosi hanno provato ad analizzare il fattore della distribuzione delle diseguaglianze, sia tra persone con diversi titoli di studio, sia all’interno degli stessi titoli di studio; l’istruzione o la formazione ci spiega le diseguaglianze. Studiare però serve, perché è vero che mediamente i laureati guadagnano di più, anche se guadagnano sempre meno. Il differenziale infatti si riduce se consideriamo il tempo tra le due crisi, per esempio 1992 e 2012 per L’Italia.
Dentro la struttura il problema rimane la produttività del lavoro. Se andiamo a vedere i dati, notiamo che le mansioni per le quali fino a 6-7 anni fa si veniva assunti col diploma, ora invece necessitano la laurea. La questione riguarda più da vicino la struttura e il tessuto produttivo italiano, fatto di micro o piccolissime imprese, che non è funzionale agli investimenti in ricerca e sviluppo, settore in cui si verifica un processo di sottocapitalizzazione e non si muovono grandi investimenti.
Il dibattito è enorme, rispetto a chi dovrebbe essere a fare investimenti strutturali, ovvero il pubblico o il privato. Preferirei personalmente che fosse un’intelligenza collettiva, e non il mercato, che poi è finanziarizzato, a decidere in quali settori farlo, sia in termini di rendimenti sociali o privati, sia in termini di investimento e di assunzioni. Il privato in Italia infatti — data la conformazione della struttura e del tessuto produttivo — sia dal punto di vista della dimensione che delle capitalizzazioni, non è in grado di investire.
I laureati oggi fanno esattamente quello che facevano i diplomati dieci anni fa. Guadagnano un po’ di più, nel caso in cui abbiano un contratto a tempo indeterminato, perché i contratti collettivi nazionali mal che vada sono ad ogni modo migliori, ma il vero problema è che in Italia dopo 6 anni — nel 40% dei casi — un laureato diventa un para-subordinato, e quindi un lavoratore senza tutele, oppure passa alla disoccupazione. Studiare serve, ma non garantisce più nessuna forma di stabilità.
Rispetto alla composizione sociale del mercato del lavoro, la retorica è che oggi i laureati non sono più a rischio, fanno cioè parte effettivamente di quella classe media stabile al di fuori del rischio e della vulnerabilità economica, ma in realtà sono altrettanto vulnerabili, anche se ci sono da fare delle accurate distinzioni all’interno della macrocategoria. Quello che ci dicono i dati forniti da Michele Raitano è che la disuguaglianza nel mercato del lavoro può essere spiegata tramite le disuguaglianze tra titoli di studio diversi, cioè secondo premi per laureati, ma anche all’interno della stessa fascia di istruzione (1). Se guardiamo queste due componenti, si vede che la diseguaglianza tra titoli di studio diversi, tra il 1991 e il 2015, è rimasta costante, spiegando solo un 5% dei casi di diseguaglianza nel mercato del lavoro. Il problema allora risiede all’interno del processo di differenziazione degli stessi titoli di studio: cioè dove si ha studiato, da dove si proviene, che tipo di relazioni si ha. Questi fattori vengono definiti non misurabili, ma se astraiamo il fenomeno da questa metodologia imposta e lo guardiamo in termini di classe, il dato appare eloquente.
C’è la differenza fra sud e nord, molto diversi in termini di posizioni sociali, ma anche al nord i fattori da considerare sono molteplici: chi sei, quanti libri avevi a casa, cosa ti hanno fatto studiare, quale università hai frequentato. È vero che non abbiamo la piramide delle università come per esempio nel sistema francese, ma nella realtà dei fatti questo esiste: la Bocconi sarà sempre valutata più positivamente dell’università di Camerino.
Il problema è insito nel sistema universitario — e non dal 2012 quando sono cominciati i tagli all’università. Dal 2012, con tutta la retorica dell’individualismo, dell’autonomia e della meritocrazia, ciò che si sta facendo in termini di diseguaglianza e di rapporto al mercato del lavoro è rendere l’università molto più elitaria. C’è il numero chiuso, aumentano i costi dell’università, aumentano i costi della vita delle città dove fisicamente sono, ma probabilmente si apre qualche sbocco in più rispetto a chi non ha nessuna laurea, anche se oggi non risulta essere un grande vantaggio; il fatto è che sempre meno famiglie possono permetterselo.
Un’ultima cosa: ci dobbiamo porre davvero la questione di cosa studiamo e perché. La funzionalità al lavoro gratuito non penso che serva nemmeno in termini di coscienza: dire no al lavoro gratuito a 16 anni è un diritto e lo dobbiamo riconoscere. Chi però può rifiutare questo schema è esattamente chi si può permettere di rimanere disoccupato, ma non tutti gli altri, cioè quelli su cui l’ASL si abbatte molto più ferocemente: dovranno farlo obbligatoriamente per molto più tempo e si abitueranno al livello disciplinare che ciò comporta.
Se fino a 20 anni fa esistevano degli spazi di dibattito e di dialettica interna, oggi tutto questo non esiste.
Quindi la chiusura dell’università dentro un unico schema teorico è un boomerang che poi ci governa e si riproduce: è una scuola di ceto che riproduce il ceto. Oltre a questi due grandi problemi, c’è poi il grande problema del mercato del lavoro.
Di Marta Fana
Ricercatrice in economia presso l’istituto di studi politici di Sciences Po a Parigi
Note
(1) Franzini, Murizio, e Michele Raitano. 2012. Differenziali salariali e capitale umano: alcune evidenze in cerca di spiegazione. Scaricabile da http://www.siecon.org/online/wp-content/uploads/2012/08/Franzini-Raitano1.pdf



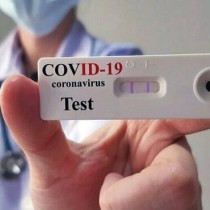






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!