Giustizia e giustizieri. Il caso del Ministro dell’interno

Il 5 ottobre 2011, Angelo Peveri, sorprende un ladro, Dorel Jucan, a rubare gasolio da un escavatore presente in uno dei suoi cantieri e lo mette in fuga; tuttavia, il “fuggiasco” torna indietro per recuperare il mezzo con cui era giunto sul luogo e, lì, viene bloccato dall’imprenditore e da un suo dipendente; cosa avviene in quei momenti è ben descritto nella sentenza pronunciata pochi giorni fa dalla Corte di cassazione che conferma la condanna Peveri a quattro anni e sei mesi di reclusione per tentato omicidio: «la vittima, palesemente non armata, dopo essere stata bloccata a terra, è stata ripetutamente percossa, anche con un corpo contundente, nonostante le insistenti e supplichevoli manifestazioni di pentimento, ed è stata colpita da distanza ravvicinata, con un fucile caricato con proiettili ad elevata capacità offensiva, al torace». Quello sparo causa a Jucan – che patteggia, per il tentato furto, 10 mesi di reclusione – una percentuale di invalidità del 55 per cento. Questi i fatti.
La difesa dell’imprenditore, negli otto anni di processo, non ha mai invocato la legittima difesa. Semplicemente perché, nel caso di specie, non di difesa si è trattato. Lo ha fatto, invece, sabato il Ministro dell’interno, Matteo Salvini, recandosi nel carcere di Piacenza a far visita all’uomo: erigendosi lui stesso a giudice, portavoce delle istanze del “popolo” (che ha formulato, attraverso i social, un quarto grado di giudizio), lo ha assolto, invocando la concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica – potere che, peraltro, spetta a quest’ultimo in “collaborazione” con il Ministro della giustizia e non con quello dell’interno – e delegittimando quella magistratura che, lei sì, in nome del popolo e del suo essere soggetta “soltanto alla legge”, ha accertato oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza di Peveri.
È una vicenda, questa, che, in un momento in cui è in discussione alla Camera un progetto di legge volto a riformare l’istituto della legittima difesa, impone alcune riflessioni.
In primo luogo, Matteo Salvini (e come lui, altri), invocando sicurezza e paura quali cause giustificatrici di ogni azione privata, spinge ogni volta un po’ più in là quel confine che consente di qualificare la difesa, da parte del singolo, come “legittima”, manipolandone il suo significato più proprio.
In una sorta di paradosso, proprio il soggetto deputato, nel nostro ordinamento, alla tutela dell’ordine pubblico, deresponsabilizza lo Stato, ammettendo (la presunta) incapacità di quest’ultimo di assolvere alla sua funzione originaria. Ogni ordinamento giuridico nasce, infatti, per assicurare ordine e protezione ai consociati; il monopolio della forza in capo all’autorità statale (nei limiti inderogabili fissati dalla legge) è l’unica risposta possibile al quesito hobbesiano di come superare l’insicurezza della guerra di tutti contro tutti propria dello stato di natura. È, pertanto, allo Stato e solo allo Stato che è affidata la difesa (nel senso più lato) dei consociati dalle aggressioni che possono subire. In questo contesto, l’autotutela privata ha una ragion d’essere esclusivamente laddove l’intervento dell’ordinamento si ponga, nel caso concreto, come impossibile: solo in quel caso, il singolo, ingiustamente aggredito, potrà difendersi. Il tutto, con un’azione che, però, è e deve rimanere sottoposta a precisi vincoli; nel nostro Stato, infatti, non può trovare spazio l’idea per cui l’atto privato possa assolvere a una funzione punitiva. Men che meno, può trovare spazio la legittimazione di forme di vendetta privata, quale si è configurata nel caso di Peveri.
La reazione a un’aggressione, quindi, opera solo nei limiti in cui la prima, in un contesto di attualità del pericolo e alla luce di circostanze la cui sussistenza deve essere valutata dalla magistratura, sia proporzionata alla seconda. Tutto ciò è messo in forte dubbio dalla riforma in discussione in Parlamento: essa legittima lo Stato ad arretrare dallo svolgimento di funzioni sue proprie, delegandole ai privati; depotenzia il ruolo dei tribunali, che rischiano di essere trasformati in organi preposti solo a ratificare l’azione di chi abbia reagito a un’offesa, reale o presunta, sulla base della sola prova di una ragionevole (e percepita) paura, a prescindere dalla proporzionalità della risposta; subordina il diritto alla vita – in funzione della cui tutela lo Stato si origina – alla protezione incondizionata del domicilio; sovverte la gerarchia dei valori tutelati dalla Costituzione e da tutte le Carte dei diritti internazionali, prime tra tutte la Convenzione europea dei diritti dell’uomo; riduce la persona e la sua dignità a un bilanciamento con il valore commerciale di altri beni.
Così la sicurezza non è più un bene comune (condizione, questa, essenziale per evitare arbitrii), ma diventa la somma di singole forme di giustizia privata che portano con sé l’insofferenza per il limite. Proprio quel concetto di limite che un Ministro dell’interno e Vice presidente del Consiglio è chiamato a far proprio e a ribadire, in un’ottica di convivenza pacifica tra consociati e sulla base del principio per cui qualunque azione umana deve essere valutata, nella irriducibile complessità dei fatti della vita, alla luce del principio personalistico che fonda la Costituzione repubblicana.
Non è, però, solo questo aspetto a interessare nella vicenda dell’imprenditore piacentino. Matteo Salvini, nell’invocare, in veste istituzionale, la legittima difesa in un caso in cui essa è stata inequivocabilmente esclusa dalla magistratura nel corso di tre gradi di giudizio (senza entrare, invero, mai nel processo), non solo sembra avallare il principio per cui la percezione di pericolo da parte del singolo e la narrazione che questi ne fornisce debba rappresentare l’unico inappellabile metro di giudizio applicabile e da cui può dipendere la vita o la morte di un ladro (tale o presunto che sia); non solo riesce nel gioco di fare apparire il problema della legittima difesa (importante in via di principio, ma quantitativamente modesto nei fatti, come risulta dai dati Censis del 2018) come cardinale per il contrasto alla criminalità; ma, nel farlo, delegittima l’opera di un altro potere, la magistratura, a cui, sola e in piena indipendenza, spettano le decisioni in merito alle modalità e alla durata di una pena detentiva. Opera, Salvini, quale esponente del potere esecutivo, un’invasione di campo nei confronti di quello giudiziario con il dichiarato scopo (coerente con il progetto di riforma in discussione) di marginalizzare la giurisdizione, dipinta, ormai, come insensibile al bisogno di protezione dei cittadini.
Ciò rappresenta un evidente pericolo: mettere in discussione che il processo sia l’unico luogo deputato alla ricerca delle prove e alla ricostruzione dei fatti (l’unico “strumento” attraverso cui si può pervenire all’accertamento delle responsabilità personali, garantendo, al tempo stesso, tanto i diritti degli accusati, quanto quelli delle persone offese) significa rendere più fragile il nostro stesso ordine giuridico. Significa mettere potenzialmente a rischio i diritti di tutti noi. Certamente, più di un ladro che si intrufola in casa nostra.
Francesca Paruzzo
26/02/2019 https://volerelaluna.it





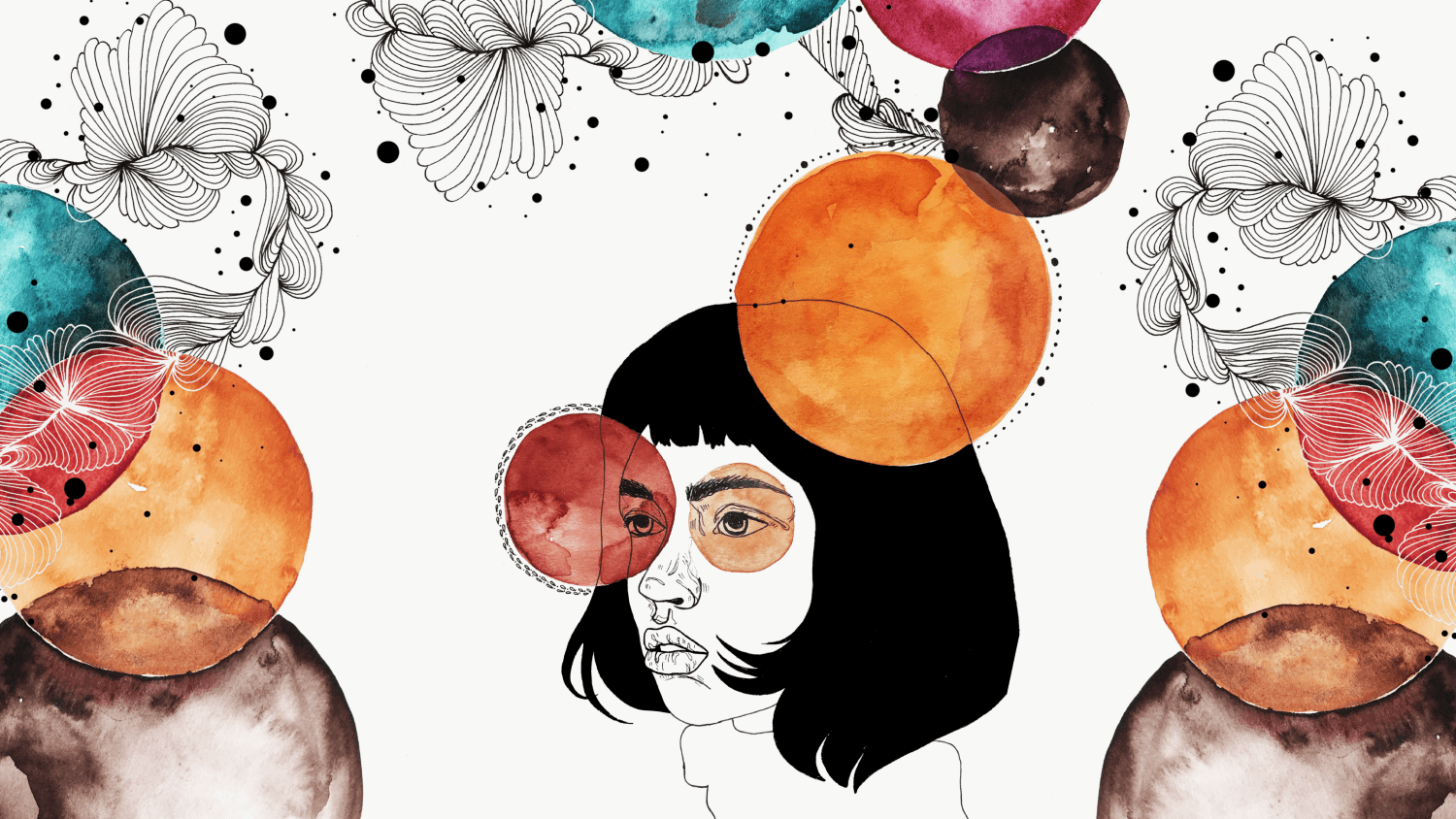




Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!