Il sindacato alla prova dello smart working
La remotizzazione del lavoro, complessivamente intesa nelle forme di lavoro agile (legge 81/2017), telelavoro o terze modalità ibride, è diventata una modalità organizzativa comune acquistando significati nuovi e imprevisti. Pensato prima della pandemia, il lavoro agile era uno strumento dedicato ai lavoratori dipendenti con mansioni a progetto/obiettivo, non legati a un turno fisso, allo scopo dichiarato di favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.
In effetti molti lavoratori compatibili con questo identikit lo bramavano, e le aziende lo concedevano tramite un accordo individuale. I vantaggi di una pattuizione di questo tipo, con potere negoziale totalmente sbilanciato verso il datore di lavoro, sono stati per i lavoratori interessati comunque maggiori di qualsiasi ipotetico contenuto collettivo. Questo ha fortemente limitato l’influenza del sindacato in merito, e gli accordi collettivi di lavoro agile sono stati rari e hanno aggiunto poco alle garanzie minime di legge. I venerdì o lunedì di smart working sono diventati in alcuni casi un gettone premiale per consentire a lavoratori altamente professionalizzati di iniziare prima o finire con più calma il weekend: a poco più di questo si è ridotta la conciliazione vita-lavoro promossa dalle legge 81/2017 – non a caso definito il «Jobs Act del lavoro autonomo». Il telelavoro invece non è regolamentato da una legge, è oggetto di linee guida della Confederazione Sindacale Europea (2002) recepite dai sindacati confederali italiani (2004), è delineato in alcuni contratti collettivi e dedicato a lavoratori la cui prestazione è definita in termini per lo più quantitativi, su turni rigidi e da postazione fissa.
Terze modalità ibride, cioè fuori sia dal perimetro della legge 81/2017 che da quello dei contratti collettivi, sono tutte le remotizzazioni emergenziali comandate o incentivate dai vari decreti di emergenza nel corso del 2020. Oggi non stiamo assistendo a un boom del lavoro agile o del telelavoro, ma a una proliferazione quasi incontrollata di un ibrido. Il fuggi fuggi generale da potenziali focolai di Covid-19 ha spinto le aziende ad abbracciare, più o meno entusiasticamente, le opportunità offerte dalla digitalizzazione, chiudendo le sedi e chiudendo a casa i lavoratori, di fatto delegando a questi ultimi la responsabilità dei costi di gestione e della predisposizione dell’ambiente di lavoro. I comitati azienda-Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) previsti dal protocollo del 14 marzo 2020 sottoscritto da sindacati e datori di lavoro, ove istituiti, sono stati un luogo di informativa aziendale agli Rls, non certo uno spazio di discussione. Anche le aziende più timide, che prima temevano la lontananza dei propri dipendenti, hanno scoperto che la produttività rimaneva invariata o addirittura aumentava, e il distanziamento delle risorse umane è diventato un piacevole obbligo, felicemente deregolamentato. A ciò i sindacati hanno risposto con un certo «senso di responsabilità», rimandando la discussione sulle nuove condizioni di lavoro e accettando come emergenziali, transitorie, provvisorie le policies aziendali ormai in atto da diversi mesi.
Il timore è che questa flemma nasconda una mancanza di visione e la preoccupazione è resa più forte dall’assenza della voce di chi avrà la vita stravolta da questo cambiamento, ovvero dal soggetto più debole: le lavoratrici e i lavoratori.
Eppure di fronte a questa strana congiuntura storica datori di lavoro e sindacati, governo e cittadini tutti dovrebbero avere un obiettivo comune, tutelando interessi diversi: trasformare modelli produttivi e organizzativi obsoleti, estremamente energivori e «cronovori», utilizzando le nuove tecnologie per lavorare meno, lavorare meglio, con più salario, e con ricadute benefiche sotto l’aspetto ambientale, sociale e politico.Non tutti gli attori sono silenti: le aziende fanno il loro mestiere, e stanno sfruttando la remotizzazione del lavoro per ottimizzare i profitti oltre che per lavorare in sicurezza. Ma quale dovrebbe essere il ruolo del sindacato, della politica, della società civile?
Decentramento produttivo solidale e sostenibile
Le modalità ibride con cui milioni di persone già lavorano dovrebbero essere affrontate come nuovo campo di studio. Tuttavia, pur non essendo ancora note tutte le implicazioni che la remotizzazione comporterà a lungo termine, il sindacato dovrebbe cominciare col negoziare garantendo e ripensando due principi: la solidarietà(il Dna sindacale, che dovrebbe escludere la contrattazione individuale, l’unilateralismo aziendale, le discriminazioni), la sostenibilità(quella ambientale, che da vessillo agitato inseguendo le mobilitazioni dei giovani deve essere finalmente tradotta nella pratica).
La solidarietà nella remotizzazione è il principio che deve permette a chi non può lavorare da casa (per situazioni familiari, ambientali o altro), di lavorare in altre sedi, compresa la sede originaria. Volontarietà, rotazione, definizione della priorità di accesso alla remotizzazione devono essere criteri definiti nelle assemblee e negoziati con le aziende per tradurli in termini concreti; il sindacato non deve rinunciare all’idea, del tutto rivendicabile, di lasciare in capo al lavoratore la scelta di quanto, quando e se lavorare da remoto, garantendo l’invarianza della produttività. La volontarietà del lavoratore non deve essere quella (fittizia) di accettare o meno l’offerta di remotizzazione prevista per lui dall’azienda, bensì quella di decidere o meno se adottare questa modalità secondo le regole concordate collettivamente con l’azienda o nel settore. La remotizzazione non può essere una prigione domiciliare, in cui il tempo di lavoro divora il tempo libero, esattamente come l’azienda-fabbrica non ha potuto più essere l’istituzione totalitaria novecentesca che regolava la vita del lavoratore, dalle colonie per la prole al dopolavoro per i pensionati.
Nel sindacato è viva una certa mitologia della fabbrica come luogo di socialità, come ambiente da democratizzare, come scuola politica, come elemento unificante di classe. Queste connotazioni non sono superate – nonostante il perdurante riflusso successivo a lontane stagioni di lotte – ma devono essere rilanciate e oggi devono rivestire spazi nuovi, perché sarebbero del tutto svuotate di senso se rimanessero nei confini fisici delle aziende e delle fabbriche.
I lavoratori remotizzati non minano la loro unità se come sindacato creeremo le condizioni per un’unità che finalmente superi appartenenze aziendali (brodo di coltura del sindacalismo giallo o pseudo autonomo, peraltro). Il lavoratore remotizzato non deve essere un «lavoratore sparso», ma non è chiudendolo nella sua azienda in un mondo fatto di appalti, subappalti, delocalizzazioni e esternalizzazioni che lo renderemo meno solo. Una «confederalità decentrata e diffusa», che unisca i lavoratori di aziende diverse, e addirittura categorie diverse, nei nuovi luoghi dove svolgono il loro lavoro può (deve) dare protagonismo al lavoratore, anche in vertenze territoriali, sociali, ambientali, di genere.
Le camere del lavoro periferiche dovrebbero assumere un nuovo ruolo, aprire le porte e diventare il luogo di condivisione delle problematiche del lavoro. I lavoratori saranno remotizzati nel proprio domicilio o in spazi comuni di co-working promossi anche – perché no? – dal sindacato stesso, in cui il lavoratore lavorerà continuativamente o saltuariamente, secondo le proprie esigenze di vita. Le istituzioni devono essere nel processo, investendo le risorse pubbliche europee destinate alla salvaguardia del Lavoro (Sure) e coinvolgendo i risparmi che questo processo frutta alle grosse aziende. Locali pubblici o privati, eventuali sedi periferiche chiuse dalle grosse aziende a rete (Tim, ecc.) permetteranno di riportare un «lavoro plurale» in aree che ancora soffrono di emigrazione interna. Le montagne, le campagne e le aree depresse, grazie al lavoro decentrato, devono dare lo stimolo per la cablatura in fibra di zone di cui beneficeranno anche le utenze private. Le «aree a fallimento di mercato» poste oltre al digital divide possono diventare nodi sparsi in cui si ricompone la dimensione collettiva del lavoro ma anche quella sociale dei piccoli centri abitativi. In quei nodi serve il sindacato, in un rapporto con i lavoratori e col territorio più diretto di quello di oggi. Questo decentramento, domiciliare o «condiviso», sporadico, parziale o totale, non deve in ogni caso impedire incontri fisici con la parte datoriale, anzi i «rientri» in sede devono far parte della contrattazione collettiva.
L’immobilismo di governi preoccupati da scelte impopolari e quello di capitali impegnati nel green washing rappresentano un problema per tutti gli esseri umani, sempre più pervasi da senso di impotenza di fronte all’accelerazione del cambiamento climatico e all’avverarsi dell’ecocidio. Ma gli esseri umani sono spesso lavoratori, e la dimensione del lavoro accomuna le centinaia di milioni di lavoratrici e lavoratori che vivono in paesi dove la sindacalizzazione è possibile e può sedere al tavolo con i governi e le controparti datoriali. Questi lavoratori hanno la facoltà e la responsabilità, attraverso un’immane presa di coscienza del proprio ruolo, di dire la loro sulla sostenibilità di ciò che producono e sulla lotta alla distruzione del pianeta. I lavoratori sono la grande maggioranza dei cittadini e dei consumatori. Dovrebbe bastare questa autocoscienza collettiva per osservare sotto una luce diversa i benefici del decentramento e della ricomposizione del lavoro.
La sostenibilità deve essere oggetto di rivendicazione dei consumatori-cittadini-lavoratori, in un tavolo in cui i lavoratori negoziano la diminuzione delle emissioni anche a parziale svantaggio dei profitti aziendali; non nella misura in cui il mercato giudicherà tale negoziazione sostenibile economicamente, ma nella misura in cui loro e i loro figli potranno giudicare la propria vita sostenibile ambientalmente. Davanti a questa impostazione la prevedibile contrapposizione aziendale non sarà strumentale, verso pretesi «privilegi» dalle lavoratrici e dai lavoratori, ma verso il benessere collettivo, e come tale dovrà essere denunciata, combattuta e vinta. Il sindacato non è ancora entrato in questa logica.
Salute e salario
L’obiettivo della costruzione di un decentramento solidale e sostenibile in luogo dell’atomizzazione deregolamentata, non deve ostacolare gli obiettivi che nell’immediato il sindacato dovrebbe rivendicare negli accordi di queste settimane: salario e salute. La tutela del salario e della salute sono un’eredità di decenni di lotte, di contrattazioni e di leggi a cui è inammissibile derogare con un accordo di secondo livello sullo smart working. Obiettivo primo da mettere sul tavolo come premessa fin dall’insorgere della pandemia avrebbero dovuto essere la difesa del potere d’acquisto dei salari e il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza sul luogo del lavoro.
Il salarionon deve diminuire, deve aumentare. L’annoso problema dei working poors ha un’occasione senza precedenti per essere affrontata in maniera radicale. Va rifiutata la logica aziendale secondo cui a fronte di un risparmio del lavoratore nei trasporti possa corrispondere, ad esempio, la mancata corresponsione del ticket restaurant o dell’indennità di mensa. Non è l’azienda che paghiamo quando andiamo a lavorare con mezzi pubblici o privati e non c’è un loro mancato guadagno da compensare. Nell’immediato il salario complessivo al netto delle spese legate alla prestazione di lavoro deve rimanere almeno invariato. La remotizzazione permette razionalizzazioni di sedi, chiusure temporanee e parziali di reparti, crea un risparmio che deve essere condiviso con i lavoratori, che dovranno ricreare altrove le condizioni di lavoro legali (in termini di ergonomicità, microclima, ecc.) che le aziende, sperabilmente, avevano predisposto adempiendo alla legge 81/2008. In alternativa le aziende dovranno farsi carico della messa a norma, delle utenze e delle strumentazioni anche utilizzando gli sgravi previsti per il cosiddetto welfare aziendale – che in questo caso, non sostituendosi al salario, sarebbe sindacalmente accettabile.
La salute e il salario complessivo devono essere garantiti anche qualora il lavoratore non possa o non voglia destinare il proprio domicilio al lavoro, nei quali casi l’azienda dovrebbe farsi carico di affittare postazioni di co-working o naturalmente permettere al lavoratore di lavorare nella vecchia sede, ridimensionata, ottimizzata e messa in sicurezza. Bisognerà inserire principi di calcolo salariale nella contrattazione aziendale o in leggi e protocolli che le parti sociali devono promuovere, per evitare il dumping di aziende nuove o non sindacalizzate che, soprattutto in settori labour intensive, potrebbero comprimere ancora di più il costo del lavoro delegando le spese di gestione al lavoratore.
Un esempio concreto: Tim
Nel settore delle telecomunicazioni, architrave dell’intera digitalizzazione e presupposto stesso della remotizzazione di tutti gli altri settori produttivi, le categorie competenti di Cgil, Cisl, e Uil hanno sottoscritto il 30 luglio 2020 un protocollo con l’associazione datoriale Asstel in cui è assente la progettualità – che infatti non è stata discussa con i lavoratori. Finora non è stato promosso un dibattito sui temi immani che la remotizzazione sconvolgerà, cosa che si sarebbe dovuta fare già all’indomani del lockdown.
Nonostante ciò già il 4 agosto è stato firmato con l’azienda più grande del settore un primo accordo sullo smart working. L’analisi dell’accordo di Tim nella prospettiva delle rivendicazioni di solidarietà, sostenibilità, salario e salute evidenzia quanto i suoi contenuti siano difensivi (quando non inefficaci) invece di essere propositivi e rivendicativi. Pare un errore di impostazione chiamare l’oggetto dell’accordo «smart working», perché si autorizza l’accordo individuale previsto dalla legge 81/2017, e la volontarietà del lavoratore è ridotta solo alla possibilità di rifiuto totale del lavoro agile qualora giornate e orari non soddisfino le esigenze di vita del lavoratore. L’unilateralità aziendale è controbilanciata, dal punto di vista del salario, della corresponsione del ticket restaurant anche per le giornate svolte in smart working, e da uno sconto del 30% su una promozione di Tim per la connettività domiciliare. A conti fatti, quindi, chi lavorerà da casa non avrà risparmi sui trasporti se non sull’utilizzo di mezzi privati nei soli giorni in cui gli verrà assegnato lo smart work (chi utilizza i mezzi pubblici invece l’abbonamento lo dovrà comunque pagare). Le utenze domestiche saranno a carico dei lavoratori, così come la responsabilità e il costo di mantenere una postazione adeguata sotto il profilo igienico, microclimatico, ergonomico ecc. L’accordo prevede anche una fase «transitoria» legata allo stato di emergenza, in cui il lavoratore continuerà a utilizzare strumentazioni proprie (computer, sedia ecc.) in attesa di passare – nel 2021 – alla fase «provvisoria», in cui Tim gradualmente fornirà gli strumenti aziendali. La fase provvisoria terminerà alla fine del 2021. Un ipotetico accordo «definitivo», quindi, non vedrà la luce prima di un anno abbondante, il che rende meno comprensibile l’urgenza dell’accordo del 4 agosto che sostanzialmente è una proroga «attutita» dell’emergenza.
In estrema sintesi, quello di Tim è un accordo che non tocca i temi della solidarietà e della sostenibilità della remotizzazione, e deroga in peius sui temi del salario e della salute in attesa di un «accordo definitivo». Ma al di là del contenuto concreto, che comunque presenta i miglioramenti legati al ticket restaurant e allo sconto sulla connessione, è l’impianto che appare fuori da una visione generale (che in effetti non c’è): impostazione inadeguata (incasellamento della remotizzazione nella definizione di «smart working») e prospettiva debole (accordi sottoscritti nell’assenza di elaborazione programmatica).
Un accordo aziendale non può certo definire una visione intercategoriale. Tuttavia, non possiamo limitarci a parare i colpi della controparte in un terreno inesplorato sia per noi che per loro. L’isolamento dei lavoratori che tanto temiamo non deve impedirci di vedere il rischio di «isolamento sindacale» di chi si siede al tavolo con le aziende. I sindacati devono essere portatori di diritti universali e divenire lo strumento collettivo dei protagonisti della società civile organizzata: le persone.
Luca Barbuto
Delegato Rsu Vodafone e funzionario Slc-Cgil di Bologna.
3/9/2020 https://jacobinitalia.it







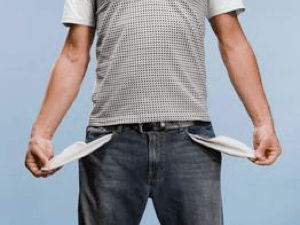


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!