Perché le morti sul lavoro per amianto restano senza giustizia

“Cercavamo giustizia ma abbiamo trovato la legge che difende i potenti. Il processo sui morti per amianto alla Breda Termomeccanica-Ansaldo ha avuto un esito non diverso da quello che negli ultimi anni abbiamo visto nel Tribunale di Milano”. Michele Michelino, ex operaio della Breda e portavoce del Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro, sintetizza così la sentenza della quinta sezione della Corte d’Appello di Milano che a gennaio ha assolto i manager dell’azienda dall’accusa di non avere tutelato i lavoratori. Il processo ha riguardato la morte di 12 operai esposti all’amianto nello stabilimento milanese di Viale Sarca tra gli anni Settanta e il 1985 per cui il sostituto procuratore generale Nicola Balice aveva chiesto condanne tra i due e i quattro anni.
La Corte ha anche condannato le parti civili ricorrenti, tra cui lo stesso Comitato, al pagamento delle spese processuali. “Il messaggio alla base è chiaro: non fatelo più. Ma noi non ci fermiamo e il Comitato andrà avanti a chiedere giustizia per tutti i colleghi morti sul lavoro. Solo nel 2020 hanno perso la vita altri cinque ex operai della Breda per malattie riconducibili all’amianto”, prosegue Michelino. “Purtroppo questo è solo l’ultimo processo sui lavoratori uccisi dalle fibre di asbesto che si è concluso con le assoluzioni. Prima ci sono stati l’Alfa Romeo di Arese, la Pirelli di viale Sarca e viale Ripamonti, e la centrale Enel di Turbigo”. Le motivazioni della sentenza sulla Breda si leggeranno tra 90 giorni “e poi il Comitato farà ricorso in Cassazione”. Nella sentenza di assoluzione di primo grado, quella che l’accusa sperava venisse ribaltata, il giudice aveva scritto che non esiste una “legge scientifica” che possa descrivere l’ipotesi, sostenuta invece dall’accusa, di “un nesso di causalità tra una determinata condotta ascrivibile a un imputato e la malattia insorta in un preciso lavoratore, successivamente deceduto”.
Milano rappresenta un caso emblematico per le scelte dei tribunali che, rispetto ad altre zone, hanno emesso sentenze di assoluzione per le imprese e i loro dirigenti. Nel 2019 i giudici della Corte d’Appello di Milano hanno assolto gli ex vertici ed ex manager di Fiat, Alfa Romeo e Alfa, imputati per la morte di 15 operai deceduti per forme tumorali provocate dall’esposizione all’amianto dopo avere lavorato negli stabilimenti dell’Alfa Romeo di Arese (MI). La Procura generale di Milano aveva chiesto condanne tra i cinque e gli otto anni di reclusione per omicidio colposo perché, secondo l’accusa, nel periodo al centro delle indagini, tra gli anni Settanta e gli anni Novanta, non avevano adottato le necessarie misure di prevenzione per proteggere i lavoratori dal rischio di amianto. Ma per il Tribunale non era stato possibile accertare se l’asbesto, nel periodo in questione, avesse causato o contribuito a causare i decessi per tumore polmonare e mesotelioma pleurico (tumore che si sviluppa sul mesotelio, la membrana che riveste la parte interna del torace, addome e cuore. È provocato dall’esposizione all’amianto e la sua latenza media oscilla tra i 15 e i 50 anni, ndr) dei lavoratori.
Nel 2017 a Milano i sette ex manager degli stabilimenti Pirelli in Viale Sarca e Via Ripamonti, imputati per la morte di 28 operai, sono stati assolti fino in Cassazione. È rimasto senza responsabili nel 2015 anche il processo per la morte di otto operai della centrale termoelettrica Enel di Turbigo (MI), colpiti da mesotelioma pleurico provocato, secondo l’accusa, dalle polveri di amianto respirate nello stabilimento tra gli anni Settanta e Ottanta. I quattro ex dirigenti Enel ed ex responsabili delle centrale, imputati per omicidio colposo, erano stati assolti dal Tribunale di Milano per non aver commesso il fatto.
“Il caso Breda ha avuto una sentenza simile a tutte quelle emesse dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello sui processi che riguardano le morti per amianto. Purtroppo è un andamento che si ripete da molti anni e che ora si osserva con più frequenza anche nella sezione quarta della Corte di Cassazione”, spiega l’avvocata Laura Mara che nel processo Breda ha assistito le parti civili Medicina Democratica, l’Associazione italiana esposti amianto (Aiea) e il Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro. “Si assiste sempre più spesso a scelte e sentenze non costituzionalmente orientate”, prosegue Mara che è anche legale delle stesse parti civili nel processo per la morte per amianto di nove lavoratori del Teatro La Scala di Milano.
Uno dei punti centrali che orienta le sentenze sono le teorie scientifiche di riferimento -presentate dall’accusa e dalla difesa e accolte o meno dai giudici- che riguardano il nesso di casualità tra l’insorgere della malattia, in particolare del mesotelioma, e la condotta dell’imputato, quindi dell’azienda. Nelle aule del tribunale la difesa sostiene il modello della “trigger dose” o “dose killer” secondo la quale il tumore può essere indotto anche da dosi di esposizione all’amianto molto basse, anche da una sola fibra di asbesto, e che, una volta innescata la patologia, le successive esposizioni sono prive di rilevanza sullo sviluppo della malattia. Questo modello, secondo i consulenti della difesa, impedirebbe di stabilire se l’amianto presente nell’impresa abbia causato la patologia perché la vittima avrebbe potuto inalarlo in qualunque altro luogo della sua vita professionale o al di fuori del lavoro. Non si potrebbe quindi affermare che la predisposizione delle misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro avrebbero impedito l’insorgere della patologia.
“Questa tesi, purtroppo accolta nelle ultime sentenze milanesi confermate anche dalla Cassazione, non considera il parere condiviso dalla comunità scientifica sul modello multistadio della cangerogenesi”, spiega Mara. Ovvero gli studi e le ricerche internazionali, come quelle condotte dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), che hanno mostrato che il processo di formazione del cancro è un’evoluzione a più stadi e la sua progressione è favorita dalle successive esposizioni al fattore cancerogeno: quindi l’aumento delle dose di amianto inalata (dove la dose dipende dalla durata e dall’intensità dell’esposizione che a sua volta dipende dalla concentrazione di fibre nell’aria) è in grado di accorciare la latenza della malattia e di aggravarla.
“Oggi la magistratura impone che venga data la prova del momento esatto in cui la cellula da benigna diventa maligna e anche la prova della fine del periodo multistadiale per potere imputare la responsabilità a uno specifico dirigente che in quel momento gestiva la società. Questa prova non può essere fornita e il processo di trasformazione della cellula, come accade per qualsiasi altra formazione tumorale, non può essere misurato con strumenti fenomenici”, prosegue l’avvocata. “Se si accogliesse questa interpretazione sorgerebbero questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 589 del codice penale (omicidio colposo, ndr) in rapporto all’articolo 3 della Costituzione. Vorrebbe cioè dire che il reato di omicidio colposo per violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro non coprirebbe le patologie legate all’amianto creando un vuoto nel sistema del diritto penale e violando il diritto all’uguaglianza sancito dalla Costituzione”.
“Noi andiamo avanti e prima o poi dovrà adeguarsi anche la giurisprudenza. Non escludiamo di ricorrere alla Corte europea per i diritti umani”, dice Mara. “Sembra essere uno strumento necessario visti gli esiti in Italia anche degli altri processi per i morti sul lavoro. Pensiamo alla sentenza su Viareggio, sul disastro ferroviario in cui hanno perso la vita 32 persone. Ci ha lasciato senza parole”. A gennaio la quarta sezionale penale della Cassazione ha fatto cadere l’aggravante relativa alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e quindi il reato di omicidio colposo, contestato agli imputati, è stato dichiarato prescritto. Il processo di appello bis riguarda solamente il capo di imputazione relativo al disastro colposo. Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato (Fs) e di Rete ferroviaria italiana (Rfi), è stato condannato in appello a sette anni, e Michele Mario Elia, ex amministratore delegato di Rfi, è stato condannato in secondo grado a sei anni.
“Si tratta di una sentenza molto grave per l’annullamento del risarcimento per le associazioni e i sindacati. In questi anni si sono costituiti come parte civile e sono stati condannati a pagare le spese processuali”, spiega Riccardo Antonini, ex ferroviere di Fs e membro dei comitati delle famiglie delle vittime. “È una sentenza politica. Noi continueremo con la nostra battaglia per avere giustizia”.
Marta Facchini


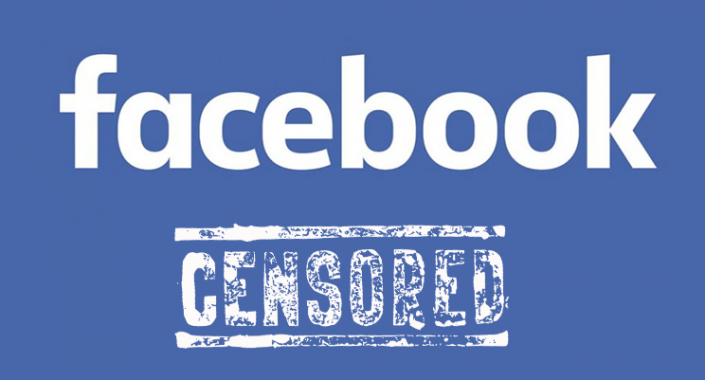







Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!