La politica nel plutocene
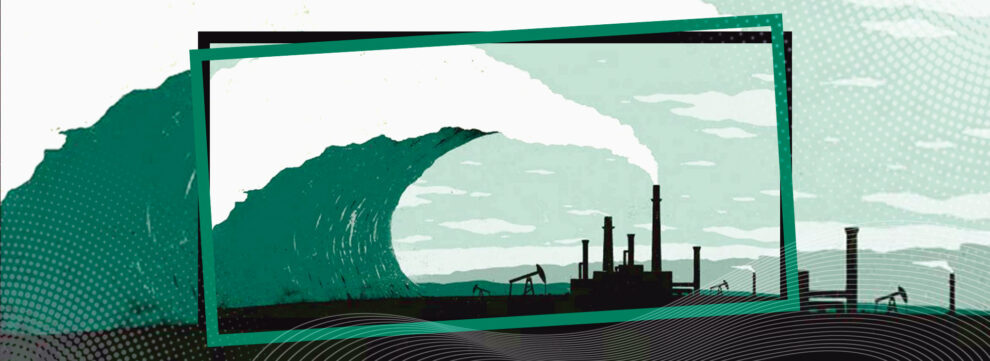
La crisi climatica viene spesso presentata come un problema meramente tecnologico senza alcuna connessione al sistema capitalistico e alle crescenti disuguaglianze economiche che esso comporta. Tuttavia un numero crescente di studi rivela come la ricchezza sia la variabile più direttamente correlata all’impronta ecologica di un individuo. Non importa quanto sensibili alle tematiche ambientali i ricchi siano, in generale i dati dimostrano che chi ha molti soldi finisce quasi inevitabilmente per spenderne una parte considerevole e appesantire la propria impronta ecologica. Per tale ragione alcuni ricercatori hanno chiamato «plutocene» l’epoca geologica in cui ci troviamo a indicare che la crisi ecologica è trainata dagli alti livelli di consumo di una minoranza di ricchi.
A oggi nell’Unione europea il 10% più ricco emette la stessa quantità di CO₂ emessa dal 50% più povero. Se invece di guardare ai livelli di emissioni aggregati guardiamo all’impronta di carbonio pro capite per classe sociale, ci rendiamo meglio conto della sperequazione esistente: l’impronta media pro capite dell’1% più ricco equivale a 55 tonnellate di CO₂ all’anno mentre quella del 50% più povero vale 5 tonnellate, ossia meno di un decimo. Ma ancora più preoccupante è che fra il 1990 e il 2015 nell’Ue le disuguaglianze in termini di CO₂ sono aumentate: l’impronta di carbonio pro capite media del 50% più povero è diminuita del 32%, quella del 10% più ricco è diminuita solo del 10%, mentre quella dell’1% più ricco è addirittura aumentata del 7%.
I ricchi hanno un’elevata impronta di carbonio a causa degli alti livelli di consumo, in particolare di energia elettrica e carburante. In tutti i paesi per i quali esistono studi, il 10% più ricco della popolazione consuma in media circa 20 volte più energia di quella consumata dal 10% più povero. Una sperequazione provocata principalmente dai trasporti: i ricchi viaggiano abitualmente in aereo (sia di linea che privati), possiedono barche a motore e auto di grossa cilindrata. L’uso frequente dell’aereo è l’indicatore più consistente di agiatezza: il 41% dell’impronta di carbonio dell’1% più ricco è dovuta ai viaggi aerei. Di fatto, nel 2018, il 50% di tutte le emissioni del settore aereo civile è riconducibile ai voli effettuati dall’1% della popolazione mondiale più ricca. I ricchi hanno quindi un’elevata impronta di carbonio principalmente a causa della loro «iper-mobilità».
Oltre che attraverso i consumi di lusso, i ricchi contribuiscono al degrado del pianeta attraverso gli investimenti. Una ricerca condotta dal settimanale The Economist rivela che l’84% di tutta la CO₂ emessa a livello mondiale è dovuta a produzione e consumo di beni riconducibili a 220 multinazionali, per lo più possedute da una manciata di fondi di investimento. I ricchi partecipano ai profitti dei grandi complessi multinazionali sia in forma diretta, tramite il possesso dei loro titoli azionari, sia in forma indiretta tramite la partecipazione a fondi di investimento che a loro volta comprano titoli azionari dei complessi industriali. Seguendo questa linea di ragionamento, il ricercatore Dario Kenner è arrivato a delineare una vera e propria «polluter élite», una casta formata da grandi investitori e dirigenti di aziende che non solo sostiene l’economia fossile, ma definisce i connotati dell’intera società per il potere che ha di determinare le scelte di consumo dell’intera popolazione. Sia decidendo cosa e come produrre, sia facendo pressione sui decisori politici affinché adottino politiche industriali e infrastrutturali favorevoli ai loro interessi.
Tale visione dei processi decisionali nell’economia è antitetica a quella denominata «sovranità del consumatore» che identifica in quest’ultimo il soggetto economico che determina il come e il cosa deve essere prodotto nelle nostre società. La verità è che non è tanto la domanda che influenza l’offerta, quanto la concentrazione dei mezzi di produzione che determina la domanda. Per questo la responsabilità dell’inquinamento è da caricare sulle spalle di chi restringe l’offerta influenzando i consumi, piuttosto che sui cittadini che finiscono per subire le decisioni della «polluter élite» che detiene i mezzi di produzione. Prendiamo come esempio la mobilità. L’esigenza di muoversi è avvertita da tutti come irrinunciabile, ma il modo per soddisfarla è vario: bici, auto privata a motore, autobus a idrogeno, treno elettrico. Una scelta o l’altra non è indifferente perché ognuna produce conseguenze sociali e ambientali dagli effetti contrapposti. Ciò nonostante la forma adottata nelle nostre società non è stata il frutto di una discussione pubblica, ma di un’imposizione del sistema produttivo dominante.
In Italia, ad esempio, abbiamo avuto uno sviluppo esagerato del trasporto privato su gomma, con tutto quello che ne consegue sul piano dello spreco di risorse, inquinamento atmosferico, consumo di suolo. Responsabilità da attribuire in parte alla classe politica, che è stata accondiscendente, ma soprattutto alla famiglia Agnelli, gran burattinaio dell’industria dei trasporti in Italia. Per cui se volessimo determinare l’impronta ecologica della famiglia Agnelli, non dovremmo concentrarci solo sui suoi consumi finali (certamente superiori a quelli della grande maggioranza degli italiani), ma su tutte le conseguenze determinate a livello di sistema dalle scelte industriali di Fiat prima e Fca dopo. Ad esempio se Fca avesse cominciato a investire in ricerca sui veicoli elettrici già anni fa, oggi sarebbero disponibili auto elettriche a prezzi abbordabili, permettendo a molti di noi di acquistarne una, con enormi vantaggi per l’ambiente in virtù della riduzione di anidride carbonica.
Per impedire che il riscaldamento globale superi di 1,5°C i livelli preindustriali, l’Ipcc raccomanda che entro il 2030 le emissioni medie pro capite non eccedano 2,5 tonnellate l’anno. Al momento nell’Ue il 10% più ricco ha in media un’impronta pro capite di carbonio 10 volte superiore all’obiettivo di riduzione indicato. Mentre l’1% più ricco ha un’impronta 22 volte superiore. Quanto al 50% più povero, mediamente la sua impronta pro capite è solo doppia rispetto all’obiettivo da raggiungere. E tuttavia le statistiche dicono che il 5% della popolazione dell’Ue ha già un’impronta pari a quella indicata dall’IPCC. Dunque servono politiche di riduzione diversificate per classe sociale. Nel caso dei redditi alti l’obiettivo è ridurre i consumi in senso lato, mentre nel caso delle categorie più povere l’obiettivo è aiutare le famiglie a consumare meglio, e se necessario di più, affinché possano condurre una vita dignitosa pur mantenendo la propria impronta entro limiti di sostenibilità.
Nel valutare quali misure assumere per porre un freno alle emissioni di anidride carbonica, occorre considerare che nella nostra società c’è chi può decidere come vivere e chi invece lo deve subire. Chi si trova in povertà non può scegliere se vivere in centro o in periferia, se mangiare biologico o cibo spazzatura, se avere la casa coibentata o ad alta dispersione termica. Deve semplicemente adottare lo stile di vita meno dispendioso. Che non è automaticamente il meno impattante. Molti poveri, ad esempio, sono costretti a vivere in periferia dove gli affitti sono generalmente più bassi. Ma contemporaneamente mancano di servizi essenziali (scuole, negozi, presidi medici) e di trasporti pubblici. Di conseguenza l’auto si rende indispensabile con inevitabile aumento dell’impronta di carbonio. Ed arriviamo all’assurdo che al di sotto di certi livelli di reddito, l’impronta ambientale non è determinata dalla ricchezza, ma dal livello di povertà che non lascia possibilità di scelta come invece hanno i facoltosi.
Se sei così ricco da poterti permettere un’automobile di alta cilindrata, allora sei anche sufficientemente ricco da poterti permettere una vita senza automobile. I soldi ti permettono di scegliere il tuo stile di vita, e se finisci per condurne uno ad alto impatto ambientale, ne sei responsabile. Non altrettanto per i più poveri la cui mancanza di libertà annulla anche la responsabilità per le conseguenze che la propria vita arreca all’ambiente. E a dimostrazione di come per i più poveri non esista una diretta correlazione fra impronta di carbonio e responsabilità, c’è che molti di loro hanno chiaro che investire in incrementi di efficienza per la propria casa, per i propri elettrodomestici e per la propria vettura può fare la differenza. Molti sanno che a parità di consumi, una famiglia che vive in una casa ben coibentata e utilizza elettrodomestici e veicoli ad alta efficienza energetica può arrivare a produrre fino a tre volte meno emissioni climalteranti rispetto a una famiglia costretta a utilizzare beni a bassa efficienza. Ma pur sapendolo non investono in innovazione perché non hanno i soldi per farlo.
Le proteste dei gilet jaunes vanno lette in questa prospettiva. Vogliono dirci che le misure fiscali per ridurre il consumo di benzina e di elettricità si trasformano in misure contro i poveri se non sono accompagnate da maggiori servizi e da adeguati contributi alle ristrutturazioni. Vogliono anche dirci che vanno inventate nuove forme di rilevamento dell’impronta di carbonio affinché si possa distinguere fra «emissioni di sussistenza», che pur risultando alte a causa delle distorsioni sociali sono comunque connesse ai bisogni essenziali, ed «emissioni di lusso», dovute invece ai bisogni superflui. In base alla loro incidenza sarà possibile capire quanto colpire con la leva fiscale e quanto intervenire con la spesa pubblica in modo da trasformare la sostenibilità in un percorso a vantaggio di tutti e non in un affare per ricchi a detrimento dei poveri.
È sempre più evidente che per ridurre la nostra impronta di carbonio, dobbiamo rivedere in profondità cosa e come produciamo oltre a cosa e come consumiamo. La lista dei cambiamenti da introdurre è sicuramente molto lunga e comprende un diverso modo di produrre energia elettrica, il ridimensionamento e la riformulazione della nostra mobilità, nuovi assetti produttivi improntati all’economia circolare, eliminazione dei consumi superflui, un nuovo modo di costruire le nostre case, riduzione e riciclo dei rifiuti. Cambiamenti possibili solo con un radicale ripensamento, non solo della nostra impostazione culturale, della nostra organizzazione economica, della nostra tecnologia, ma anche della nostra politica fiscale e della spesa pubblica. Rispetto a questi ultimi due aspetti, le grandi parole d’ordine devono essere: tassazione dei prodotti inquinanti con misure compensative per i più poveri, potenziamento dei servizi pubblici, tassazione dei ricchi. Tre percorsi che devono procedere di pari passo per impedire che la sostenibilità si trasformi in un castigo per i più poveri.
Focalizzandoci sulla spesa pubblica, già da vari decenni i movimenti popolari hanno ottenuto che lo stato si faccia carico del così detto welfare, l’organizzazione di servizi essenziali finalizzati a proteggere tutti i cittadini contro i «rischi sociali» come ignoranza, malattie, povertà, vecchiaia. L’impegno dello Stato per la sicurezza sociale, l’istruzione universale, i servizi sanitari e altro ancora, ha contraddistinto le democrazie occidentali a partire dal dopoguerra. Ma nel ventunesimo secolo la sfida è coniugare la «questione sociale» con la nascente «questione ambientale» perché fragilità sociale ed esposizione ai rischi climatici si influenzano a vicenda. Le famiglie a basso reddito hanno maggiori probabilità di vivere in aree a elevato rischio di dissesto idrogeologico o in quartieri con bassa qualità dell’acqua e dell’aria. I poveri corrono maggiori rischi sanitari anche perché sono meno attrezzati di fronte ai picchi di calore e di freddo. E in caso di disastro ambientale subiscono maggiori disagi perché non hanno i soldi per riparare i danni e mettersi in sicurezza. Il che dimostra che la gravità dei disastri naturali non è misurabile solo con criteri di carattere ambientale, ma è direttamente proporzionale al grado di fragilità sociale in cui avvengono.
Parimenti le conseguenze sociali sono inversamente proporzionali alla risposta che la collettività è capace di dare. Nell’estate 2018 si ebbe un’anomala ondata di calore che fece divampare incendi boschivi in tutta Europa. Fra i paesi colpiti ci furono anche Svezia e Grecia, che però ebbero esiti molto diversi in termini di vite umane. Mentre in Svezia non ci fu neanche un morto, in Grecia le vittime superarono il centinaio, anche a causa di un generale indebolimento di tutti i servizi pubblici, compreso quello dei vigili del fuoco, della protezione civile, delle ambulanze e degli ospedali, come risultato dell’austerità imposta dall’Unione europea. E alla fine chi fu il vero omicida: la natura o l’austerità? La collettività è di fondamentale importanza non solo per ridurre le sofferenze dovute a situazioni naturali avverse, ma anche per ridurre il nostro impatto sulla natura e quindi per prevenire le avversità.
È dimostrato, ad esempio, che i più poveri hanno spesso impronte di carbonio sproporzionate rispetto al loro tenore di vita a causa delle inefficienze dovute alla mancanza dei servizi pubblici nel proprio territorio o per l’impossibilità di effettuare investimenti di miglioramento termico ed elettrico alle proprie abitazioni. Per cui una sana politica di abbattimento dell’anidride carbonica passa anche attraverso l’elargizione di contributi per la ristrutturazione edilizia a favore di tutte le famiglie al di sotto di certi redditi, attraverso il rafforzamento del trasporto pubblico affinché tutte le periferie siano ben raccordate con i principali centri urbani, attraverso la garanzia, anche nei luoghi più remoti, di tutti i servizi essenziali: scuole, negozi, ambulatori medici, pronto soccorso, biblioteche e connessione internet. La dimostrazione di come i problemi ambientali si risolvono con scelte sociali.
Riccardo Mastini è ricercatore in ecologia politica presso l’Università Autonoma di Barcellona.
28/10/2021 https://jacobinitalia.it

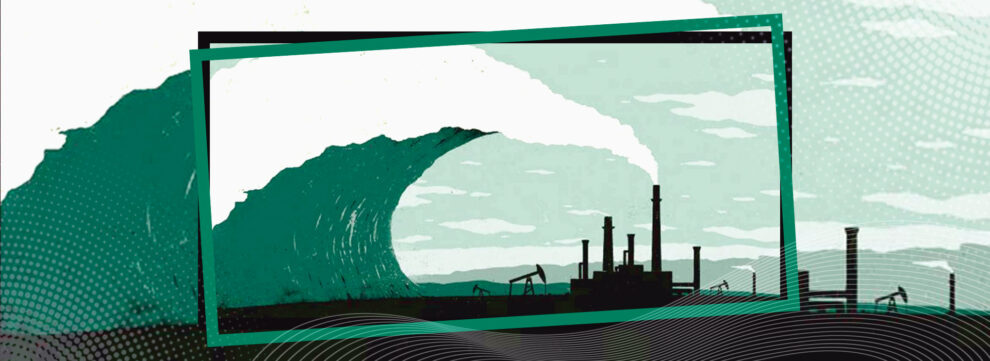








Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!