Note sulla borghesia italiana
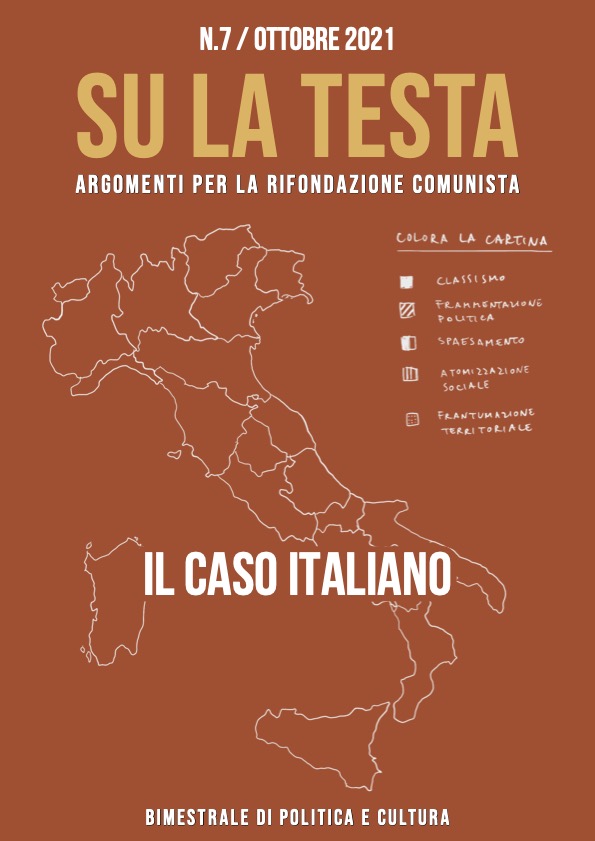
Scrivere in modo esauriente della borghesia italiana ci sembrerebbe un impegno troppo vasto per poter essere esaurito in queste poche pagine; abbiamo scelto quindi, nell’ambito comunque di un approccio storico, di mettere l’accento solo su alcuni aspetti tra i più significativi del tema.
Bisogna a questo punto premettere che abbiamo certo presente come il borghese non sia soltanto il capitalista e che tale figura, per altro verso, non si possa, per alcuni aspetti, limitare alla sfera economica, implicando essa, come sottolineato da molti, anche un mondo di valori, di mentalità, di abitudini sociali (Cafagna, 1991). Tra l’altro, si parla comunemente anche di una borghesia intellettuale.
Il termine appare comunque difficile da definire in senso preciso e risulta per molti aspetti piuttosto ostico delimitare i suoi confini. Non ci inoltreremo quindi in questioni definitorie piuttosto complicate; dati gli spazi ridotti di questo testo, faremo comunque riferimento in particolare alle figure degli imprenditori, dei grandi professionisti, dei livelli elevati del pubblico impiego.
La nascita della borghesia
Come è noto, è stato il grande studioso francese Fernard Braudel a mettere in rilievo come il capitalismo e la borghesia, due fenomeni comunque inseparabili, siano sostanzialmente nati ed abbiano compiuto i loro primi passi in Italia. È in particolare dai secoli XII e XIII in poi che in alcune località del Nord del paese, da Firenze a Venezia, a Genova, a Milano, si sviluppa una classe di mercanti e banchieri dalle più varie origini sociali. Ma non mancherà anche qualche elemento protoindustriale; si pensi soltanto ai forse 60.000 addetti del tessile a Firenze e dintorni o alle migliaia di operai che facevano funzionare l’Arsenale di Venezia, mentre Milano si avvicinava a un certo punto, secondo qualche studioso, a quella che avrebbe potuto essere una vera e propria rivoluzione industriale.
Le città italiane sono al centro dei traffici commerciali e finanziari che si svolgono in Europa e nel Mediterraneo, in collegamento con l’Asia e la via della seta.
La borghesia si sviluppa rompendo lentamente, ma progressivamente, i tradizionali equilibri di una società aristocratico-agraria, di cui pure ambirà sempre di far parte, e questa sarà la prima tappa di un lungo percorso di crescita che vedrà al centro dei suoi sviluppi ulteriori, di seguito, l’Olanda, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti.
I borghesi, pur essendo una parte esigua della popolazione, occupano totalmente la politica. Certo, a Firenze apparentemente i Medici se ne tengono lontani, ma quando ci sono le elezioni alle cariche pubbliche vengono sempre e misteriosamente scelti degli uomini della loro cerchia. I borghesi spingono tra l’altro la politica tributaria a loro vantaggio, mentre controllano la giustizia.
La borghesia mostra comunque anche delle rilevanti divisioni sulla linea politica di gestione degli affari. Guardiamo a Venezia e Genova. Le due città sono gestite totalmente dai ricchi. Ma nella prima (la sua ricchezza, a un certo punto, è superiore a quella di tutta la Francia) si ha una certa attenzione al bene comune; così vengono impediti i monopoli nei vari settori dell’economia e viene bloccato il potere economico troppo spinto di una sola famiglia. A Genova invece non ci sono regole e i ricchi governano nel loro solo e stretto interesse.
Ma la borghesia italiana mostra comunque in nuce anche gran parte di quei caratteri negativi che caratterizzeranno in seguito quella di tutti i paesi occidentali. Essa sfrutta senza pietà i piccoli artigiani e i lavoratori dipendenti. Oltre a combattersi in lotte intestine, veneziani e genovesi inventano inoltre una sorta di “colonialismo precoce”, come lo definirà una storica francese, Catherine Otten-Froux; essi occupano militarmente delle isole dell’Adriatico e del Mediterraneo Orientale e le sfruttano economicamente in maniera spietata, tanto che quando arriveranno i turchi essi saranno accolti come liberatori dalle popolazioni. Non si scherza anche con i problemi ambientali: i 60.000 operai tessili delle manifatture fiorentine inquinano con le lavorazioni della lana l’Arno.
Bisogna anche ricordare la spietata repressione, sempre a Firenze, della rivolta dei Ciompi del 1378. A tali moti parteciparono soprattutto i dipendenti dell’arte della lana; essi chiedevano il diritto di associazione e la partecipazione alla vita pubblica. Anche in questo le vicende italiane del periodo anticipano questioni molto più moderne.
È anche in Italia che si sviluppa il primo di quei “tradimenti della borghesia” che gli storici hanno delineato nel corso dei secoli. Con il tempo la funzione di rottura degli equilibri tradizionali lascia il passo da noi ad un’integrazione sempre più spinta e regressiva con le vecchie classi aristocratiche, i legami con la quale non si erano mai peraltro rotti del tutto, mentre nel Nord Europa c’era indubbiamente più distacco dagli elementi agrari (Cafagna, 1991). Il punto di riferimento, di gravitazione dell’assetto sociale, e il riferimento fondamentale dei processi di ascesa sociale si trova in effetti da noi nel periodo nella condizione nobiliare. L’aspirazione della borghesia a entrare nei ranghi della nobiltà diventa preponderante.
Poi verrà la crisi. Con la scoperta dell’America i traffici più importanti si spostano nell’Atlantico, mentre l’avanzata dei turchi che, tra l’altro, conquistano Costantinopoli, renderà alla lunga più difficoltosi quelli con l’Oriente, e sulle rotte marittime sempre dell’Oriente avanzano inoltre portoghesi e spagnoli, mentre poi sarà la volta degli olandesi e degli inglesi, che peraltro erano già penetrati nel Mediterraneo.
Intanto crolla anche il mercato dei beni di lusso su cui si basava in gran parte la prosperità delle città della penisola. Essi perdono il loro peso politico anche in parallelo al fatto che le potenze straniere si interessano ormai in maniera pesante al paese. Così verso il 1620 i banchieri genovesi, che avevano controllato per molti decenni i circuiti finanziari europei, offrono ormai denaro in prestito all’1% di tasso di interesse, ma nessuno lo vuole.
Da allora si compie la sostanziale crisi dell’economia del nostro paese e della borghesia con essa; crisi che durerà alcuni secoli, e al momento dell’Unità d’Italia se ne troveranno ormai poche tracce.
Dopo l’Unità d’Italia
Nel secolo della borghesia e del capitalismo trionfanti in Occidente, l’Ottocento, l’Italia resta per molti aspetti al traino degli altri paesi. Il quadro economico e sociale al momento dell’Unità era molto arretrato, se facciamo in particolare il confronto con paesi come la Francia e la Gran Bretagna, che avevano tra l’altro creato uno stato nazionale molto prima; il reddito nazionale era pari a meno di un terzo di quello francese e a un quarto di quello inglese. Eravamo di fronte ad un’economia eminentemente agricolo-commerciale ripiegata per la gran parte su se stessa; il settore agricolo produceva nel 1861 ancora il 58% del Pil totale, la manifattura il 20%, i servizi il 22%.
Lo sviluppo industriale avviene dopo l’Unità in maniera tardiva e lenta e questo sia per la mancanza di un mercato interno consistente che per i ridotti sbocchi sui mercati esteri, per l’orizzonte ristretto degli imprenditori, le difficoltà delle comunicazioni, la carenza di risorse naturali, la scarsa accumulazione di capitali, la concorrenza dei paesi più avanzati, le difficoltà di un’agricoltura arretrata, per ragioni orografiche, in gran parte del paese.
Anche il sistema bancario era molto poco sviluppato, mancavano i capitali e il costo del denaro era molto alto. Solo l’esposizione nazionale di Milano del 1881 mostra dei segni che lasciano intravedere un netto miglioramento della situazione, mentre la svolta decisiva per il decollo dell’economia fu il periodo 1899-1915, in parallelo in qualche modo sul piano politico con l’”età giolittiana”.
Non si può forse dire per il nostro Paese quello che la maggior parte degli studiosi raccontano della Francia dei primi decenni dell’Ottocento (1830-1848, periodo della monarchia orleanista), secondo cui essa era stata governata come una società per azioni da una ristretta oligarchia, ma comunque il nuovo Stato unitario, dopo i primi quindici anni in cui si occupa soprattutto a dotare il Paese di una adeguata struttura amministrativa, incoraggia poi comunque lo sviluppo di un’economia borghese e capitalistica.
Tra l’altro, si registra l’eliminazione delle barriere doganali interne, che peraltro distruggono gran parte della debole industria del Sud, men- tre viene avanti la costruzione delle rete ferroviaria, con il contributo del capitale estero, per unificare il paese dal punto di vista economico. D’altro canto, molte delle più significative nuove imprese che sorgono otterranno commesse e altre facilitazioni dal nuovo Stato, e quindi acquisiranno almeno in parte sin dall’inizio un carattere parassitario.
Sul piano politico si afferma dall’inizio una rivoluzione conservatrice dall’alto, un liberalismo moderato, con l’alleanza tra i ceti industriali e la nobiltà agraria, con permanenti residui feudali (ci risiamo); un possibile sviluppo alternativo, più moderno, che può essere rappresentato ad esempio da una figura come quella di Carlo Cattaneo, non riuscirà ad emergere. Ma nella sostanza, nonostante un certo sviluppo economico, certo meno spettacolare e più lento di quello degli altri grandi paesi europei, l’Italia non ha conosciuto una vera rivoluzione borghese; e questo per certi vizi originari: dal dualismo economico allo scarso spirito civico originario, alla carenza di senso dello Stato. Pesano fortemente tra l’altro i retaggi del passato, i municipalismi derivanti dalla forte tradizione delle città, l’ostilità della Chiesa.
Certo, l’Italia non ha avuto un cantore della sua borghesia degli affari e del denaro, sia pure in negativo, come è stato a suo tempo Thorstein Veblen per quella americana, alla cerniera tra il XIX e il XX secolo, con la sua opera Teoria della classe agiata, ma purtuttavia per quanto riguarda il ruolo della nostra borghesia tra il 1861 e l’avvento del fascismo ricordiamo in estrema sintesi le conclusioni cui è giunto Alberto Mario Banti nella sua opera pluricitata (Banti, 1996).
Intanto l’autore sottolinea come “dagli anni sessanta-settanta dell’Ottocento e sino alla fine del secolo, il termine borghesia sarà caricato di valenze semantiche negative, espressivo di rapacità economica e sociale, di corruzione politica, di opportunismo”.
Sul fronte dell’analisi più da vicino l’autore parla in sostanza di un nuovo tradimento della borghesia per il periodo. Localismo, clientelismo, particolarismi sembrano essere stati i tratti fondamentali dei suoi comportamenti, accanto ad una mancanza sostanziale di visione complessiva. Banti parla di una borghesia frantumata, di solo un vertiginoso caleidoscopio di appartenenze territoriali, socio-professionali, ideologiche, politiche. Mancano i grandi progetti in grado di convogliare le energie del paese verso mete ambiziose.
Sarà tale situazione che porterà in maniera facile e rapido la stessa borghesia nelle braccia del fascismo, come nel secondo dopoguerra in quelle della DC.
Il secondo dopoguerra
Nel secondo dopoguerra, l’economia italiana, dopo qualche problema iniziale, mostra per alcuni decenni una forte crescita. Ancora negli anni sessanta il tasso medio di aumento del Pil reale era superiore al 7%; poi scenderà al di sotto del 4% nel decennio successivo e negli anni ottanta diminuirà ancora, collocandosi intorno al 2,5%. Comunque tra il 1950 e il 1973 il Pil per abitante crescerà del 5,3% all’anno, la produzione industriale dell’8,2%, la produttività del lavoro del 6,2%.
Poteva essere finalmente la volta buona per un rinnovamento dell’economia e della società, ma i vecchi vizi della borghesia italiana si presentano puntuali all’appuntamento.
Non mancherà certo qualche iniziativa da parte di una frazione almeno della borghesia in ascesa per contribuire a far fare un salto in avanti al paese. Sono da registrare, a questo proposito, i tentativi economici, sociali, politici, di alcuni imprenditori e di alcuni grandi manager pubblici, da Leopoldo Pirelli, a Adriano Olivetti, a Oscar Sinigallia con l’Italsider, a Enrico Mattei con l’Eni, agli stessi Agnelli e a Felice Ippolito con il nucleare (progetto criticabile su altri piani).
Ma tale tentativo fallirà presto, tra l’altro, per la carenza di una strategia complessiva, per il mancato sostegno della politica, per i limiti del ruolo dell’Italia nella divisione internazionale del lavoro, per l’assenza di un retroterra ancheculturale adeguato nel paese.
Più tardi, un tentativo minore portato avanti dagli stessi Agnelli, da De Benedetti, da Gardini per avviare almeno un rilevante processo di espansione internazionale, soprattutto in Europa, fallirà presto anch’esso. Il punto finale di tali tentativi sarà collocato con la politica delle privatizzazioni.
Oggi la situazione non appare certo brillante; l’economia è ferma da una ventina di anni, mentre nei settori di punta l’Italia arranca insieme all’intera Unione Europea, di cui rappresenta comunque uno dei vagoni di coda, di fronte invece all’avanzare di Usa e Cina. Alcuni mali atavici del nostro paese sono sempre presenti, dalla grande criminalità, alla corruzione, al divario Nord-Sud, alla rilevante disoccupazione e alla forte presenza di lavoro irregolare e sommerso, alla mancanza di grandi imprese che raccolgano le sfide della nostra epoca ed ad una ridotta internazionalizzazione.
Interi pezzi del nostro sistema industriale sono stati ceduti al capitale straniero senza che si registrasse peraltro una qualche reciprocità. I ricchi preferiscono portare i capitali all’estero piuttosto che investire all’estero dall’Italia.
Simbolo rilevante di questa fase appare la famiglia Agnelli, che prima trasferisce all’estero il gruppo Fiat, poi lo cede ai francesi. Sempre sul piano dei simboli, si può far riferimento ai Riva che, mentre portano clandestinamente i profitti dell’Ilva all’estero, inquinano Taranto, o ancora ai Benetton con i casi di Autostrade.
Su di un altro piano, in Italia, come in altri paesi occidentali, si rende evidente, negli ultimi decenni, la crescente frattura tra le due borghesie, quella economica e quella intellettuale da una parte e le classi popolari dall’altra, come afferma tra l’altro in un’intervista Louis Maurin, direttore dell’Osservatorio francese sulle diseguaglianze, con le conseguenze politiche ben note.
In tale quadro, per avere un’idea degli atteggiamenti recenti della grande borghesia, segnaliamo una ricerca svolta da Giulio Marcon, nell’ambito di un progetto sulle diseguaglianze portato avanti alla Scuola Normale di Pisa (Marcon, 2021).
In tale ricerca vengono tra l’altro presentati dall’autore i principali elementi emersi dalle interviste a 22 persone ricche del nostro paese. La prima conclusione che emerge è quella che i ricchi italiani si presentano in prevalenza come sicuri del proprio valore professionale e del rilievo dei risultati che giustificano la ricchezza da loro accumulata. Per altro verso, la maggior parte di essi non si sente in qualche modo artefice delle trasformazioni del capitalismo nazionale, capaci di influenzarne gli esiti; essi si rappresentano invece come persone con la capacità di cogliere le occasioni offerte dalla corrente dei processi globali.
Il secondo punto che viene fuori riguarda una netta prevalenza del punto di vista individuale, della propria esperienza personale, come chiave di lettura dei problemi più generali del capitalismo italiano. Raramente gli intervistati si percepiscono come parte integrante della classe imprenditoriale del paese. Manca inoltre una visione di sistema, condivisa, da parte dell’élite economica del paese per quanto riguarda il capitalismo nazionale ed internazionale.
Il terzo punto importante riguarda il rapporto problematico delle persone intervistate con lo Stato e con la politica, un rapporto di apparente estraneità, anche se almeno alcuni hanno persino fatto parte a suo tempo di qualche governo. Lo Stato viene soprattutto visto come una minaccia, in particolare si teme il fisco, mentre si lamenta l’inefficienza delle strutture pubbliche. In sintesi, alla fine, quello che emerge, sottolinea Marcon, è una sorta di dissociazione degli intervistati dalle responsabilità di classe diri- gente. Dalla Genova del Medioevo a oggi le cose non sembrano molto cambiate. Come sottolineava un grande storico italiano del recente passato, Ruggero Romano, in Italia il morto afferra sempre il vivo.
Dalle interviste si configura in effetti una classe dirigente inadeguata al suo ruolo, concentrata nella contemplazione del proprio particulare e con scarsissima voglia di farsi carico responsabilmente dei problemi del paese.
Per altro verso, il giudizio di Giuseppe De Rita sul tema della borghesia italiana contemporanea non è meno impietoso, quando afferma che essa da noi, al contrario che negli altri paesi, non c’è, c’è solo un ceto medio; una borghesia per esistere ha bisogno della coscienza di sé e delle sue responsabilità sociali, il ceto medio no, ripiega nell’egoismo. Non c’è circolazione delle élite, non c’è mobilità di ruoli.
L’autore, in una sua opera scritta con Antonio Galdo (De Rita, Galdo, 2011) parla ancora di un capitalismo refrattario a regole ed etica, dalla rinuncia all’impegno nella vita pubblica al dilagare di corporativismo e pulsioni individuali, dallo smarrimento di elementi di equilibrio all’interno di una democrazia compiuta, alla crescita di un’informazione poco indipendente.
Non è così un caso, alla fine, che non si sviluppi da noi una adeguata cultura di impresa; nelle università e nelle scuole di management, anche nelle più prestigiose, al contrario che negli altri importanti paesi europei, si ricopiano il più delle volte i manuali degli autori anglosassoni, mentre non nasce una capacità di elaborazione autonoma, tranne che forse, e non a caso, nel campo dell’organizzazione e della sociologia del lavoro. È difficile elaborare qualcosa sul nulla.
Testi citati nell’articolo
- Banti A. M., Storia della borghesia italiana, L’età liberale (1861-1922), Donzelli, Roma,1996
- Cafagna L., voce Borghesia, Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, 1991
- De Rita G., Galdo A., L’eclissi della borghesia, Laterza, Bari, 2011
- Marcon G., La ricchezza in Italia, rapporto di ricerca, MPRA paper, Scuola Normale Superiore, Pisa, maggio 2021
Vincenzo Comito
Economista. Ha lavorato a lungo nell’industria, nel gruppo Iri, alla Olivetti, nel Movimento Cooperativo. Ha poi esercitato attività di consulente ed ha insegnato finanza aziendale prima alla Luiss di Roma, poi all’Università di Urbino. Autore di molti volumi. Collabora a “Il Manifesto” e a www.sbilanciamoci.info.

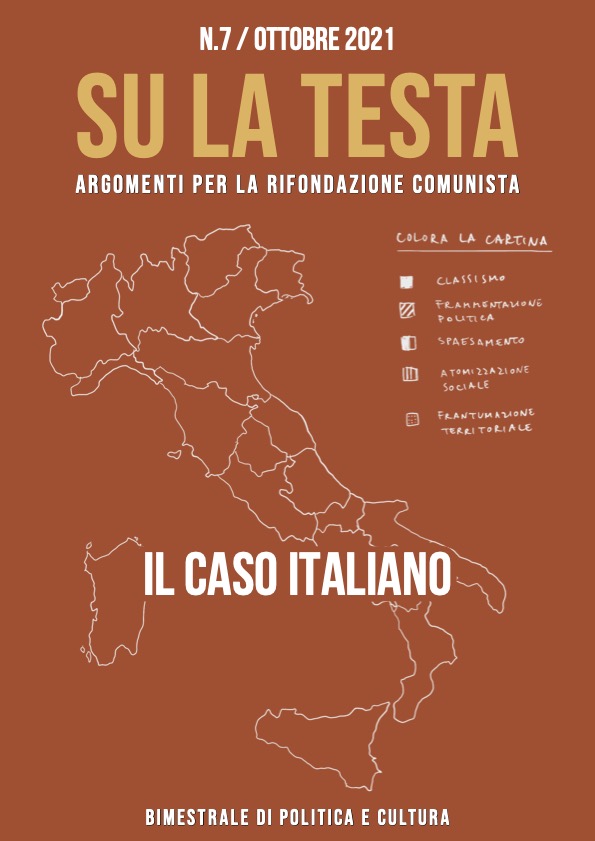








Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!