Vietato parlare di neoliberismo

È solo l’ultima di tante storie simili. Una ricercatrice scrive su una testata online un articolo sulle proteste in Iran in cui usa la parola «neoliberista» per definire le politiche del regime degli ayatollah. Su Twitter si scatena l’inferno: centinaia di account attaccano lei, la rivista e la sua tesi, per aver osato usare quella parola. Come se i regimi autoritari non avessero una politica economica. La stampa di area salta sopra alla storia, e Carlo Calenda ci mette la ciliegina insultando pubblicamente la ricercatrice. Una storia di ordinaria follia social in un paese in cui il dibattito pubblico sulle questioni economiche è ostaggio di tabù e paletti che risulterebbero incomprensibili e fuori tempo in tutto il resto dell’Occidente. Dietro questa storia ci sono i meccanismi perversi del circuito mediatico-social che sta portando i liberali italiani ad assumere linguaggi, stili e comportamenti trumpiani. Ma se la leghiamo alla canea che ha accolto l’uso del termine «neoliberismo» nel percorso congressuale del Partito demodratico, questa storia ci dice qualcosa di più: quella parola deve restare un tabù perché, per il pensiero dominante, nessuna persona e nessun movimento di massa può essere influenzato da istanze socioeconomiche, e perché citare il neoliberismo come un’ideologia significa minarne lo status di legge naturale universale che caratterizza le ideologie dominanti, e indicare quindi la possibilità di immaginare e creare altri mondi possibili.
Calenda, Twitter, e la Fox News all’italiana
La storia inizia qualche giorno fa. La protagonista, suo malgrado, è Stella Morgana, ricercatrice italiana che lavora all’Università di Liverpool con una borsa post-dottorato della British Academy e che da anni si occupa di lavoro e movimento dei lavoratori in Iran, con ricerche sul campo e pubblicazioni. Giovedì 8 dicembre Morgana pubblica sull’edizione online della rivista Il Mulino un articolo intitolato Iran, la rivoluzione dei lavoratori, il cui sommario recita «Precari e divisi da anni di politiche di stampo neoliberista e repressione, i lavoratori iraniani hanno iniziato alcuni scioperi locali in solidarietà con le proteste. Ma uno sciopero di massa è ancora lontano».
La tesi dell’autrice si può riassumere facilmente: la mobilitazione di lavoratori e lavoratrici a sostegno della battaglia contro il regime degli ayatollah, in Iran, sta crescendo ma è ancora molto frammentata, a causa della repressione del regime e di trent’anni di attacchi ai diritti sul lavoro e all’organizzazione di classe. Si tratta di un’analisi, che si può condividere o meno (chi scrive non conosce né Morgana né le politiche del lavoro iraniane), ma che sicuramente porta alla luce elementi di cui raramente si parla, nel dibattito sulle proteste in Iran, e che è fondata sulla ricerca dell’autrice e di altri colleghi. Non dovrebbe essere la normalità, un dibattito pubblico in cui esperti informati propongono temi e punti di vista a un pubblico libero di farsi la propria opinione? Qual è il problema?
Il problema è che è stato usato, non solo nel testo dell’articolo, ma soprattutto nel sommario e conseguentemente nel tweet con cui l’account social della rivista ha annunciato la pubblicazione, l’aggettivo «neoliberista» per definire le politiche economiche del regime iraniano. Ciò ha scatenato un attacco violentissimo da parte di centinaia di account Twitter legati al mondo ultraliberista italiano, rivolti alla rivista, alla ricercatrice e alla sua tesi. L’idea sottesa a questi attacchi è che, per citarne alcuni, non sia possibile «confondere una teocrazia con una società libera con economia di mercato», si debba essere «pazzi o scemi» per vedere «politiche neoliberiste in Iran», addirittura che in Iran «non ci sia un mercato» (dove gli iraniani e le iraniane scambino beni e servizi sarebbe un mistero), che non possa esistere «il famoso neoliberismo degli ayatollah», e via così, con una serie di insulti e volgarità che è meglio risparmiare a chi ci legge.
Sulla stessa linea, è intervenuto sul Foglio il direttore Claudio Cerasa, ironizzando sui «piccoli genietti del Mulino» (l’anti-intellettualismo non può mancare, nello stile da populismo di destra che caratterizza ormai il liberalismo italiano) e invitando a «non giocare con le parole e chiamare le cose con il loro nome. Si chiama islamismo, non liberismo». Come se le due cose fossero reciprocamente esclusive. Come se i regimi autoritari non avessero una politica economica. Come se fosse folle vedere in un movimento di massa, oltre a una sacrosanta battaglia di libertà, in gran parte femminista (parola così difficile da pronunciare, per i liberalissimi commentatori mainstream italiani), una lotta contro le ingiustizie economiche. Ne ha già parlato sulle nostre pagine qualche giorno fa Paola Rivetti, in un articolo linkato da Morgana sul Mulino e diventato a sua volta una prova d’accusa nei suoi confronti, perché chi cita Jacobin Italia, in quel mondo, non può che avere torto. I regimi autoritari hanno politiche economiche, e in alcuni casi queste sono liberiste: dal Cile di Pinochet a, come abbiamo avuto modo di mostrare con diversi articoli nel numero 16 della nostra rivista, una certa fase del fascismo italiano, gli esempi in questo senso non mancano. Non tutti, non sempre: alcuni, talvolta. E ciò comporta conseguenze. Non si capisce davvero cosa ci sia di scandaloso in questa semplice osservazione di fatto.
Il carico l’ha messo l’onorevole Carlo Calenda, deputato della Repubblica e leader di Azione-Italia Viva, che ha twittato ai suoi oltre 400 mila follower, in riferimento all’articolo in questione: «Una vera idiozia». Calenda non è entrato nel merito, non si conoscono sue ricerche o analisi sull’Iran, non sappiamo davvero che da pulpito e su che basi si sia permesso di definire «idiota» il punto di vista altrui. È tutto da dimostrare, del resto, che abbia letto l’articolo. Il punto era il tweet, che stava girando da ore nella bolla di account ultraliberisti (in buona parte anonimi) che circonda l’ex ministro. È fin troppo facile sottolineare il paradosso di un politico che ha fatto della retorica della competenza e degli esperti uno dei nuclei fondamentali del proprio discorso politico, e poi attacca in mondo becero e senza alcuna argomentazione di merito, basandosi sull’equivalente social dei discorsi da bar, gli esperti competenti che usano una parola che non gli aggrada.
Dell’elitismo tossico della borghesia italiana, del populismo elitario insito nella retorica dei competenti, e della scelta di Calenda di interpretare proprio quel populismo, abbiamo già scritto. Il punto qui è: perché Calenda fa quel tweet? Perché un leader di partito con 2 milioni di voti e 400 mila follower perde tempo ad attaccare una qualsiasi ricercatrice e il tweet da poco più di 200 like che ne annuncia un articolo? Davvero non ha niente di meglio di cui occuparsi? Davvero sente il bisogno di comportarsi come il peggiore dei troll, insultando persone che non conosce e una rivista che, nella storia del centrosinistra italiano a cui in teoria appartiene, qualche ruolo l’ha avuto, come Il Mulino?
L’impressione è che l’agenda del leader di Azione-Italia Viva sia dettata, quando va bene, da Il Foglio, e quando va male dalla bolla degli ultraliberisti di Twitter. Quel tweet, e la tendenza ad attaccarlo con violenza e volgarità, giravano nel suo ambiente, e Calenda o chi per lui si è accodato. Il fenomeno è interessante perché ricorda da vicino quanto accadeva negli Stati uniti negli anni della presidenza Trump, con l’inquilino della Casa Bianca che passava buona parte delle sue giornate seduto sul divano davanti alla tv a guardare il canale conservatore Fox News, per poi twittare compulsivamente sui temi che la bolla mediatica dell’ultradestra gli proponeva. Le posizioni politiche di Calenda, per fortuna, nonostante le convergenze, non sono quelle di Trump, ma il meccanismo che porta un politico a diventare prigioniero di una bolla discorsiva ultra-ideologica, perdendo progressivamente il contatto con la realtà, potrebbe essere più diffuso di quanto si pensi.
Le fratture nel realismo capitalista
Ma il fenomeno va ben oltre Calenda e l’articolo di Morgana. Pochi giorni prima l’identico trattamento era stato attribuito (in maniera più accettabile, trattandosi di dibattito politico) alle voci che esprimevano una peraltro timidissima critica al neoliberismo all’interno del dibattito congressuale del Partito democratico: da Elly Schlein che l’ha citato nel discorso di annuncio della sua candidatura alla segreteria, ad alcuni membri del comitato costituente destinato a riscrivere il manifesto del Pd, che nella prima riunione hanno criticato il testo del 2007 in questo senso. Il coro mediatico-social è stato unanime: parlare di neoliberismo è una sciocchezza.
Quando si approfondisce, le argomentazioni sono diverse: alcuni trovano priva di significato la parola, nonostante la storia intellettuale abbia ampiamente ricostruito il percorso di quel filone di pensiero, come ha efficacemente mostrato Quinn Slobodian; altri sostengono che non abbia senso applicarlo all’Italia, data l’alta spesa pubblica che ancora caratterizza il nostro paese, nonostante la consistente letteratura sull’ondata di privatizzazioni, austerità di bilancio e precarizzazione del lavoro che ci è passata sopra negli ultimi trent’anni; altri negano che esista alcun neoliberismo in Europa, e si tratta di gente che considera Angela Merkel e Mario Draghi dei pericolosi socialisti. E così via. L’impressione è che le argomentazioni possano cambiare di volta in volta, e l’importante sia il tabù del termine. Ma perché al pensiero dominante fa così paura una parola?
Il primo motivo, particolarmente rilevante nel caso delle proteste iraniane, è che va negata l’ipotesi che masse di persone possano essere mosse da istanze di giustizia socioeconomica, o anche solo di miglioramento collettivo delle condizioni di vita, se non di critica dell’economia politica. La visione del mondo che il pensiero dominante ci propone è un mix hollywoodiano di individualismo e idealismo: le persone si possono muovere per il proprio tornaconto personale, all’interno del quadro di compatibilità dato, oppure per grandi ideali di libertà, anche in quel caso ovviamente individuale. Il conflitto non esiste, a meno che abbia il fine di approdare alla società liberale, che è il definitivo e metafisico approdo della storia umana.
Sugli iraniani va proiettato il proprio paradigma, senza tenere conto delle complessità della realtà (realtà che, paradossalmente, a quanto sostiene Morgana, non è particolarmente favorevole alla lotta di classe, in Iran). Come se, spesso, i regimi autoritari non andassero in crisi proprio sul lato della distribuzione della ricchezza. Come se, ad esempio, la Primavera Araba del 2011 non fosse iniziata con il suicidio del venditore ambulante tunisino Mohamed Bouazizi in un contesto di disoccupazione e drammatico aumento dei prezzi del cibo. Come se questioni di classe e genere, libertà e uguaglianza, economia e diritti individuali non si intrecciassero quotidianamente nella vita delle persone. Ma, appunto, il copione è un altro: le rivoluzioni del XXI secolo devono avere obiettivi di emancipazione prettamente individuale (che tra l’altro nessuno, dalle nostre parti, si sogna di contestare e non sostenere), non possono prevedere alcun protagonismo collettivo di lavoratori e lavoratrici (che, lo ricordiamo ancora, l’articolo in questione considera difficile da concretizzare in Iran) e non devono neanche citare l’esistenza di diverse opzioni di politica economica, pur all’interno dello stesso modello capitalista. Si vive e si muore per libertà individuali o, in qualche caso, sotto bandiere nazionali. Ogni altro fattore della vita sociale e ogni altra possibile appartenenza collettiva sono impossibili. La politica mondiale è una guerra santa dei buoni contro i cattivi, delle «società aperte» contro le «società chiuse», ed è impossibile che società autoritarie, e quindi per definizione «chiuse», seguano dottrine economiche non dissimili da quelle di buona parte delle società «aperte». Anche perché, così facendo, la grande foto di gruppo dei «nemici della libertà», in cui tenere insieme fondamentalisti religiosi, fascisti e sinistre varie, rischia di venire sfocata.
Il secondo motivo è più generale e parla al nostro mondo: il neoliberismo non si deve nominare perché farlo significa identificarlo come ideologia, come una visione del mondo tra le altre, e rende quindi possibile immaginarne altre. Il neoliberismo non va nominato perché, per il pensiero dominante, non è un’opzione di politica economica tra le tante che si possono seguire: è la legge naturale dell’economia e della società. Purtroppo questo è ciò che è stato insegnato e continua a essere insegnato a una generazione di studenti di economia: i principi dell’utilità marginale sono come la legge della gravitazione universale, l’economia neoclassica descrive la realtà senza alcun elemento normativo, il neoliberismo è, semplicemente, il funzionamento dell’economia, quando nessun complotto comunista-statalista le impedisce di svilupparsi. Da qui deriva il culto per tecnocrazia e meritocrazia: dato che non esistono diverse visioni del mondo da applicare, ma un solo funzionamento possibile dell’economia, la politica e la democrazia sono inutili; basta selezionare i «migliori» e far amministrare loro il sistema così com’è.
Nominare il neoliberismo significa metterlo in discussione, sottoporlo alla possibilità di critica e cambiamento, e immaginare quindi mondi diversi possibili. Difficile non pensare al «realismo capitalista» di Mark Fisher, alla capacità del pensiero dominante di naturalizzarsi fino a occupare l’intero orizzonte del pensabile e a non farsi neanche nominare, tanto è strutturale allo scenario in cui viviamo. Tra l’altro, la predominanza a sinistra della critica al neoliberismo, inaugurata alla fine degli anni Novanta, è a sua volta figlia del realismo capitalista, dell’impossibilità di sottoporre a critica il capitalismo, limitandosi invece a prendere di mira una versione particolarmente radicale di sua gestione da parte dello stato, quella appunto neoliberista. Il realismo capitalista arriva a tentare di cancellare anche le critiche, come quella al liberismo dal punto di vista keynesiano, un tempo tollerate in quanto compatibili con la tenuta generale del sistema.
Ma non è un segno di debolezza, questo? La reazione violenta neanche più alla critica del capitalismo, ma anche solo alla critica del neoliberismo, non indica che il pensiero dominante non è più così saldo nel suo controllo delle coscienze? Può sembrare frustrante che in Italia si debba lottare perché, nel campo democratico e progressista, si possano fare quelle, anche timide e parziali, critiche alla sbornia neoliberista degli anni Novanta e 2000 che nel resto dell’Occidente, Stati uniti compresi, sono l’assoluta normalità del dibattito politico e culturale. A 15 anni dalla grande crisi finanziaria, siamo ancora qui a non riuscire a dire che, forse, la deregulation totale non era stata un’idea geniale? A dover difendere chi dice che un paese in cui il 90% dei contratti di lavoro sono temporanei ha avuto una politica economica discutibile.
La frustrazione è comprensibile. Però, guardandola in prospettiva, si tratta di una rottura storica. Da quanti decenni, in mondi mainstream e potenzialmente maggioritari, non si sentiva usare «liberismo» in senso negativo? In fondo, è giusto che agli ultraliberisti faccia impressione la crescente tendenza alla critica al neoliberismo: è la loro visione del mondo che, da pensiero egemone e quindi legge naturale universale, diventa un’opzione come tutte le altre. Da poter discutere, criticare e abbattere, per immaginare e creare altri mondi possibili.
Lorenzo Zamponi, ricercatore in sociologia, si occupa di movimenti sociali e partecipazione politica. È coautore di Resistere alla crisi (Il Mulino).
12/12/2022 https://jacobinitalia.it


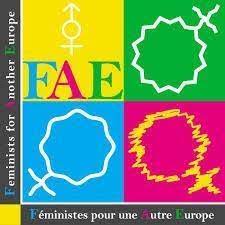






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!