Giovani, armati e disperati
Si muovono in cellule autonome, spinti dalla mancanza di prospettive e dalla violenza dell’occupazione. Indagine sulle nuove resistenze nei territori palestinesi
«La prima Intifada fu mossa dalla speranza, quella che verrà sarà mossa dalla sua scomparsa». Difficile dire a quante attiviste e attivisti palestinesi adulti, a un certo punto di una qualsiasi conversazione, non esca di bocca una considerazione del genere.
Fanno il paio con i più giovani, ragazzi adolescenti o nei loro vent’anni, che in questi mesi riassumono in poche parole la situazione nei Territori palestinesi occupati: «Non abbiamo nulla, nemmeno la capacità di sognare. La scelta è tra morire lentamente o morire subito». Parole che potrebbero apparire retoriche da questa parte del mare ma che sono l’approccio quotidiano all’esistenza di una buona parte dei palestinesi a Gaza, in Cisgiordania, a Gerusalemme est (nei campi profughi sparsi per il Medio Oriente la risposta sarebbe ancora più caustica).
Spiegano anche molto del modo in cui oggi è percepito l’embrione di resistenza armata che ha segnato il 2022 e che continua a crescere in questo inizio sanguinoso di 2023. Quasi 180 palestinesi uccisi da esercito o coloni israeliani nella prima metà dell’anno, mai bilancio fu più alto dalla fine della seconda Intifada, 18 anni fa. A questi si aggiungono 25 israeliani, uccisi in attacchi compiuti da palestinesi.
Una forma altra di ricorso alla violenza, atti individuali come li ha definiti la stessa polizia israeliana, e che non ha a che fare con le brigate nate negli ultimi anni dentro alcune delle città palestinesi in Cisgiordania. La Fossa dei Leoni a Nablus, la Brigata Jenin, e poi via via piccoli nuclei combattenti sorti in diverse realtà, come il Nido dei Calabroni nella sonnolenta Gerico, ma anche a Tulkarem e a Tubas. I palestinesi ne hanno fatto una barzelletta: se anche a Gerico, nel punto più basso della terra, si imbracciano i fucili vuol dire davvero che la situazione è caldissima. Bollente.
Chi sono, cosa fanno, cosa vogliono
«L’alto bilancio di morti ha galvanizzato una nuova generazione di combattenti palestinesi – scriveva a marzo su Foreign Policy l’analista Dalia Hatuqa – Sono iperlocalizzati, operano nelle trincee dei campi profughi e delle città vecchie, e agiscono in aperto contrasto con l’Autorità nazionale palestinese [l’amministrazione nata con gli Accordi di Oslo del 1993 nell’attesa mai concretizzata di farsi Stato, ndr], che è impegnata nella cooperazione alla sicurezza con Israele e di frequente prende di mira questi stessi gruppi. Sono per lo più giovani uomini, da diverse parti della Cisgiordania, dal deserto sonnacchioso di Gerico alla tentacolare città settentrionale di Nablus al decrepito campo profughi di Jenin. Si vedono spesso imbracciare un fucile M16 e indossare passamontagna per non essere identificati».
Un buon identikit, che ridà indietro l’immagine che appare di frequente nelle agenzie internazionali. Giovanissimi, tra i 18 e i 30 anni, legati in molti casi a partiti pur agendo in solitaria, capaci di mescolarsi tra loro e tra diversi riferimenti politici e veloci nel ricambio a causa della crescente repressione da parte israeliana (sotto forma di violentissimi raid, spesso in pieno giorno e in piena città) che li cerca, li individua e li elimina con una velocità altrettanto impressionante.
«Sono i figli della seconda Intifada, ora ne sono i leader», raccontava Amir, un residente nel campo profughi di Jenin, all’agenzia israeliana antisionista 972mag. È una definizione questa che ne contiene tante, che contiene l’analisi della società palestinese dell’ultimo decennio: uscita a pezzi da due rivolte popolari, punita prima con la farsa degli Accordi di Oslo e poi con una riduzione ulteriore delle libertà di base, privata di un’economia funzionale e costretta a farsi manodopera a basso costo nel mercato israeliano, soffocata da un secondo autoritarismo che si è sommato all’occupazione militare e a forme di neoliberismo che hanno aperto un gap difficilmente sanabile tra classi sociali.
I suoi giovani pagano il prezzo maggiore: le figlie e i figli della seconda Intifada non hanno conosciuto che questo, il dominio dell’Anp, una forma di colonialismo di insediamento israeliano ancora più feroce e immune del passato e l’impossibilità di muoversi liberamente sul territorio, inconsapevoli del palestinese che vive al di là del muro, in una frammentazione geografica che si è traslata nella frammentazione del movimento di liberazione, delle sue esigenze e di conseguenza delle sue modalità.
Molta della responsabilità, quei giovani, la attribuiscono ai partiti storici. Per questo le brigate – due-trecento membri al massimo – operano al di fuori. Molti di loro sono vicini alle ali armate di Fatah, Hamas, del Jihad Islami o del Fronte popolare, vuoi per convinzione politica o eredità familiare, ma non se ne sentono legati. Le brigate sono miste, dentro operano fianco a fianco giovani islamisti e giovani comunisti, creano quell’unità che la politica rifugge. Agiscono in piccole cellule, decentralizzate ma riunite sotto un unico ombrello, secondo un modello molto diverso da quello di vent’anni fa quando le varie cellule erano espressione delle ali militari dei partiti politici.
Raramente compiono attacchi, anche se se ne sono registrati di mortali. Per lo più agiscono a difesa dei territori, ovvero dei campi profughi e delle città in Cisgiordania oggetto di incursioni e operazioni militari dell’esercito israeliano. Che si trova sempre più in difficoltà: la più sofisticata organizzazione dei combattenti e la migliorata strategia militare hanno costretto i soldati di Tel Aviv a mettere in campo strumenti che in Cisgiordania non utilizzavano dalla seconda Intifada. A Jenin a fine giugno sono apparsi gli Apache. Aerei da guerra. A qualcuno piacciono molto, il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir preme sul premier Netanyahu perché ordini una vera e propria operazione militare, con il dispiegamento dell’aviazione accanto alle truppe di terra.
Non hanno una precisa agenda politica, o perlomeno non l’hanno ancora resa nota. Vogliono agire, reagire, superare in qualche modo lo stallo.
La critica (poco) sottesa all’Autorità nazionale palestinese
I primi gruppi, o comunque i loro embrioni, sono sorti nel maggio 2021. Era il periodo designato per le tanto attese elezioni parlamentari e presidenziali nei Territori occupati, a 15 anni dalle precedenti. Più volte in passato erano state annunciate e poi ritirate, ma stavolta sembrava che l’Anp facesse sul serio. E invece no. Voto cancellato. La rabbia è montata. Non tanto perché infilare una scheda nelle urne avrebbe innescato chissà quale cambiamento ma perché i palestinesi avevano voglia di esprimersi, di intervenire su una leadership asfittica e divisa, tra Fatah in Cisgiordania e Hamas a Gaza.
La cancellazione di quel voto è stato l’ultimo esempio dell’ormai strutturale autoritarismo dell’Anp, leadership politica che si è fatta anche élite economica, dai metodi clientelari e la corruzione imperante, incapace di una strategia politica seria e di rompere definitivamente con il sistema della cooperazione alla sicurezza con il potere occupante.
Da allora gli unici voti che si sono tenuti, l’ultimo poche settimane fa, è stato quello per il rinnovo dei consigli studenteschi nelle università palestinesi, da tempo ormai specchio della mappa politica visto che sono le uniche urne che si aprono: ha rivinto Hamas, stavolta in modo schiacciante; segue Fatah; la sinistra del Fronte popolare quasi non pervenuta. Anche stavolta tanti studenti hanno detto l’ovvio: non condividiamo il modello sociale di Hamas ma votare gli islamisti è l’unico modo per segnalare a Fatah che l’Anp non la vogliamo più.
Il fatto che le prime brigate siano sorte dopo la cancellazione del voto non è un caso. È un altro messaggio all’Autorità come lo sono gli scioperi nelle scuole (l’ultimo è durato mesi, per tutta la primavera), quelli degli avvocati, dei medici, dei giudici. E non è nemmeno un caso che le brigate godano di un consenso generalizzato. Lo dicono i sondaggi: il 60% dei palestinesi sostiene la resistenza armata e spera si allarghi, il 56% sogna una nuova Intifada (dati del Palestinian Center for Policy and Survey Research). E lo dice la partecipazione ai funerali dei combattenti uccisi, migliaia di persone per ogni commemorazione, pronte a scontrarsi con la polizia dell’Anp che spesso e volentieri ha tentato di impedirli. Come tenta di disarmare le brigate con gli arresti, eventualità a cui le varie comunità rispondono di nuovo scendendo in strada.
Lo dice, infine, il crescente numero di membri o affiliati a Fatah che entrano nelle brigate e cooperano con esponenti di partiti rivali, perché – come spiega il combattente Mohammad Abu Dahra al Washington Post – «i nomi non sono importanti, stiamo resistendo all’occupazione israeliana, non è importante la fazione a cui appartieni. L’importante è essere un soldato sul campo».
Disperazione e speranza al tempo del neoliberismo autoritario
«Con l’educazione, lanciando pietre, sparando con un fucile o scontrandosi con i soldati, è lo stesso: tutte queste forme (di resistenza) fanno infuriare l’occupazione». Majd ha 17 anni e vuole fare il medico. Vive nel campo profughi di Jenin ed è nato quattro anni dopo il massacro compiuto dall’esercito israeliano nella sua comunità: in un paio di settimane di assedio il campo fu letteralmente raso al suolo, decine di persone furono uccise da aerei da guerra, cecchini, truppe d’assalto (consigliamo la visione del film Jenin Jenin di Mohammad Bakri e la lettura del romanzo di Susan Abulhawa Ogni mattina a Jenin).
Majd vive in un luogo che trasuda solidarietà ma anche dolore. I giovani come lui hanno pochissime speranze di trovare un lavoro, nemmeno in Israele (impossibile ottenere un permesso di lavoro se vieni dal campo di Jenin, bollato in partenza), tanto meno di viaggiare all’estero. Ogni famiglia conta un membro ammazzato o in prigione. Ogni giovane conta un amico ucciso, e succede sempre più di frequente. Ogni tanto – anche qui sempre più di frequente – arriva l’esercito israeliano, demolisce case, spara per strada, arresta. Difficile sapere come si sogna. La disperazione è ovunque e allora prendere un fucile diventa quasi una via di uscita.
«Non credo che la lotta armata in Cisgiordania possa avere un futuro alla luce della repressione dell’intelligence e dell’esercito israeliani, che possa diventare una resistenza organizzata e ampia – ci diceva un paio di mesi fa Jamal Juma, storico attivista palestinese e coordinatore da due decenni della campagna Anti-Apartheid Wall – Ma la gente li vede come fonte di speranza perché hanno dato vita a un’unità nazionale, è un caso unico».
Un’unità che oggi manca, sul piano politico ma anche su quello sociale ed economico. Chi viaggia in Cisgiordania, e magari si fa un giro a Ramallah o a Betlemme, questa disperazione potrebbe non vederla neppure, allucinato da grattacieli, negozi di souvenir, bar, banche a ogni angolo. È l’allucinazione neoliberista, quella che Israele e Anp hanno provato a costruire: consuma, costruisci una casa, compra una bella macchina e indebitati, dimentica l’occupazione. In parte ci sono riusciti. La società palestinese è molto cambiata negli ultimi anni, il mito del benessere purché sia è visto da tanti come via di uscita (chi il fucile, chi il suv). Nei Territori non si produce più quasi nulla, i mille ostacoli e divieti posti da Israele hanno reso impossibile un’economia di produzione, lasciando solo le macerie di una poco sostenibile economia di servizi. La continua confisca di terre agricole ha annichilito l’agricoltura, in passato primo settore produttivo, in cambio di una vita come manodopera a basso costo nelle serre e nei cantieri israeliani.
Chi può, se ne va. Chi resta o si impoverisce o si adatta. Si allarga il gap tra ricchi e poveri, con i primi spesso strettamente legati alla leadership politica, sempre più autoritaria, soffocante, intollerante a qualsiasi forma di dissenso. La prova provata che neoliberismo e autoritarismo viaggiano sugli stessi binari, alimentandosi a vicenda, costruendo gabbie protettive del capitale attraverso il dominio politico e il monopolio della violenza. È quel monopolio, che per i palestinesi è ormai doppio, che le brigate armate provano a scalfire. Non perché siano mosse dalla speranza di liberazione. Sono mosse dalla disperazione.
Chiara Cruciati (1983), giornalista, scrive di Medio Oriente sulle pagine del quotidiano il manifesto. È autrice con Michele Giorgio di Cinquant’anni dopo (Alegre, 2017) e Israele, mito e realtà (Alegre, 2018). Il suo ultimo libro, scritto con Rojbîn Berîtan, è La montagna sola. Gli ezidi e l’autonomia democratica di Şengal (Alegre, 2022).
28/6/2023 https://jacobinitalia.it



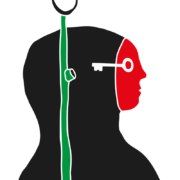






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!