Difendere la memoria dal conformismo
L’eccidio nazifascista delle Fosse Ardeatine è ancora tema di menzogne che contro ogni evidenza storica alimentano la leggenda nera anti-partigiana
La storia dell’eccidio delle Fosse Ardeatine non comincia e non finisce alle Fosse Ardeatine.
Prima ci sono sette mesi di occupazione nazista della capitale: fame, terrore, rastrellamenti, deportazioni, torture, borsa nera, bombardamenti alleati, sette mesi di guerra che oggi ci appaiono scanditi da alcune date-simbolo: 10 settembre 1943, battaglia di porta San Paolo; 16 ottobre 1943, il rastrellamento degli ebrei del ghetto, condotto da soldati delle SS e della Ordnungspolizei (Polizia d’ordine) con la complicità delle autorità fasciste repubblichine; 5 febbraio 1944, a Regina Coeli muore Leone Ginzburg per le torture inflittegli dalle SS; 3 marzo, durante una manifestazione in cui oltre duemila donne si oppongono alla deportazione di centinaia di civili prigionieri, un soldato tedesco trucida Teresa Gullace (è l’episodio che due anni più tardi ispirerà la scena madre del film Roma città aperta).
Sette mesi di resistenza non armata e armata: per quest’ultima i partiti dell’ala sinistra del Comitato di liberazione nazionale (Cln), Partito d’Azione, Partito Socialista d’Unità Proletaria e Partito Comunista, hanno costituito le loro formazioni clandestine, mentre al di fuori del Cln opera il gruppo più numeroso, Bandiera Rossa, attivo soprattutto nelle periferie e nei quartieri popolari.
I Gruppi d’Azione Patriottica (Gap) del Pci hanno elaborato una strategia d’attacco intransigente, esposta in un articolo uscito su l’Unità clandestina del 26 ottobre 1943 in cui si afferma che è necessario «agire subito e ampiamente contro i tedeschi e contro i fascisti, contro le cose e contro le persone; è necessario lottare con tutti i mezzi, dal sabotaggio della produzione, e delle macchine, dei mezzi di trasporto, all’interruzione e devastazione delle linee telegrafiche, telefoniche, elettriche, all’incendio di depositi, magazzini, rifornimenti, a colpi di mano su posti e comandi tedeschi, ecc.». Una strategia basata sul principio di rispondere al terrore con il terrore. Sullo stesso numero del giornale comunista un altro articolo commenta il rastrellamento degli ebrei del ghetto stigmatizzando la «caccia all’uomo» che è stata scatenata a Roma come «in tutta l’Europa invasa, in nome della più bestiale aberrazione che possa deformare la mente umana, in nome di quel razzismo che è la più atroce offesa alla dignità dell’essere umano», e affermando che lo «spirito di solidarietà del popolo italiano […] domanda giustizia e vendetta di fronte a questo spaventoso delitto commesso contro uomini inermi e innocenti, che si vogliono isolare dal resto della popolazione col barbaro pretesto di una inferiorità razziale, esistente solo nelle perverse ossessioni di Hitler». A tale «inaudita violenza» – afferma ancora l’articolo – «occorre resistere con tutte le forze».
Alle parole i Gap fanno seguire i fatti. Dall’autunno 1943 in poi è un crescendo di attentati contro tedeschi e fascisti; ne ricordiamo solo alcuni: il 18 novembre i Gap collocano una bomba sotto il palco del teatro Adriano, dove è prevista la presenza del maresciallo Rodolfo Graziani e del generale Stahel (per un difetto di costruzione la bomba non esplode); a dicembre ordigni esplosivi colpiscono la sede del Tribunale militare tedesco e l’ingresso del carcere di Regina Coeli; il 10 marzo ha luogo un attacco con bombe a mano contro un corteo di fascisti in via Tomacelli. A partire soprattutto dal gennaio 1944 i nazifascisti rispondono agli attacchi intensificando la repressione, operando arresti e fucilazioni.
I Gap di Roma sono caratterizzati da una forte presenza femminile: partigiane come Carla Capponi, Marisa Musu, Lucia Ottobrini, Maria Teresa Regard, sono protagoniste di numerose azioni a fianco di altri partigiani come Rosario Bentivegna, Franco Calamandrei, Mario Fiorentini.
Il 23 marzo 1944 un consistente gruppo di gappisti, fra i quali Bentivegna e Capponi, colpisce con un ordigno al tritolo e con alcune bombe a mano un plotone di gendarmi tedeschi in marcia attraverso il centro di Roma. Per effetto dell’esplosione di via Rasella muoiono 33 soldati della Ordnungspolizei (reggimento Bozen) e due civili italiani. Il Bozen, rispondendo al fuoco, uccide altri quattro civili.
Il giorno dopo le SS comandate dal tenente colonnello Herbert Kappler trasportano alle Fosse Ardeatine 335 prigionieri, in massima parte antifascisti, ebrei, partigiani, detenuti comuni già in cattività e che non c’entravano nulla con l’azione gappista; fra loro anche svariati civili rastrellati dopo l’attentato. Una sentinella tedesca spara e uccide una donna ultrasettantenne che stava raccogliendo erbe troppo vicino al luogo dell’esecuzione: non devono esserci testimoni del misfatto che sta avendo luogo. I prigionieri vengono fatti entrare a gruppi di cinque nelle grotte e abbattuti con un colpo di arma da fuoco alla nuca. Il massacro dura tutto il pomeriggio del 24 e si conclude intorno alle otto di sera. Alla fine, i tedeschi fanno crollare con delle cariche esplosive l’ingresso delle grotte, che saranno dissuggellate solo dopo la liberazione di Roma.
Il 25 marzo i giornali della capitale controllati dai nazifascisti riportano il comunicato con cui il Comando tedesco afferma di avere «ordinato che per ogni tedesco assassinato, dieci criminali comunisti-badogliani saranno fucilati. Quest’ordine è già stato eseguito». Luogo e modalità dell’eccidio vengono tenuti nascosti.
Il 26 marzo L’Osservatore Romano pubblica una nota dove i partigiani sono chiamati «irresponsabili» e gli uccisi alle Ardeatine sono definiti «persone sacrificate per i colpevoli sfuggiti all’arresto». Con tale articolo, dove la realtà della guerra in corso viene ignorata, dove l’attacco partigiano è trattato alla stregua di un atto di criminalità comune e dove i nazisti occupanti sono considerati in tutto e per tutto come l’autorità legittima, il quotidiano vaticano offre un fertile spunto alla propaganda fascista, la quale non mancherà di sfruttarlo a fondo. Lo stesso quotidiano, per inciso, non aveva ritenuto necessario spendere una sola parola di commento all’indomani del rastrellamento del ghetto.
Tra la fine di marzo e la prima metà di aprile 1944 un volantino del Partito Fascista, cogliendo e rilanciando l’assist de L’Osservatore Romano, afferma che «i banditi comunisti dei Gap avrebbero potuto evitare questa rappresaglia, pur prevista dalle leggi di guerra, se si fossero presentati alle autorità germaniche che avevano proclamato, via radio e con manifesti su tutti i muri di Roma, che la fucilazione degli ostaggi non sarebbe avvenuta se i colpevoli si fossero presentati per la giusta punizione».
Menzogna molteplice e stratificata:
- non sono mai esistite «leggi di guerra» tali da giustificare un massacro come quello delle Ardeatine, che non è neppure qualificabile come rappresaglia nel senso tecnico-giuridico del diritto internazionale bellico (in base al quale l’istituto della rappresaglia richiede una serie di requisiti, fra i quali la stretta proporzionalità tra offesa e ritorsione).
- Gli uccisi non erano mai stati ufficialmente qualificati come ostaggi passibili di essere uccisi per rappresaglia.
- La modalità dell’eccidio (Genickschuss, o esecuzione di massa tramite colpo di pistola alla nuca) è un orrore che va ben oltre la «fucilazione» evocata dal volantino fascista, per collocarsi piuttosto nell’ambito dei numerosi crimini dello stesso tipo già perpetrati dalla Wehrmacht sul fronte orientale.
- Soprattutto, nessun proclama o manifesto era stato prodotto dai tedeschi nelle ventiquattr’ore che intercorsero fra l’attentato di via Rasella e l’eccidio delle Fosse Ardeatine. Ai tedeschi non era minimamente passato per la testa di condizionare l’uccisione dei prigionieri alla mancata «presentazione» dei partigiani, come lo stesso Kesselring testimoniò in un’aula processuale nel 1946.
Eppure, le menzogne del volantino fascista costituiscono la base inscalfibile su cui viene edificato tutto il castello delle calunnie contro i gappisti di via Rasella ripetute instancabilmente fino a oggi.
Una vera e propria character assassination viene condotta dalla pubblicistica moderata e di destra in tutto il dopoguerra contro i gappisti, soprattutto contro Carla Capponi e Rosario Bentivegna, dipinto quest’ultimo come una specie di mostro sanguinario. Dai fascisti Attilio Tamaro e Giorgio Pisanò, a Marco Pannella che in un delirante intervento al congresso radicale del 1979 accomuna i gappisti di via Rasella alle Brigate Rosse, a Indro Montanelli che nel 1996 giustifica l’ufficiale nazista Erich Priebke condannato per l’eccidio delle Ardeatine, fino a Bruno Vespa che in un suo libro del 2004 ancora accusa Bentivegna di non essersi «consegnato» ai nazisti nonostante «l’avvertimento scritto sui manifesti fatti affiggere dal comando tedesco», l’elenco dei critici e degli accusatori sarebbe lungo, ma le argomentazioni ossessivamente ripetute sono pressoché sempre le stesse. In omaggio alla voga della «memoria condivisa» e dell’interpretare la resistenza contro i nazifascisti esclusivamente in chiave di «guerra fratricida» fra «italiani», negli ultimi due o tre decenni si è riscoperta l’italianità dei soldati del Polizeiregiment Bozen definiti senz’altro «altoatesini», come se affermare la loro provenienza geografica rendesse di colpo irrilevanti il ruolo che ricoprivano e la divisa che indossavano. Ultimo arrivato il presidente del Senato Ignazio La Russa che nel marzo 2023 definì i soldati del Bozen «una banda musicale di semi pensionati».
La pluridecennale campagna di disinformazione contro i gappisti ha avuto anche ripercussioni nelle aule dei tribunali, attraverso una lunga scia di vicende giudiziali che si sono sempre concluse con la condanna dei responsabili del massacro delle Fosse Ardeatine e – da ultimo – con il riconoscimento dell’attentato di via Rasella come «legittimo atto di guerra».
La persistenza della leggenda nera antipartigiana, contro tutte le evidenze storiografiche e giudiziali che la smentiscono, è un ulteriore ammonimento a mantenere alta la guardia e a non desistere dalla lotta per la memoria. «In ogni epoca – scriveva Walter Benjamin – bisogna cercare di strappare la tradizione al conformismo che è in procinto di sopraffarla. […] Solo quello storico ha il dovere di accendere nel passato la favilla della speranza, che è penetrato dall’idea che anche i morti non saranno al sicuro dal nemico, se egli vince. E questo nemico non ha smesso di vincere».
Salvatore Talia fa parte del collettivo di ricerca Nicoletta Bourbaki, gruppo di lavoro sul revisionismo storiografico in rete, sulle false notizie a tema storico e sulla riabilitazione dei fascismi in tutte le sue varianti e manifestazioni.
23/3/2024 https://jacobinitalia.it/




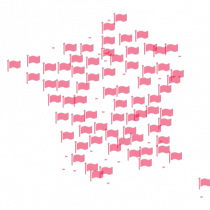




Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!