La guerra di Draghi
Non c’è solo economia nel rapporto dell’ex presidente della Bce, ma anche una politica militare pericolosa, irrealistica e antieconomica
Il 9 settembre scorso è stato pubblicato l’ormai noto Rapporto sul Futuro della competitività europea (qui in pdf), meglio conosciuto come Rapporto Draghi, richiesto dalla Commissione europea e redatto da Mario Draghi. Idealmente, il rapporto avrebbe l’obiettivo di indicare soluzioni per rendere l’Europa più competitiva sul piano globale. Di fatto, è una raccolta di proposte avanzate da Draghi, su richiesta esplicita della Commissione, presieduta da Ursula Von Der Leyen per il secondo mandato consecutivo.
Per Draghi la situazione europea è piuttosto tragica, ma non ancora irreversibile. Secondo l’ex capo della Bce l’Unione ha la possibilità di riconquistare una posizione competitiva a patto di aumentare la sua produttività. Il Vecchio Continente sarebbe indietro soprattutto in alcuni settori chiave, quali l’innovazione tecnologica, il settore energetico e la difesa, a cui si somma l’annosa questione demografica. Per superare queste arretratezze, Draghi segnala la necessità di una «politica economica estera» che sia gestita a livello europeo e non dei singoli Stati, con un duplice obiettivo: da un lato, garantire un modello di sviluppo europeo, più attento alle disuguaglianze e al welfare di quanto non sia il sistema americano, e dall’altro la realizzazione del Mercato unico (già al centro del Rapporto Letta). Smettendo di «comportarsi come un’accozzaglia di paesi diversi», nascerebbe la possibilità di investimenti insostenibili per i bilanci statali, di aumentare la scala dei mercati e di tornare ad avvicinarsi a Stati uniti e Cina, ora tragicamente lontani.
È stato proprio il tema degli investimenti quello a suscitare le reazioni più accese. Nel passaggio più memorabile (e citato) delle 400 pagine di rapporto, Draghi prevede che gli investimenti necessari a realizzare le sue soluzioni ammonterebbero a un triplo di quelli contenuti nel Piano Marshall. I fondi per un simile sforzo andrebbero ricavati anche dalla creazione di debito pubblico comune, una proposta ben difficile da digerire per molti politici europei. In prima linea fra gli scontenti ci sono i centristi tedeschi di Cdu, ossia il partito di Von Der Leyen.
Ma il debito pubblico comune non è l’unico ostacolo alle soluzioni del rapporto. Il successo crescente di partiti sovranisti e di estrema destra va nella direzione opposta rispetto alle proposte di Draghi, ossia maggior cooperazione fra paesi e centralizzazione delle decisioni sugli investimenti pubblici. Senza contare l’enfasi sulla transizione ecologica, eternamente osteggiata dall’agenda politica del nuovo populismo di destra.
Lo svolgersi del dibattito tra partiti europei ha raggiunto risultati prevedibili: l’estrema destra ha criticato i principi di federalismo europeo, la sinistra più radicale ha attaccato quelli tecnocratici, mentre la coalizione di centro ha offerto un generico supporto, anche se ogni grande partito lo ha fatto con riserve. Ecr, il gruppo dei conservatori europei di cui fa parte Fratelli d’Italia, e Verdi si sono aggiunti alla conta, offrendo supporto a specifiche parti del piano. Giorgia Meloni, ad esempio, ha detto che il rapporto contiene «importanti spunti» per quanto riguarda innovazione, questione demografica e approvvigionamento di materie prime, ma si è tenuta a distanza dalle parti più green del rapporto.
Se in generale il Rapporto è stato biasimato dai più per le probabili difficoltà di attuazione, allo stesso tempo è stato tendenzialmente celebrato per quanto riguarda i suoi obiettivi. Thomas Piketty ha scritto su Le Monde che Draghi è andato «nella direzione giusta» e che il rapporto del 9 settembre ha «il merito di seppellire il dogma dell’austerità». Buona parte delle questioni toccate sono in effetti di interesse comune e riconosciute come tali. È ormai proverbiale il ritardo europeo nell’innovazione tecnologica che occupa la prima grande sezione del Rapporto. Allo stesso modo, è ampiamente riconosciuta (estrema destra esclusa) la necessità di investire nelle energie rinnovabili, sia per far fronte al cambiamento climatico che, in un’ottica di competitività globale, per ridurre i costi dell’energia e di materie prime che, come il gas, devono essere importate dall’estero.
Esiste tuttavia una terza parte del rapporto che contiene proposte ben più discutibili in sé, seppur attualmente meno discusse. Si tratta della sezione in cui Draghi si concentra sulla questione della difesa, un tema reso centrale dall’instabilità geopolitica più volte citata all’interno del Rapporto.
Il discorso procede più o meno come segue. L’Unione europea è fortemente dipendente da agenti politici esterni a essa, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti critical raw materials (CRMs), cioè quei materiali (il nickel, il litio, ecc.) che sono insostituibili per la grandissima parte dei prodotti ad alta tecnologia, e la cui offerta è nelle mani di pochi paesi che per di più sono «strategicamente non allineati» all’Europa. Il rischio, continua Draghi, è che queste dipendenze diventino sempre più delle «armi geopolitiche», capaci di minare alla base la capacità europea di perseguire autonomamente i propri obiettivi senza essere ricattabile, nonché di essere meno vulnerabile a bruschi cambiamenti di prezzo o shock commerciali come quello del gas russo. La soluzione prevede in primis un’azione strategica che miri a inserirsi in catene commerciali e processi produttivi in Africa e America Latina (imitando la Cina), un’azione economica atta a sviluppare competenze all’interno del territorio europeo per ridurre le dipendenze riguardo certe fasi della produzione (imitando gli Stati Uuniti) e, infine, un’azione militare, ossia un aumento della spesa militare e una ristrutturazione della stessa.
Sono pochi i paesi Nato-Eu, nota Draghi, che raggiungono il livello di spesa militare del 2% del Pil richiesto nella conferenza Nato in Galles del 2014. Attualmente la crescita ha portato in un decennio la spesa militare dei paesi europei dall’1,4% all’1,8% del Pil. Pur riconoscendo questo dato a livello superficiale, in questo passaggio Draghi omette le conseguenze di tale crescita. Tra il 2014 e il 2023, in termini reali, il Pil europeo è cresciuto del 12%, un più che modesto 1% circa all’anno, e l’occupazione del 9%. Nello stesso periodo, per effetto della già citata conferenza in Galles, le spese militari sono cresciute del 46%. Siccome attualmente la maggioranza dei paesi europei ha la coperta corta per quanto riguarda la spesa pubblica, visti i diffusi problemi di debito, questo incremento ha inibito molto fortemente la possibilità di investire in altri settori: è piuttosto notevole il fatto che la crescita della spesa militare superi quella in salute (+34%) considerando che è compreso il periodo della pandemia. Salute ed educazione (+12%) sono le grandi assenti del rapporto Draghi, come ricordato anche dal già citato Piketty.
Uno studio commissionato da Greenpeace e condotto da alcuni ricercatori italiani ha analizzato, partendo dai numeri sopracitati, l’effetto sulla crescita dell’economia e dell’occupazione di un pari investimento in diversi settori, quali salute, istruzione e ambiente. I risultati mostrano che, anche per effetto della maggiore incidenza delle importazioni, la spesa militare risulta essere la meno redditizia e la meno capace di generare posti di lavoro, mentre l’ambiente emerge come miglior opzione in entrambi i campi. Questo per quanto riguarda l’approvvigionamento di armi, che rappresenta un elemento centrale nella crescita della spesa militare dell’ultimo decennio. A fronte di numeri simili, le conclusioni dello studio affermano che «la militarizzazione è un cattivo affare anche in termini puramente economici». La giustificazione della posizione di Draghi non può che essere politica. A dir la verità, la posizione dell’ex capo della Bce sembra più che altro ricalcare le conclusioni della conferenza Nato di Vilnius dell’anno scorso, nella quale è stata riconosciuta la necessità di prepararsi a spese anche superiori al 2%. Più che una «politica economica estera», sarebbe il caso di parlare di una «politica militare europea».
Nel capitolo in questione, Draghi cita anche la necessità di aumentare la percentuale di spesa militare destinata all’R&D (Research & Developement), una componente sottorappresentata nei bilanci attuali dei paesi Ue. Tuttavia, l’intero ragionamento sulla difesa si fonda sulla necessità di proteggersi nel breve periodo dagli effetti distorsivi della globalizzazione, mentre cambiamenti così radicali richiedono tempo. Per di più, nulla vieta (se non gli interessi di alcuni privati molto potenti) di concentrarsi su una riorganizzazione della spesa militare, piuttosto che su un suo aumento in termini assoluti, ammesso e non concesso che il settore debba effettivamente essere una priorità della prossima legislatura europea.
Immaginando realisticamente che nei prossimi anni probabilmente non si investirà il triplo del Piano Marshall, anche perché le misure con cui Draghi immagina di finanziare le sue proposte sono mal viste da molti nei vertici europei, l’Europa si troverà nuovamente davanti a una scelta. Non ci saranno i fondi per concentrarsi su tutto, e nuovamente un aumento della spesa militare ridurrà la portata di investimenti in educazione, salute e ambiente soprattutto. Si tratta di una valutazione di costi opportunità: quando si prende una scelta economica, si sostengono i costi delle opzioni a cui si rinuncia. Secondo questo ragionamento, i costi di un aumento ulteriore del ritmo di crescita delle spese militari superano i benefici. È una conclusione a cui si arriva anche sorvolando il fondamentale discorso politico: siamo davvero sicuri che il modo più efficace di difendersi dall’instabilità geopolitica sia armarsi? Draghi evidentemente lo è. E siccome è difficile che immagini davvero la mole di investimenti di cui parla, è anche ben consapevole degli effetti sull’economia di simili priorità. Il rischio, insomma, è il celebre cane che si morde la coda. Paradossalmente, aumentare gli investimenti militari è uno dei modi più efficaci per tramutare in realtà le nere profezie che lo stesso Draghi formula nelle prime pagine del rapporto: un’Unione europea che, perseverando diabolicamente con le stesse scelte, resterà inadeguata e stagnante.
Luca Santoro è uno studente di sociologia, collabora con la redazione programmi di Radio Popolare a Milano.
14/10/2024 https://jacobinitalia.it




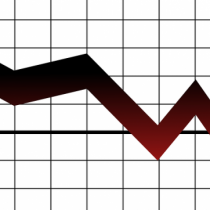

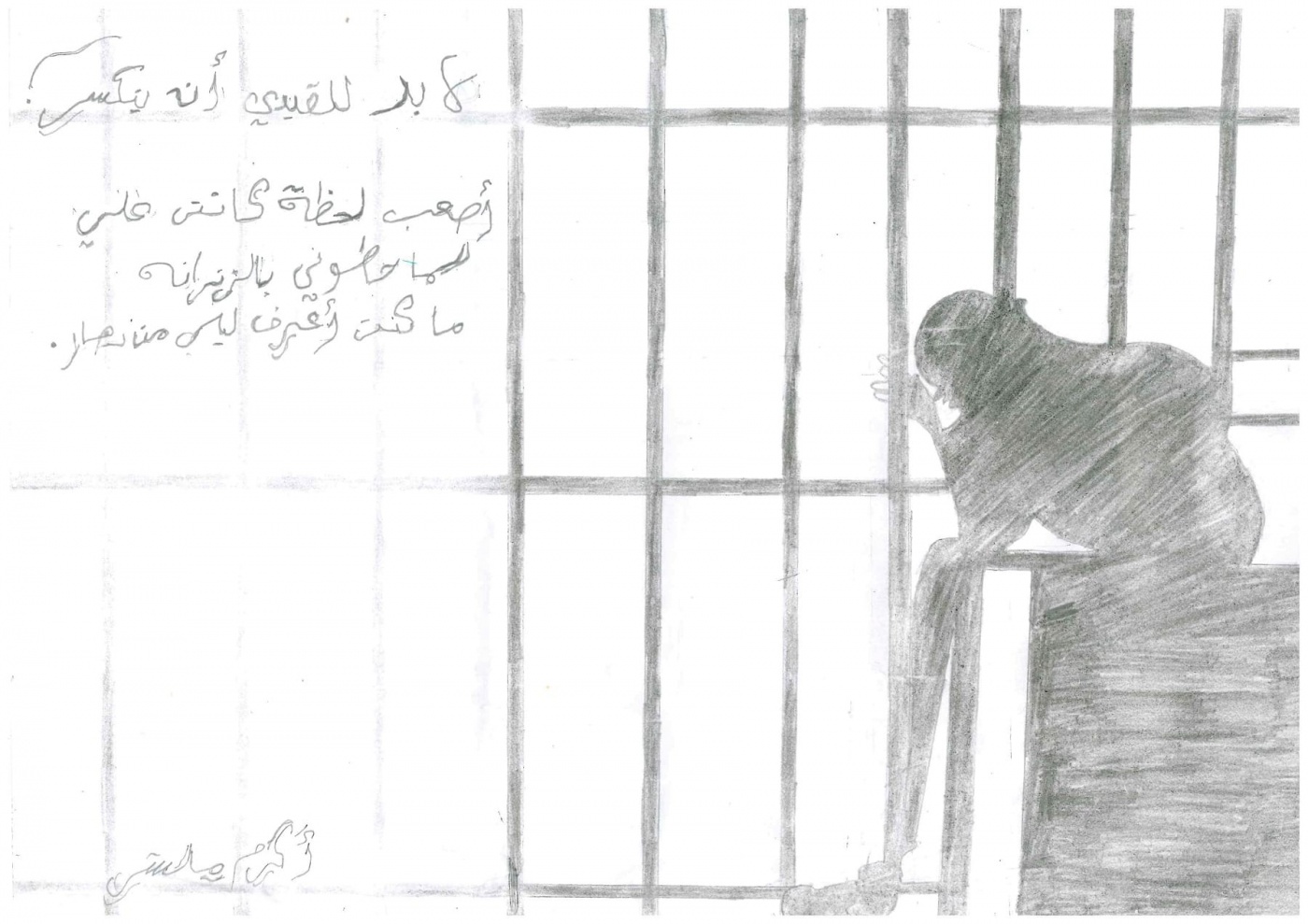



Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!