A uccidere è l’organizzazione del lavoro

Qualche settimana fa proprio da alcuni capannoni di Montemurlo in provincia di Prato, vicino a dove è successo il terribile infortunio mortale di Luana D’Orazio, l’operaia tessile di 22 anni rimasta intrappolata e stritolata nel subbio dell’ordito, inviai ad alcuni compagni sindacalisti questa foto che avevo appena scattato commentando «la solitudine del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls)».

Ero uscita da una ditta tessile artigiana e ancora una volta avevo dovuto spiegare che non ero rappresentante in quanto «venditore di qualcosa» ma sono una figura formata e obbligatoria per legge, che cerca di rappresentare e dunque dare voce e tutela sulla salute, la sicurezza e la prevenzione a lavoratrici e lavoratori nelle aziende sotto i quindici dipendenti del territorio di Prato e provincia.
Poco più di un anno prima, con l’inizio della pandemia, con il lockdown, con i Dpcm e i protocolli anti-contagio improvvisamente ci si era ricordati di questa figura, come ho già raccontato. Purtroppo non è durata molto: dopo lo stordimento iniziale, le riunioni, il coinvolgimento, i telefoni impazziti, le misure di precauzione per il virus, gli Rls sono tornati i rompiscatole di prima, più di prima. «Quante storie, quanta precauzione, bisogna pur lavorare e andare avanti, no? Non ci volete far lavorare? Qua se non si lavora chiudiamo tutto per davvero». Parole che potevi sentire dappertutto. La prevenzione come ulteriore ostacolo alla ripartenza.
C’era stato poi un altro grave fatto che aveva colpito sei Rls ferrovieri che si sono costituiti parte civile nel processo della strage di Viareggio e che in seguito alla sentenza di Cassazione che non ha riconosciuto la mancata applicazione del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro come era stato fatto nei gradi di giudizio precedenti, sono stati chiamati dai legali delle Ferrovie dello stato a versare una somma complessiva di circa 80.000 euro di spese legali. Dieci anni di tempo, carte, competenza, conoscenza di procedure e leggi messe a disposizione della battaglia a fianco dei familiari delle vittime e delle organizzazioni sindacali per poi vedersi arrivare questa batosta. È evidente che se fosse passato che le lotte per la salute e la sicurezza, e per il riconoscimento delle figure di rappresentanza, producono questi costi di impegno e soldi, sarebbe stata una sconfitta per tutto il mondo del lavoro. Dopo un tam tam di solidarietà per promuovere una cassa di resistenza, dopo un appello di Rifondazione Comunista e svariate firme del mondo culturale e dello spettacolo, il Primo Maggio i sei Rls hanno annunciato la straordinaria partecipazione delle circa 3.000 persone che, sensibili a quella tragedia e ai temi della sicurezza, hanno contribuito individualmente oppure in forma organizzata al difficile traguardo di questa sottoscrizione solidale raggiungendo più di 130.000 euro che oltre a coprire le spese sosterranno altre lotte su salute e sicurezza.
La seconda ondata di contagi riesplosa a ottobre ci ha condotto alle note zone colorate e a Prato, proprio negli ultimi mesi, nonostante settimane di zona rossa, i contagi non calavano. Continuavo a muovermi fra capannoni, ma sempre più a fatica: quarantene, contagi, positivi, c’era sempre qualche ditta che rimandava il sopralluogo. Agli amici che mi chiedevano come va, rispondevo «scanso i birilli». La mia percezione era che non si rispettassero i protocolli, ma non tanto su mascherine, gel e distanza quanto sulle quarantene. Se c’è da rispondere a una consegna, nelle ditte piccole soprattutto, anche se in attesa di esito da tampone o con familiari positivi, vieni a lavoro lo stesso per poi contagiare gli altri dipendenti. Se non previeni il conto ti arriva tutto insieme o in contagiati o in infortuni. Se le persone si ammalano poi non lavorano e magari per risparmiare un giorno di quarantena hai perso due mesi di lavoro.
Abbiamo avuto la conferma dalla Asl che ha decretato che in Toscana la provincia peggiore dei contagi è proprio Prato: ci si contagia nelle fabbriche e dai controlli una ditta su quattro non rispetta le regole. Sono arrivati anche i dati drammatici della perdita dei posti di lavoro che in assenza del blocco dei licenziamenti sarebbe un’emorragia: nel 2020 nell’area pratese si sono persi 2.161 posti di lavoro, 955 nel tessile, soprattutto nell’abbigliamento, e 1.242 nei servizi. Come mi ha detto un artigiano: «io faccio filato per giubbotti e io che li faccio nell’ultimo anno non ne ho comprati. Se esci in questa situazione vai a prendere un gelato, una boccata d’aria e non a comprarti un giubbotto». Un suo dipendente impiegato da 19 anni come tessitore si è licenziato ed è tornato in Pakistan.
Prato e provincia poi hanno avuto 1.872.185 ore di cassa integrazione in deroga solo nel periodo da gennaio a luglio 2020. Le ore del Fondo di integrazione salariale nello stesso periodo sono state 5.036.940. Girando per capannoni ho spesso avuto l’impressione che o sei fermo con gli operai a casa o chi è a lavorare corre, anche per rimediare al tempo perso o per colmare le assenze da contagi e quarantene.
Prato ha un’insolita percentuale di lavoro part-time se confrontata col resto della Regione: si assicurano i lavoratori per 4 ore, se ne lavorano 16. Senza denunce di lavoratori e lavoratrici le aziende sfuggono ai controlli perché il lavoro a nero è subito identificabile, il sommerso e il grigio molto meno. A Prato è balzata alla cronaca nazionale la lotta con sciopero e presidio permanente dei lavoratori tessili della Texprint che chiedono di lavorare 8 ore al giorno e di non essere sfruttati: praticamente una conquista avuta all’inizio del Novecento, ma che qua non è garantita.

Prato ha poi poco personale negli organi competenti per i controlli. Ha avuto investimenti regionali per il piano del lavoro sicuro che però ha concentrato e intensificato i controlli sulle aziende a titolarità cinese e non per l’intera filiera della moda.
Prato ha una superficie di capannoni industriali impressionante che l’ha disegnata nei decenni, ma molti sono vuoti, altri fatiscenti e senza innovazione. Tanti industriali hanno abbandonato la produzione e gli investimenti per darsi alla più comoda e redditizia rendita degli affitti dei capannoni. È un mio cruccio, dopo aver seguito il processo per la morte dei sette operai cinesi nel rogo del Teresa Moda nel 2013 e la sentenza che ha scagionato i proprietari del capannone, definiti dal Pubblico ministero «professionisti dell’immobiliare», trovare i dati sugli affitti. Ma non ci sono e non interessa a nessuno trovarli. Il distretto tessile era caratterizzato anche da un continuo studio del territorio e della filiera, coniando concetti poi divenuti di uso nazionale, ma adesso si è smesso di fare. La ricerca è un orpello, quella sociale non ne parliamo. Anzi, si è fatto pure peggio: molto spesso si continua a guardare il distretto tessile con la lente della nostalgia del passato, di una gloriosa età dell’oro, dove chiunque trovava da lavorare e giravano tanti soldi, mettendo in campo risposte di pancia più che di studio del contesto e dei cambiamenti in atto.
Si dice che a Prato vada riscoperta l’etica del lavoro. Quale etica aveva Prato? Lavorare 16 ore il giorno, perdere falangi e udito, bambini a gironzolare fra i macchinari, acque colorate e inquinate nei fiumi, capannoni che vibrano di fianco alle case e sognare di diventare padrone? Questa etica aiuta salute e sicurezza nel lavoro e nella città?
A Febbraio 2020 è morto schiacciato da un macchinario Sabri Jaballah, operaio tessile poco più che ventenne a Montale in provincia di Pistoia in una ditta italiana strutturata. Luana D’Orazio è morta in una piccola ditta artigiana italiana, di cui è costellato questo contesto. Va accertata la dinamica perché un ordito con fotocellule e protezioni non stritola un corpo. Due ventenni in poco tempo nello stesso territorio e nello stesso settore ci hanno schiaffeggiato di orrore per il modo terribile in cui sono morti e ci hanno ricordato che gli operai e le operaie esistono e che i racconti patinati sui giovani non la dicono tutta. Come ha scritto Alberto Prunetti devi crepare per ricordare che esisti.
Può sembrare paradossale dirlo, ma non sono le macchine che uccidono, uccide l’organizzazione del lavoro e il contesto lavorativo. Questa morte sul lavoro è avvenuta in un contesto familiare. Nel luogo di lavoro tutti volevano bene a Luana, pure i titolari. Ci mancherebbe. È un’altra caratteristica del territorio avere ditte familiari. Un punto considerato da sempre di forza del tessuto produttivo, ma anche questa è una distorsione per salute e sicurezza. La famiglia non ti salva, volersi bene non ti salva. L’affetto non è fare prevenzione sui luoghi di lavoro. Anzi, spesso attutisce le richieste, soffocate nel pudore e in altri sentimenti. Salvano, a Prato come in tutto il paese, le protezioni, l’investimento in tecnologie (perché si investe solo sulle App per sfruttare il lavoro e molto meno su macchinari, procedure e protezioni?), la formazione seria e non il mercato nero degli attestati, i contratti stabili e senza monetizzazione del rischio, l’analisi di filiera e di territorio, lo studio dei lavoratori come cittadini e poi come lavoratori, l’addestramento e il passaggio di consegne di conoscenza delle maestranze, il coinvolgimento di lavoratori e lavoratrici e delle loro rappresentanze nella valutazione dei rischi e nella prevenzione.
Fra gli anni Sessanta e Settanta abbiamo conquistato lo Statuto dei lavoratori e il Sistema sanitario nazionale grazie alle lotte del movimento operaio e a una stretta collaborazione con tecnici, medici, studiosi. Una sinergia che ha saputo fare rete e produrre forza. Oggi tutto è frammentato e ognuno guarda al proprio pezzettino, muovendosi in un magma per salvaguardare sé stesso e sempre di più si disperde un patrimonio di relazioni e conoscenza intorno al lavoro, alla salute e alla sicurezza. Enti pubblici, procure, istituzioni, organi di vigilanza, medicina del lavoro, sindacati sono strutturati più su gerarchie, burocrazie e rigidità che non sul patrimonio di conoscenza comune e sulla capacità di metterlo in rete. Bisogna riuscire a non disperdere e a riprodurre la conoscenza.
Mia mamma, operaia tessile, mi ripeteva come un mantra di studiare perché è brutto quando le parole ci vengono dopo, quando è tardi. Ecco, studiare per difendersi. Studiamo e diamo valore per gli altri al nostro studio. Non cerchiamole dopo, le parole. Non svuotiamole di senso. Usiamole correttamente e coerentemente e diamo parole per difendersi alle lavoratrici e ai lavoratori. Perché siamo stanchi anche di chi usa la cultura della sicurezza come un intercalare: di solito più la si invoca meno ce n’è.
Ci vediamo oggi in piazza per lo sciopero generale a Prato.

Simona Baldanzi è Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza per la Cgil di Prato. È autrice tra l’altro di Figlia di una vestaglia blu (Fazi 2006, Alegre 2019), che ha vinto il Premio Miglior Esordio di Fahrenheit Radio3 Rai, di Il Mugello è una trapunta di terra(Laterza, 2014) e di Maldifiume. Acqua, passi e gente d’Arno (Ediciclo, 2016).
7/5/2021 https://jacobinitalia.it




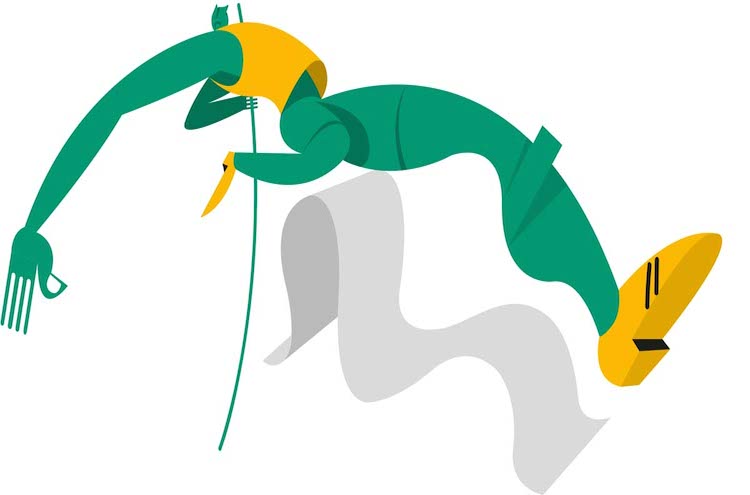





Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!