Al lavoro nell’Italia contemporanea

Alessandra Pescarolo, ricercatrice storica e sociale, laureata in Storia economica e sociale, ha pubblicato un testo molto interessante e approfondito sul rapporto fra donne e lavoro dall’Ottocento a oggi. Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea (Viella, 2019) risponde a molti quesiti di un dibattito antico che caratterizza la storia di genere. All’autrice abbiamo rivolto alcune domande per capire gli snodi fondamentali che hanno caratterizzato l’affermazione delle donne nel mondo del lavoro.
Perché ha deciso di scrivere questo libro che indaga il lavoro delle donne nell’età contemporanea?
Le ricerche sul lavoro delle donne si sono sviluppate molto negli ultimi anni, con studi importanti ma frammentati. Dare conto delle dimensioni e della qualità di questo lavoro, ricomponendo tutti i pezzi in un quadro unico, mi è sembrato utile per contrastare una sottovalutazione del loro contributo all’economia e allo sviluppo che ha radici in discriminazioni antiche ma resiste nel nostro immaginario. Una sintesi mi sembrava utile per rendere più istituzionale e condivisa questa storia. Con questo scopo ho però cercato di superare una valorizzazione del lavoro femminile altrettanto ideologica, appiattita su un sentimento ‘rivendicativo’. C’è una vulgata della storia delle donne che, per smontare il luogo comune che esse siano entrate nel mondo del lavoro solo con la modernità e con l’accesso ai diritti, rischia di suggerire che le donne siano sempre state estranee all’ideale della ‘domesticità’. In un quadro di lavoro duro e di incompatibilità con una identità materna desiderabile, affettiva ed educativa, la figura della moglie/madre ha assunto connotati morali e di status e, nel corso del Novecento, ha esteso la sua influenza dalla borghesia agli strati superiori della classe operaia, rendendo ambivalente il rapporto fra donne e lavoro.
Quali sono i momenti storici più importanti per l’affermazione della donne nel mondo del lavoro?
Dal punto di vista quantitativo la partecipazione, sia femminile che maschile, era più alta prima dell’industrializzazione, che ha reso più produttivo il lavoro e permesso allo stato di ampliare le fasce di popolazione (scolari, studenti, e poi pensionati) che non lavoravano. Dal punto di vista qualitativo molte lavoratrici, sotto una cortina di riserbo, hanno coltivato amore e fierezza per il loro lavoro. Non solo artiste o insegnanti: anche le contadine, nonostante l’enorme fatica, erano fiere della propria forza e della propria resistenza fisica. L’espressione affermazione suggerisce tuttavia una storia diversa, che ha una dimensione essenziale nel riconoscimento pubblico. Solo quando le borghesi, nel corso del Novecento, cominciarono a far proprio il valore del lavoro, entrando in attività professionali fino ad allora maschili, il lavoro poté declinarsi come affermazione di sé. La prima guerra mondiale fu un cruciale spartiacque per la visibilità pubblica del lavoro delle donne, che avevano mandato avanti il fronte interno in assenza degli uomini, e anche per l’accesso all’istruzione superiore: si celebra quest’anno il centenario della Legge Sacchi, che nel 1919, grazie alla spinta ugualitaria impressa dalla guerra, abolì l’autorizzazione maritale, secondo cui le mogli dipendevano dal consenso del marito per firmare contratti e comparire in giudizio. Fu inoltre consentito alle donne di accedere alla dirigenza pubblica, anche se non ancora all’alta dirigenza (ad esempio la magistratura). Dopo la seconda guerra mondiale inizia un percorso di riconoscimento e inclusione più intenso, che si accompagna a una più piena affermazione del valore del lavoro femminile nella classe media e alta. Come è ben noto, questo mutamento non ha però condotto le italiane a livelli di partecipazione paragonabili a quelli dell’Europa centrale e settentrionale.

Guardando al lavoro femminile, quali sono le differenze di ieri e di oggi, anche rispetto alla geografia dell’Italia?
I dati dell’edizione relativa al 2014 dell’indagine Istat sull’uso del tempo sono interessanti. Le risposte all’affermazione presentata nell’indagine “per la famiglia è meglio che l’uomo si dedichi prevalentemente alle necessità economiche e la donna alla cura della casa” si differenziano per genere, per collocazione territoriale, per età e per livello di istruzione. La differenza territoriale è consistente fra i giovani maschi di 18-24 anni, e quelli del mezzogiorno concordano in maggioranza, con il 54,7%, diversamente dai coetanei del nord, che rispondono affermativamente solo nel 37,2% dei casi. Anche più marcate, a partire da una minore condivisione dell’affermazione, sono le differenze fra le donne, che rispondono affermativamente nella proporzione del 22,8% al nord e in quella del 39,9% nel mezzogiorno. Il dato delle giovani del sud lascia supporre un forte isolamento, in quel contesto, delle laureate, la cui adesione ai valori tradizionali è più bassa rispetto al dato citato. Il titolo di studio è infatti un’altra variabile di grande rilievo: nel caso degli uomini la maggioranza di coloro che hanno solo la licenza elementare o media, con il 52,7%, condivide l’affermazione, che coinvolge, invece, solo il 28,8% dei laureati.
Quali sono le posizioni professionali in cui le donne ancora oggi faticano ad affermarsi? Quali i fattori che incidono in questo genere di disuguaglianza?
Le donne hanno avuto lentamente accesso a posizioni ‘alte’, come quella di imprenditrice o di dirigente, che chiedono un impegno pervasivo, e offrono posizioni di potere, denaro, visibilità pubblica. Dove gli orari sono family friendly, come in magistratura, le donne sono entrate tuttavia con numeri massicci.
Cosa si intende per modello male breadwinner e dove non è ancora stato superato? Perché questa resistenza?
La definizione è stata coniata da un sociologo americano, Talcott Parsons, per l’America degli anni cinquanta, e in Italia si è realizzato parzialmente, estendendosi ai ceti superiori della classe operaia. Il modello ha radici antiche, basate nella cultura maschile dell’onore e sull’invisibilità pubblica delle donne, ma la borghesia, dal primo novecento, ha cercato di universalizzarlo con leggi che impedivano alle donne i lavori notturni, pesanti e faticosi, e con una campagna ideologica, aggiungendovi l’idea che sia dovere dell’uomo mantenere le donne, viste solo con i loro corpi di potenziali madri, bisognosi di tutela contro sforzi eccessivi. Il cosiddetto modello del male breadwinner, che attribuiva dunque agli uomini il compito di mantenere la famiglia con i loro guadagni e alle donne quello essenzialmente materno e domestico, è ancora radicato in Italia. Si potrebbero citare molti esempi di un persistente ‘tradizionalismo’, a partire dall’European Values Survey: una delle domande consente di capire quante persone, nei vari paesi europei, pensano che i figli in età prescolare soffrano se la madre lavora. Rispondono positivamente solo il 9% dei danesi e il 36% dei francesi, mentre la percentuale di italiani e di italiane raggiunge il 76%, con una adesione maggioritaria delle stesse intervistate.
Quali sono le radici dell’idea di ‘minorità femminile’? Quando, storicamente, le cose hanno cominciato a cambiare?
L’idea della minorità femminile è legata a una lunga tradizione culturale che ha considerato le donne inferiori agli uomini in termini di forza fisica, mentale, morale. Perfino nel processo generativo Aristotele considerava superiore il contributo dell’uomo, e Galeno, alla fine del II secolo dopo Cristo, scriveva che la costituzione sessuale femminile era un opaco riflesso di quella maschile, affermando: “Tutte le parti che hanno gli uomini le hanno anche le donne (all’interno)”; “i genitali femminili sono la versione imperfetta dei maschili, come gli occhi ciechi della talpa sono la versione imperfetta dei nostri occhi”. Queste credenze furono incorporate in leggi che non accordavano alle donne una piena capacità giuridica.
Secondo lei il dibattito sulle disuguaglianze di genere è abbastanza presente in Italia?
Credo che gran parte delle donne che lavorano sia ormai motivata a ridurre le diseguaglianze; credo anche che molti uomini di orientamento democratico siano divenuti consapevoli, ma a volte con una convinzione poco profonda, superficiale. Però ci sono molte differenze fra soggetti e contesti, e la situazione sembra migliore fra i giovani, le persone con livelli di istruzione più alti, nel nord Italia.
Il femminismo ha ancora qualcosa da dire alla società di oggi?
Il femminismo ha ancora molto da dire, ma a mio avviso l’elaborazione intellettuale deve uscire dagli spazi separati, che è stato giusto costruire dagli anni settanta per rafforzare la nostra consapevolezza delle capacità mentali e fisiche delle donne. Oggi il separatismo organizzativo, posto che abbia ancora un senso, dovrebbe essere integrato con l’azione su temi specifici, culturali e politici, inerenti a un nuovo equilibrio di genere. Il separatismo invece aiuta gli uomini a considerare le questioni femminili come questioni particolari, questioni di donne. Non dico che si debbano chiudere i battenti delle associazioni e delle riviste militanti, con il loro patrimonio di riflessione anticonformista. Tuttavia bisogna stare addosso agli uomini per intrecciare i nostri discorsi con i loro, per far capire che non c’è un intento conflittuale, ma la proposta di una cooperazione paritaria nel proporre spazi e beni comuni che vanno dal livello micro (la famiglia) a quello macro (la società e la politica).
Giovedì 17 ottobre 2019 Alessandra Pescarolo sarà a Roma, presso la sede della Fondazione Giacomo Brodolini, in Via Solferino 36, per la presentazine del suo libro che si terrà alle 17.30. Per saperne di più
Elena Paparelli
2/10/2019 www.ingenere.it






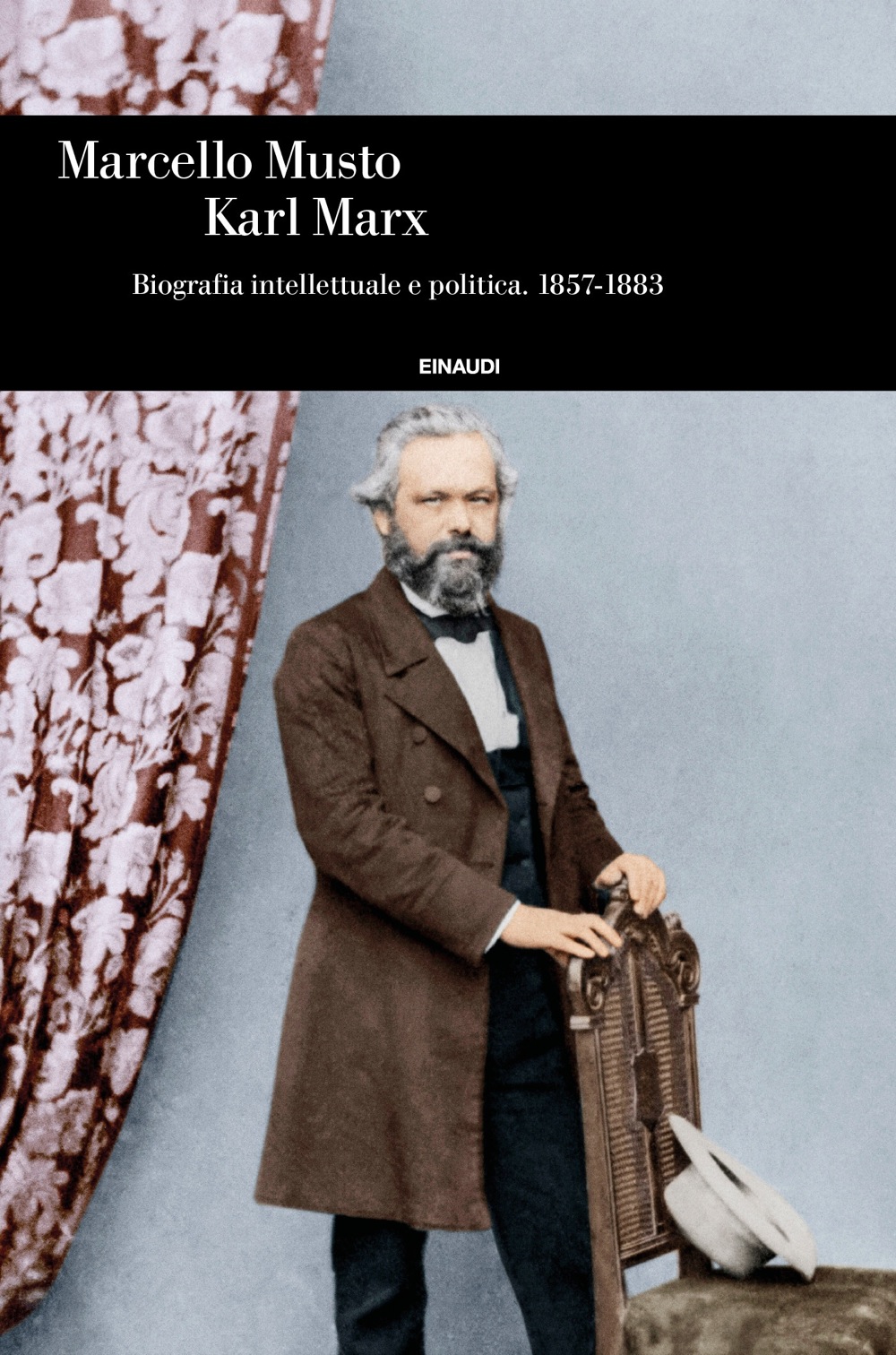



Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!