Assistenti familiari
In un paese dove il numero delle persone anziane è destinato ad aumentare, quella dell’assistente familiare è una figura cruciale. Servono norme condivise a livello nazionale per una formazione adeguata alla professione. Il quadro, a partire dagli ultimi interventi di legislazione in materia
Secondo l’ultimo rapporto annuale sul lavoro domestico dell’Osservatorio dell’Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico (Domina), nel 2023 le persone impiegate nel lavoro domestico in Italia erano 833.874, di cui l’88,6% donne e l’11,4% uomini. Le persone straniere rappresentano il 68,9% contro il 31,1% di quelle italiane, mentre le colf sono il 50,4% e le persone che svolgono il lavoro di badante il 49,6% (di cui quasi due terzi straniere).
Senza entrare nella diatriba sulle diverse denominazioni, userò qui il termine ‘assistente familiare’ per indicare la figura professionale a cui si riferiscono la legge 33/2023 e il successivo decreto legislativo attuativo n.29/2024.
Le norme prevedono l’adozione di Linee guida nazionali che definiscano le competenze delle persone che lavorano come assistenti familiari (e non dimentichiamo che si tratta soprattutto di donne) e le modalità per la loro formazione, con standard formativi uniformi a livello nazionale e i riferimenti per individuare, validare e certificare le competenze pregresse.
Alla base c’è l’esigenza di mettere ordine in un quadro che vede una grande diversità nella regolazione da parte delle regioni – non solo nella denominazione della figura dell’assistente familiare, ma anche nella sua collocazione in ambito sociale o socio-sanitario e nella formazione, con contenuti differenti e durata variabile, da 122 a 600 ore.
Inoltre, non tutte le regioni possiedono una regolamentazione di questa figura. Fra gli obiettivi della legge, pertanto, c’è quello di garantire alle famiglie, in tutto il territorio nazionale, la qualità delle prestazioni, e a chi lavora come assistente familiare il diritto di accedere a una formazione adeguata, ma anche il dovere di possedere le competenze necessarie per accedere alla qualifica regionale – e magari anche a un percorso di carriera come operatrice/operatore socio-sanitario (Oss).
Questo diritto-dovere deve comprendere anche la possibilità di vedersi riconosciute le competenze acquisite tramite esperienze o attività formative pregresse, attraverso il Sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite, istituito dal Dlgs 13/2013 nella prospettiva dell’apprendimento permanente definita dalla legge 92/2012.
Il 18 dicembre 2024, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), in collaborazione con l’associazione Officina delle competenze, ha elaborato e reso pubblico un documento con una serie di Osservazioni e proposte in materia di Linee guida per la formazione degli assistenti familiari, con l’obiettivo di dare un contributo alla definizione delle linee guida, a garanzia delle persone impiegate nel lavoro domestico e delle famiglie che fruiscono dei loro servizi.
Per questo, il Cnel sottolinea da una parte la necessità di offrire un quadro condiviso fra tutte le istituzioni coinvolte e le parti sociali, per realizzare percorsi di formazione professionale per diventare assistente familiare. Dall’altra, di riconoscere le competenze pregresse in termini di risultati di apprendimento all’interno di contesti di lavoro, compresi quelli informali e non formali.
Nelle raccomandazioni del Cnel vengono analizzati i dati del fenomeno e l’evoluzione del contesto, che vedono un quadro demografico di allungamento della vita (il 12% della popolazione ha più di 75 anni), ma anche di aumento delle fragilità e dei bisogni di assistenza delle persone non autosufficienti (condizione stimata in Italia per 3,8 milioni di persone).
Una situazione che evidenzia il ruolo cruciale di chi svolge il lavoro di cura: l’assistente familiare, che ha un rapporto di lavoro dipendente dalla famiglia, ma anche chi presta assistenza come caregiver e all’interno della famiglia si prende cura di un proprio congiunto (la stima è di 2,3 milioni di persone con impegni di cure spesso superiori alle 20 ore settimanali).
Se il diritto delle persone anziane a una vita dignitosa e indipendente è un principio cardine che deve orientare ogni intervento, chi lavora come assistente familiare non è solo un’operatrice o un operatore, ma anche una figura di riferimento nella costruzione di un ambiente che tuteli l’autonomia e contrasti solitudine, isolamento e discriminazioni basate sull’età avanzata.
Il ritardo strutturale del nostro paese sul versante dei servizi per l’assistenza a lungo termine e su quelli per la non autosufficienza, in particolare per la domiciliarità, fa emergere un quadro caratterizzato da forti differenziazioni a livello territoriale. Per questo è importante che ci sia anche il riconoscimento di chi si fa carico del lavoro di cura, sia come lavoratrice o lavoratore che come familiare, offrendo stimoli per uscire dal sommerso, dignità al ruolo svolto e prospettive di crescita professionale.
Le raccomandazioni del Cnel delineano il profilo dell’assistente familiare considerando diversi riferimenti normativi e professionali: l’Atlante del lavoro e il repertorio nazionale, che descrivono le attività e le competenze richieste per questa professione; il Contratto collettivo nazionale (Ccnl), che individua i livelli professionali per chi assiste persone non autosufficienti, includendo anche mansioni legate alla casa, e la Certificazione UNI 11766:2019. Quest’ultima stabilisce standard per colf, baby-sitter e badanti ed è rilasciata dall’Ente Ebincolf, che offre anche un corso di formazione di 64 ore.[1]
Un elemento di cui le linee guida dovrebbero tener conto riguarda dunque la ricerca di una coerenza fra questi tre contesti, con una chiara individuazione degli ambiti di operatività del profilo (processi di lavoro), oltre al necessario aggiornamento nell’Atlante del lavoro, in modo tale da disporre di un quadro condiviso tra le istituzioni coinvolte e le parti sociali per realizzare percorsi formativi coerenti con il profilo e riconoscere le competenze pregresse.
Su queste basi, viene delineato uno standard di qualificazione per assistenti familiari, ovvero di un profilo articolato in competenze e unità di competenze condiviso fra tutte le Regioni e le Province Autonome, nonché di standard formativi condivisi per conseguire la qualificazione.
I principali elementi sono: durata, tenendo conto dei corsi formativi e professionali precedenti, oltre ai requisiti minimi (aver completato la scuola dell’obbligo e avere una conoscenza adeguata della lingua nel caso di persone straniere); articolazione in moduli, che consenta di adottare modalità diverse di erogazione e il riconoscimento di crediti; modalità di didattica mista (blended learning), adatte a persone adulte che lavorano, anche per promuovere l’aggiornamento continuo delle competenze; riconoscimento delle esperienze pregresse, attraverso il sistema nazionale di certificazione delle competenze; elenchi e registri pubblici degli operatori qualificati, con criteri omogenei per l’iscrizione, anche ai fini della mobilità lavorativa.[2]
Nelle raccomandazioni del Cnel, viene precisato che l’urgenza di offrire un contributo al processo – in atto – di definizione delle linee guida ha richiesto un approfondimento su questo specifico aspetto, proponendo però anche una riforma complessiva delle norme che regolano il lavoro domestico in tutte le sue articolazioni – anche per ampliare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e finalizzare il sistema di incentivi fiscali e contributivi volti a far emergere le situazioni di lavoro sommerso e a sostenere le famiglie.
A maggior ragione, tenendo in considerazione che le persone che lavorano come assistenti familiari stanno a loro volta diventando un bene scarso, che sta invecchiando e risentendo dei cambiamenti nei flussi migratori, a fronte di una domanda crescente.
Anche per questo, in attesa che le linee guida vedano la luce, non si può non rilevare l’importanza di dare operatività e concretezza alla valorizzazione, operata dalla legge, del ruolo delle e degli assistenti familiari come elemento chiave di un welfare mix assistenziale in grado di migliorare continuità, prossimità e personalizzazione della domiciliarità.
Note
[1] Per approfondire si rimanda al documento di Osservazioni e proposte su “Linee guida per la formazione degli assistenti familiari” del Cnel, allegato in fondo all’articolo.
[2] Per approfondire si faccia riferimento alle raccomandazioni del Cnel consultabili come allegato.
Osservazioni e Proposte su Linee guida per la formazione degli assistenti familiari.pdf
21/3/2025 https://www.ingenere.it/







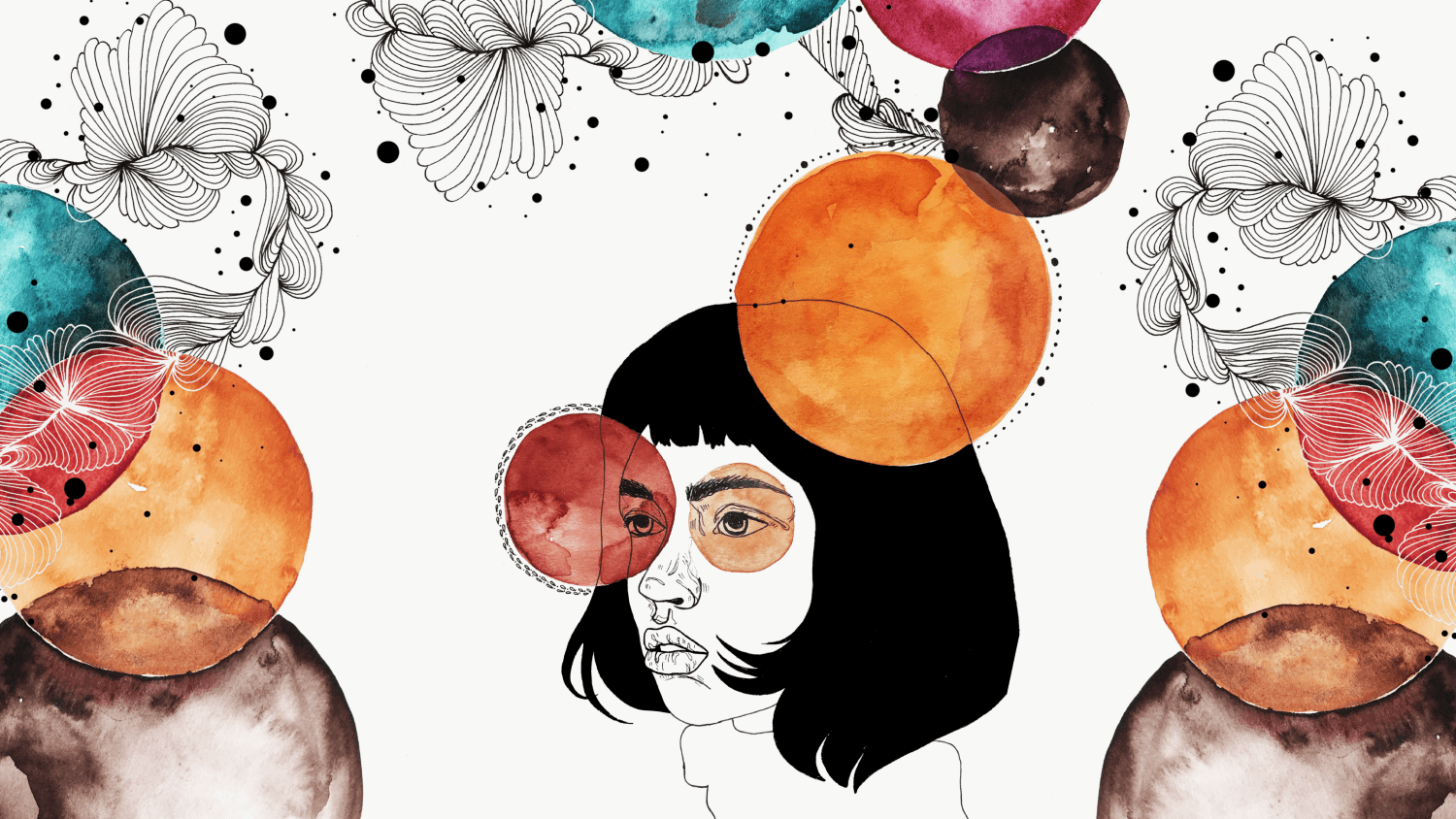


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!