Avanti con la lotta di classe!
È sempre più ampio e aspro il conflitto tra chi vende il proprio lavoro per sopravvivere e chi ne trae profitto. Sta aumentando la non-salute mentale degli sfruttati che, sempre più spesso, crollano. Meglio essere asociali che disumani.
di Marco Sommariva
L’anno scorso, il regista inglese Ken Loach ha rilasciato un’intervista al giornalista Stefano Galeazzi del mensile Altreconomia, che ho trovato particolarmente interessante.
Diversi sono i passaggi che mi hanno indotto a ragionare nuovamente su un argomento che spesso viene ritenuto superato, la lotta di classe.
Il primo è questo: “[…] al centro della nostra società c’è il conflitto tra chi vende il proprio lavoro per sopravvivere e chi ne trae profitto. Ci raccontano la grande bugia che abbiamo un interesse comune, che tutti abbiamo gli stessi problemi e naturalmente non è così. Perché l’interesse di coloro che sfruttano il lavoro, possiedono e controllano le finanze, le industrie, che fanno profitto in un sistema fondato sulla concorrenza è questo: vince chi fornisce i migliori prodotti e servizi al costo più basso sfruttando la forza lavoro. Invece l’interesse della gente comune è rappresentato dall’avere un lavoro sicuro, un reddito sicuro, una casa sicura, cibo sicuro per la propria famiglia. E questi due interessi sono apertamente in conflitto, non possono essere riconciliati, e questo è il conflitto inevitabile che abbiamo. E finché non ne prendiamo atto restano inconciliabili perché è il sistema a richiederlo”.
È vero, i due interessi sono apertamente in conflitto fra loro; diversamente non si spiegherebbe quanto accaduto il mese scorso in una grande ditta ligure: una selezione di trenta giovani di età compresa tra i venti e i trent’anni non sono stati assunti con un contratto a termine della durata di un anno, perché l’azienda in questione è riuscita a sostituire con l’intelligenza artificiale quella che avrebbe dovuto essere la loro mano d’opera. Questa mossa ha permesso di ridurre ulteriormente e drasticamente i costi, reso l’azienda in questione ancor più competitiva di quello che era. Dico che i costi sono stati ridotti ulteriormente perché già la decisione di assumere per dodici mesi i trenta giovani, era stata presa per risparmiare: sarebbero stati lasciati tutti a casa appena terminata la nuova commessa acquisita.
Un altro passaggio del regista che mi è rimasto impresso, è questo: “Siamo ormai in una fase in cui le conquiste come la giornata di otto ore, il posto fisso, il licenziamento per giusta causa, il salario minimo, sono sparite, finite in quella che chiamiamo la gig economy. Il datore può aprire e chiudere il lavoro come un rubinetto. Ovviamente, questo porta grande povertà. E il sistema ti dice che se sei povero è colpa tua. C’è la povertà, ma ti dicono che tutti possono lavorare, che se ti impegni abbastanza c’è un impiego per tutti. Sappiamo che è una bugia, ma loro sono costretti a insistere su questo per evitare che venga messo in discussione il sistema. E quindi è colpa tua e devi essere punito se sei povero. […] Se invece lavori, la lotta per mettere insieme abbastanza soldi per andare avanti con la gig economy e l’insicurezza del lavoro creano una pressione psicologica enorme. Non puoi mai rilassarti. Sappiamo che c’è chi fa due o tre lavori insieme, lavora giorno e notte. Quindi è una pressione psicologica enorme”.
La Treccani spiega così il significato di gig economy: “Modello economico basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo, e non sulle prestazioni lavorative stabili e continuative, caratterizzate da maggiori garanzie contrattuali”.
In effetti, conosco ragazzi e giovani adulti che davvero si sentono in colpa perché, con le loro varie attività che svolgono – dog-sitter, consegne a domicilio, ripetizioni online o a casa, eccetera –, non riescono a raggranellare quanto necessario come, per esempio, rendersi indipendenti dai genitori. Senso di colpa che sempre più spesso tende a ingigantirsi e a sfociare in qualcosa di grave, a volte in tragedia, specie quando inizialmente se n’è sottovalutata la portata; sto parlando di quell’enorme pressione psicologica capace di sfociare nel mare magnum dei problemi inerenti alla salute mentale a cui, guarda caso, fa riferimento sempre Ken Loach nel prosieguo dell’intervista: “Stiamo assistendo a una crisi colossale della salute mentale in Gran Bretagna, una crisi enorme. Non ne capiscono le cause perché non vogliono mettere in discussione il sistema. Dalla destra ai socialdemocratici, che sono i più pericolosi di tutti, perché dicono di rappresentare i lavoratori ma per loro conta solo il profitto. Quindi, il capitalismo deve funzionare, e funzionerà solo se otterranno profitti. Una concorrenza sfrenata significa sempre più sfruttamento. E così la salute mentale, anzi la non-salute mentale è in forte aumento. Le persone crollano, i legami e i matrimoni si rompono, perché non si può vivere sempre sotto pressione dal punto di vista economico. È molto, molto difficile. I lavoratori, se uniti, possono fermare tutto: non siamo noi a dipendere da loro. E la menzogna che accettiamo, che questo sia l’unico modo di organizzare la nostra vita, è disastrosa”.
Il sistema che non si vuole mettere in discussione e il capitalismo che “deve funzionare”, basano la propria sopravvivenza su un consumismo sfrenato e dopato che aumenta la pressione psicologica di cui sopra. Un esempio di consumismo dopato? Eccovelo. Andando a parlare nelle scuole in veste di scrittore contemporaneo, con studenti e studentesse si affrontano tanti discorsi, dei più svariati; è capitato che uno di questi riguardasse le scarpe costosissime che adolescenti e non solo vogliono avere ai piedi e, mentre un ragazzino di una prima superiore denunciava molto timidamente il fatto d’esser stato messo da parte dai compagni di classe per le “scarpe da pezzente” che indossava, un altro vantava a testa alta di potersele permettere grazie al secondo lavoro svolto da suo padre, che era quello di spacciare cocaina, giuro, ha detto proprio così – una volta salutati gli studenti, gl’insegnanti presenti all’incontro mi hanno confermato quanto riferito dai due studenti, l’istituto scolastico conosceva entrambe le realtà famigliari.
L’intervista di Altreconomia al regista inglese ci mette a conoscenza di una sua idea che ha a che vedere con la lotta di classe: “[…] riconoscere che questa società si basa sulla lotta di classe e organizzarsi nei sindacati, sul lavoro e difendere le scuole, i servizi e unirsi, perché finché siamo isolati all’interno di questa comunità, di quel sindacato, di quel Paese e non creiamo dei legami non succede nulla. […] la nostra forza è la solidarietà. I lavoratori, se uniti, possono fermare tutto: non siamo noi a dipendere da loro. E la menzogna che accettiamo, che questo sia l’unico modo di organizzare la nostra vita, è disastrosa”.
Certo è che la prima cosa di cui si sente l’assenza è proprio l’unità fra i lavoratori, e qui preferisco non spendere parole nel raccontarvi le decine di episodi vissuti in oltre quarant’anni di lavoro, dove protagonista è la sfacciataggine con cui, per un misero aumento o avanzamento di carriera, un lavoratore frega decine di colleghi – ci tengo ad assicurarvi che, spesso, l’ignoranza del soggetto rampante c’entra poco o niente.
A proposito, scriveva ne Il nostro programma Errico Malatesta: “L’ignoranza fa sì che gli uomini non conoscano le cause dei loro mali e non sappiano rimediarvi, e per distruggere l’ignoranza bisogna che gli uomini abbiano il tempo ed il modo d’istruirsi”. Sarà mica per questo, perché non si sia più in grado di risalire alle cause dei propri mali, che abbiamo ridotto molti studenti ad arrivare all’università, anche università molto selettive e considerate d’élite, senza più la capacità di leggere libri? https://www.internazionale.it/notizie/rose-horowitch/2025/01/07/lettura-libri-studenti
Personalmente, rimpiango quella palpabile solidarietà che faceva da collante fra i lavoratori durante gli anni Settanta e i primi anni Ottanta, così come sento la mancanza di una certa letteratura capace di raccontare lavoratori in lotta contro sfruttamento, miseria e alienazione: “Diciamo Sì alla violenza operaia. Perché siamo noi proletari del sud noi operai massa questa enorme massa di operai noi centocinquantamila operai della Fiat che abbiamo costruito lo sviluppo del capitale e di questo suo Stato. Siamo noi che abbiamo creato tutta la ricchezza che c’è e di cui non ci lasciano che le briciole. Abbiamo creato tutta questa ricchezza crepando di lavoro alla Fiat o crepando di fame nel sud. E adesso noi che siamo la grande maggioranza del proletariato non ne abbiamo più voglia di lavorare e di crepare per lo sviluppo del capitale e di questo suo Stato. Non ne possiamo più di mantenere tutti sti porci” – Vogliamo tutto di Nanni Balestrini.
Sia chiaro, al sottoscritto andrebbe benissimo che la violenza operaia citata nel romanzo di Balestrini fosse espressa, oggi, con l’impeto di parole capaci di dare forza a discorsi di riscatto, concetti di rivolta, dare forma costruttiva a quel furore che, terminata la giornata lavorativa, portiamo quotidianamente fra le mura domestiche perché non abbiamo saputo o potuto smaltirlo sullo stesso posto di lavoro che, molto gentilmente, ce ne ha fatto generosamente dono.
Anche perché, scusate questa mia convinzione, sono le parole esplosive a poter uccidere questo sistema, non altri generi di deflagrazioni capaci solo di produrre martiri tra i defunti e demoni fra i bombaroli. Poi ognuno intraprenda la metodologia che più gli si confà, ci mancherebbe: non ho mai ritenuto la mia lotta essere di serie A e le altre di serie B.
C’è tanta letteratura che può aiutare un lavoratore, una lavoratrice a non commettere errori, a dare forza e forma a ciò che ha già in testa senza che, magari, se ne sia neppure reso conto; leggete cosa scriveva Jack London sulla lotta di classe, oltre un secolo fa, nel romanzo Il tallone di ferro: “È un vecchio trucco, come la lotta di classe, che consiste nello scegliere i propri capitani togliendoli all’esercito del nemico. Poveri lavoratori eternamente traditi! Sapessi quanti sindacalisti, in passato, sono stati comprati così! Costa meno, molto meno assoldare un generale, che non affrontarlo con il suo esercito e combatterlo”.
Lo stesso libro – notare bene, edito nel 1907! – ci dice qualcosa sul sistema capitalistico: “Quando ogni paese si troverà in possesso di beni in eccedenza inconsumabili e invendibili, il sistema capitalistico crollerà sotto l’enorme peso dei profitti che ha accumulato”.
Il tallone di ferro racconta una società dominata dal profitto, da un’oppressione generalizzata che non lascia scampo; un libro che influenzò non poco l’iniziale formazione socialista di Mussolini il quale, quando fu al potere, non a caso ne vietò la ristampa e la diffusione.
Ancora dal romanzo di Jack London: “Mio padre fu marchiato come anarchico e nichilista […]. Venne aspramente attaccato da tutta la stampa, in lunghi e spietati articoli, per la sua anarchia e furono fatte allusioni a una sua incipiente follia. Questa tattica, ci informò Ernest, non era una novità da parte della stampa capitalistica, che inviava di solito i suoi cronisti a tutte le riunioni socialiste, con l’ordine di alterare e svisare ciò che veniva detto, per spaventare la borghesia e distoglierla da ogni idea di una possibile unione col proletariato”.
La stampa che spaventa la borghesia per distoglierla da ogni idea di una possibile unione col proletariato, potrebbe essere la stessa stampa di destra nominata ancora da Ken Loach, nell’intervista citata prima: “Le persone sono state incoraggiate dalla stampa di destra a essere razziste cadendo nella trappola secondo cui il motivo per cui non hanno un buon lavoro è che ci sono gli immigrati che glielo portano via. Ma ovviamente non è affatto vero. Sono senza lavoro perché le miniere di carbone sono state chiuse, noi come società non abbiamo costruito nuove industrie dove ci sarebbe stato un buon lavoro qualificato, buoni salari, un’occupazione sicura, per produrre cose di cui la gente ha bisogno. E ci sono molte cose di cui abbiamo bisogno. C’erano buone comunità, avevano solo bisogno di lavoro. Si sarebbe potuto fare, ma è mancato l’investimento pubblico. Nella mente dei socialdemocratici e della destra, gli investimenti sono possibili solo se qualcuno può trarne profitto, non si possono fare “collettivamente”. Dall’altro lato ci sono le persone che arrivano. Gente comune, che spesso soffre per le guerre che noi, certamente in Gran Bretagna, abbiamo creato, come quella in Iraq e nell’intera area che noi chiamiamo Medio Oriente. E il modo in cui usiamo il linguaggio racconta la nostra storia coloniale: per un cittadino iracheno o palestinese è il centro, altro che Medio Oriente. Noi non accettiamo le nostre responsabilità e i governi alimentano l’ostilità contro i rifugiati generando razzismo. Questo va a favore della classe dirigente perché viene usato per dividerci. Se le persone nel nostro Paese dicono: non vogliamo i profughi, non ci piace la loro cucina, non ci piace il colore diverso della loro pelle, non ci piace il loro modo di vestire, in un certo senso ci impedisce di guardare chi veramente sta causando i nostri problemi”.
E sì, anche la stampa, i media, i Social, fanno la loro parte in questa battaglia, ed è dura regger botta contro tutti i nemici esterni che remano contro la realizzazione di una lotta di classe ben strutturata, ma è dura anche per via dei nemici interni: quante volte ci siamo scoperti del tutto impreparati ad affrontare la cruda realtà perché il nostro anticapitalismo, antifascismo, antirazzismo, antisessismo s’è rivelato puramente estetico e culturale, e non politico? Al riguardo, racconta qualcosa Pier Paolo Pasolini nel libro Pasolini su Pasolini, che raccoglie le conversazioni realizzate nel 1968 fra il giornalista e storico inglese Jon Halliday e lo scrittore e regista romano: “Nell’immediato dopoguerra i braccianti erano impegnati in una massiccia lotta contro i grandi proprietari terrieri del Friuli. Per la prima volta in vita mia, mi trovai, fisicamente, del tutto impreparato, e questo perché il mio antifascismo era puramente estetico e culturale, non politico. Per la prima volta mi trovai di fronte alla lotta di classe, e non ebbi esitazioni: mi schierai subito con i braccianti. I braccianti portavano sciarpe rosse al collo, e da quel momento abbracciai il comunismo, così, emotivamente. Poi lessi Marx e alcuni dei pensatori marxisti”.
A difesa della lotta di classe ho citato Ken Loach per i giorni nostri e Jack London per l’inizio del secolo scorso, ma nel mezzo non c’è stato di certo il silenzio.
Nel 1946 furono molti i cronisti che accorsero in Germania per raccontare quel che restava del Reich finalmente sconfitto; dal coro di voci si distinse quella di uno scrittore svedese di ventitré anni, intellettuale anarchico e narratore dotato di una sensibilità fuori dal comune, inviato lì dal quotidiano svedese Expressen per realizzare una serie di reportage poi raccolti in un libro, Autunno tedesco. Mentre le testate di tutto il mondo offrivano il ritratto preconfezionato di un paese distrutto, Stig Dagerman si muoveva fra le macerie di Amburgo, Berlino, Colonia e Francoforte, su treni stipati di senzatetto e in cantine allagate dove vivevano masse di tedeschi affamati e disperati, cercando di capire la sofferenza dei vinti. Ne emerse un quadro molto più complesso di quello che era comodo figurarsi; leggete cosa scrisse a difesa della lotta di classe: “[…] le bombe inglesi hanno ignorato i confini di classe (anche se i quartieri delle ville, meno densamente popolati, hanno senz’altro riportato danni minori degli agglomerati di case), bisogna però aggiungere, a difesa della lotta di classe, che i conti in banca non sono stati bombardati”.
Spero di non essermi perso nei mille rivoli che nascono da questo fiume in piena che è, appunto, l’argomento “lotta di classe”, e di essere riuscito a comunicare qualcosa di utile; prima di chiudere, però, desideravo ricordare una frase del filosofo belga Raoul Vaneigem, riportata nel suo Trattato del saper vivere, una lettura fondamentale per la spietata attualità della sua critica alla società dei consumi e del controllo mediatico: “Quelli che parlano di rivoluzione e di lotta di classe senza riferirsi esplicitamente alla vita quotidiana, senza comprendere ciò che c’è di sovversivo nell’amore e di positivo nel rifiuto delle costrizioni, costoro si riempiono la bocca di un cadavere”.
E allora, dài!, avanti con la lotta di classe, con la rivoluzione! Iniziamo a rivoluzionare la nostra vita quotidiana, incominciamo a rifiutare certe costrizioni, tipo l’obbligo di avere scarpe costose ai piedi per essere accettati. Vi diranno che siete inadatti, asociali? Rispondete loro con le parole di Stig Dagerman: “[…] quando le forme della società si fanno dure e negano la vita, è meglio essere asociali che disumani” – La politica dell’impossibile.







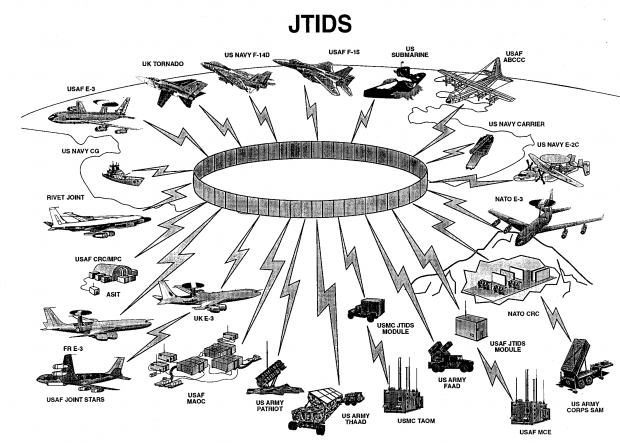

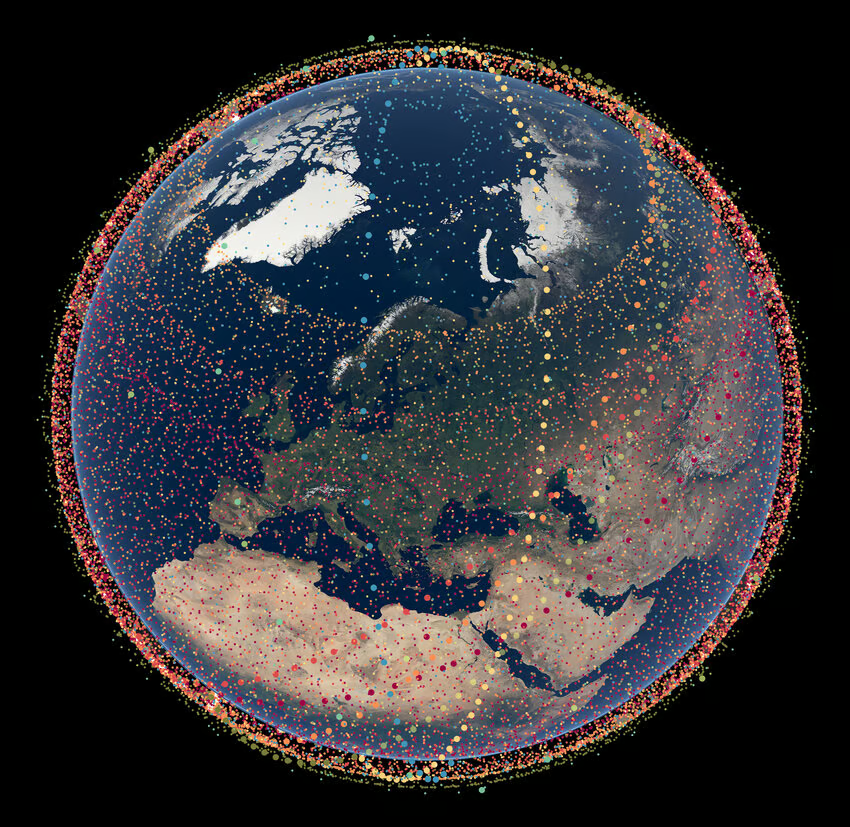
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!