Capitalismo digitale
Dialoghi. Lavinia Hanay Raja, ricercatrice indipendente e femminista, ci racconta perché tutte dovremmo prendere coscienza dei meccanismi di sorveglianza che si celano dietro le tecnologie digitali che utilizziamo tutti i giorni
Qual è la relazione tra tecnologie e violenza di genere e quali sono gli strumenti femministi per contrastare le nuove forme di controllo e oppressione nei confronti delle donne e delle persone diverse dai maschi bianchi nel contesto digitale? L’abbiamo chiesto a Lavinia Hanay Raja, femminista queer del collettivo Ippolita, un gruppo di ricerca indipendente che dal 2005 si occupa di culture digitali.
“In questi anni mi sento molto vicina alla sensibilità dei nuovi movimenti transfemministi e alle loro compagini più propriamente trans e non binarie” ci racconta. “La mia cultura tecnologica si è formata nell’hacklab Reload a Milano, mentre studiavo avidamente Haraway, Braidotti e Deleuze”.
Con Ippolita avete pubblicato diversi libri sugli effetti politici e sociali delle tecnologie che sono stati tradotti anche all’estero, qual è stato il risvolto più importante di questa attività e qual è la vostra linea editoriale?
Le pubblicazioni di Ippolita hanno contribuito a creare nel nostro paese una sponda critica dell’informatica che fosse in collegamento con il dibattito più avanzato e di ricerca. Il nostro approccio autoriale è interdisciplinare: i saperi tecnici si intersecano con quelli umanistici, dando vita a un’analisi tecno-politica orientata a una visione antiautoritaria dei saperi scientifici. Da qualche anno curiamo anche una serie di collane di libri con un taglio intersezionale.
Puoi farci qualche nome delle autrici che avete pubblicato e che state pubblicando, anche per dare un’idea a chi ci legge del tipo di scritture che state portando in Italia?
Abbiamo portato in Italia la trilogia sulla scuola di bell hooks e le opere di filosofia della tecnica di Bernard Stiegler, ma anche Gloria Anzaldua e Audre Lorde, e le analisi tecnologiche di Simone Browne e Alexander Galloway. Dal lavoro del collettivo sulle tecnologie sono nati inoltre dei percorsi formativi che stanno coinvolgendo le accademie di belle arti, chi si occupa di accompagnamento delle persone civili nelle aree di conflitto, o lavora nell’ambito della psicologia e della psicoterapia, nell’accompagnamento delle persone minori (e adulte) all’uso consapevole degli strumenti digitali, nella formazione per i centri antiviolenza. In alcuni casi, per fare formazione usiamo il metodo del gioco di ruolo.
Qual è secondo te il nesso più pericoloso fra tecnologie e violenza contro le donne?
I nessi fra queste due aree sono molti, ma per fare un’analisi completa occorre avere ben chiare almeno tre caratteristiche strutturali delle tecnologie digitali per come sono stata concepita: la sorveglianza, la cultura del rischio e la gamificazione. Questi elementi relativi ai modelli di business vengono implementati nel design commerciale, creando forme di violenza sistemica contro le donne e tutti i soggetti già inferiorizzati dalla cultura patriarcale. Gli strumenti tecnologici attualmente più usati si basano sulla sorveglianza e avvantaggiano le applicazioni dedicate al controllo diffuso: domestico, parentale, di coppia, di quartiere, eccetera. In questo modo viene promossa nella società, già fortemente securizzata, una vera e propria cultura del controllo, che si accompagna sempre più spesso a una retorica della cura come presa in carico morale della società.
Perché oggi è così importante rendere visibile questo legame?
Shoshana Zuboff ha definito l’attuale capitalismo tecnologico come “capitalismo della sorveglianza”, una logica estrattivista basata sul monopolio di un gruppo ristretto di aziende focalizzate sull’accumulo smodato di capitale e in costante crescita. La violenza digitale contro le donne si sviluppa dunque in un contesto favorevole, sia per l’ampiezza dell’offerta commerciale di app di sorveglianza, che per via del fatto che il controllo non viene riconosciuto come coercitivo, ma è normalizzato dalle pratiche tecnologiche quotidiane.
Stai parlando dell’accesso ai dati personali e di come questi vengono raccolti e gestiti?
Tutti i servizi e le applicazioni web si basano sull’identificazione minuziosa, il controllo pervasivo e la raccolta massiva dei dati dell’utenza. Il fatto che, ad esempio, nel capitalismo della sorveglianza non ci sia alcuna differenza tra persone adulte e bambine ci fa capire il livello di fragilizzazione a cui siamo esposte già dall’infanzia. In ambito tecnologico, e in particolare per quanto riguarda i nessi fra tecnologie e violenza di genere, è importante riconoscere che il controllo è una tipologia di violenza e che va per questo contrastata in tutte le sue forme. Il secondo e il terzo elemento che contribuiscono a creare forme immanenti di violenza sono la cultura del rischio e la gamificazione, residui della cultura neoliberale che si infiltrano in tutta la nostra vita “onlife”.
Esattamente, in che modo avviene tutto questo?
Per mezzo della numerificazione delle esperienze, cioè dell’attribuzione di un punteggio espresso in numeri, veniamo educate a produrre una narrazione parossistica della nostra identità e della realtà che ci circonda. L’innesco necessario per alimentare i contesti gamificati nei quali siamo immerse è la competizione. La gamificazione mutua le regole dei giochi competitivi in contesti che non sono di gioco, celando la propria capacità di manipolazione, e diventando di fatto una forma di abuso. Attraverso l’automatismo del gioco, che stimola la dopamina catturandoci nell’astrazione ambientale, le pratiche di controllo vengono trasformate in fonti di piacere.
E quali sono le conseguenze più significative?
L’obiettivo del mercato relazionale aperto con le nuove tecnologie è il self branding, che, di fatto, è una pratica di reificazione del sé, in cui cerchiamo di aderire il più possibile ai modelli dominanti di bianchezza, procacità sessuale, magrezza, capacità economica, eccetera. Che si tratti del rating su Airbnb o di Tinder, tutto concorre a stimolare l’attenzione e la paura di perdere il proprio capitale, sia esso economico o reputazionale. In alcuni casi, abbiamo chiamato foucaultianamente questa sovrapposizione “reddito psichico”. L’illusione è che, se siamo abbastanza spregiudicate, la tecnologia funzionerà come ascensore sociale.
All’interno di questo processo, qual è o dovrebbe essere il ruolo del femminismo?
La cultura del controllo e del rischio sono proprie di un modello di società machista e coloniale, in cui la proprietà delle persone in qualità di oggetti e l’adrenalina della scommessa costituiscono i presupposti in cui sono immerse le tecnologie. Tecnologie i cui titoli borsistici non conoscono flessione. Per questo è molto importante che, come femministe, ci interroghiamo su come le tecnologie sostengano forme di violenza epistemica e concretizzino sistemi di subordinazione delle donne e di tutte le soggettività inferiorizzate. È urgente una critica transfemminista delle tecnologie che non si limiti ai contenuti da veicolare all’interno dei contesti digitali, ma che metta in discussione come questi contesti sono progettati e il funzionamento delle infrastrutture che li sorreggono.
Abbiamo imparato dalla storia dei centri antiviolenza che avere una metodologia femminista e una lettura politica della violenza contro le donne è fondamentale per i percorsi di fuoriuscita da situazioni di violenza. Cosa significa avere una metodologia femminista nel contrasto alla violenza digitale contro le donne?
Come gruppo di ricerca Ippolita, da tempo siamo state coinvolte dai centri antiviolenza per immaginare insieme una formazione che fosse utile a comprendere le trasformazioni della violenza di genere in ambito digitale, con l’obiettivo di attivare degli strumenti concreti. I percorsi più duraturi sono quelli che abbiamo aperto con la cooperativa Iside di Venezia, con la quale siamo arrivate a capire che, oltre a una formazione tecnologica orizzontale per tutte le operatrici, occorre ragionare su una figura professionale specifica. Infatti, come ci si avvale della presenza di una psicologa, bisognerebbe avere un’operatrice formata sulle competenze tecnologiche.
Quali sono gli strumenti che le pratiche di contrasto alla violenza tradizionali dovrebbero integrare per far fronte ai linguaggi emergenti?
Vanno migliorate le infrastrutture dei singoli centri antiviolenza, gli strumenti di lavoro digitali vanno adeguati alle esigenze di ogni centro. Con Alexia Papapietro, operatrice e antropologa di Perugia, abbiamo cominciato a lavorare su un protocollo di accoglienza tecnica delle donne che si rivolgono agli sportelli. Sarebbe molto importante saper fare una valutazione dei rischi che la persona corre, o potrebbe correre, da un punto di vista digitale nel momento in cui chiede aiuto. Valutazioni che vanno continuamente aggiornate e rese disponibili alle operatrici di tutta la rete nazionale. Certamente lo sportello antiviolenza di Lucha y siesta e la piattaforma italiana di Chayn costituiscono una punta avanzata nella ricerca di percorsi che includano attenzione, o anche la massima attenzione, all’aspetto tecnologico.
Cos’è che non sta funzionando nelle modalità di contrasto alla violenza online usate finora?
Dal punto di vista della metodologia femminista applicata alle questioni digitali, è evidente che il “soluzionismo” tecnico non funziona. La violenza tecnologica non si può correggere come se fosse un bug. I problemi sono sempre politici prima che tecnici, e come tali vanno affrontati. Il suprematismo degli informatici che “risolvono” è parte del problema che ci ha portate all’attuale stato di subalternità nei confronti della tecnica e della scienza. Occorre quindi partire dall’ascolto reciproco e tenere a mente che ogni “soluzione” è sempre situata, circostanziale e temporanea. In generale, scontiamo però anche il mancato appuntamento dei movimenti transfemministi con le tecnologie.
Che cosa si potrebbe fare per riappropriarci delle tecnologie?
Ognuna di noi – individualmente ma anche nei collettivi e nelle organizzazioni – dovrebbe cominciare un percorso di disidentificazione nei confronti degli strumenti che usiamo ogni giorno. Le alternative non solo esistono, ma possiamo costruirne di più adeguate alle nostre esigenze. Si tratta di affrontare il tema, consapevoli che la comfort zone è una trappola consumistica. Non è un caso che, all’interno dei movimenti femministi, siano i centri antiviolenza a riprendere parola sulla tecnologia, perché è nella condizione esistenziale della fragilità, dove la “bolla” sociale collassa, che le responsabilità della tecnologia emergono. La tragedia della sofferenza e della morte, il rapporto con il limite, sia delle risorse computazionali che di quelle biologiche ed emotive dei corpi, diventano il punto di partenza inevitabile della negoziazione con gli strumenti digitali.
Oggi i dati ci dicono che la relazione fra tecnologie e donne è debole dal punto di vista delle competenze e della formazione, ma è molto forte a livello di esposizione. Quali sono i rischi? Possiamo parlare di autodeterminazione tecnologica o di autodifesa digitale?
C’è un problema specifico che riguarda la sfera sesso-affettiva e come si è trasformata a contatto con questo modo digitale complesso e compromesso dalla pervasività commerciale. La sessualità che si sperimenta mediante gli strumenti tecnologici è vera sessualità, nel senso che non va subordinata a un’altra che dovrebbe essere più reale in quanto sganciata dal digitale, così come le relazioni non sono edulcorate o di minor valore. Nella vita così coercitivamente connessa occorre avere un approccio antiproibizionista e promuovere una cultura di pratiche sessuali più sicure di quelle che ci vengono offerte di default e che ci espongono al rischio della violenza.
C’è un alfabeto che le ragazze oggi dovrebbero assolutamente conoscere?
Assieme all’approccio critico nei confronti delle tecnologie, bisogna avere una nuova visione della sessualità che includa la tecnologia come “corpo”, cioè come elemento somato-psichico che diventa parte della nostra unità emotiva. Le macchine diventano simbiotiche alla nostra intimità pur rimanendo un apparato estrattivo. Paradossalmente, occorre conoscere l’alfabeto emotivo delle macchine per fare in modo che l’esperienza sia posta al vaglio del nostro consenso.
Ormai si parla di violenza digitale anche nei contesti di policy, da UN Women alla Commissione europea…
La violenza digitale contro le donne non riguarda solo la fenomenologia degli attacchi diretti, il cui numero è in continuo aumento, ma è sistemica. Può essere contrastata più efficacemente se viene affrontato il modo in cui le tecnologie di comunicazione vengono progettate. Va tenuto presente che gli strumenti della comunicazione assolvono a questo compito per una percentuale risibile delle loro funzioni, essendo in realtà strumenti di sorveglianza, come gli studi sui media di ultima generazione ci hanno ampiamente illustrato. Le grandi aziende tecnologiche vanno messe di fronte al fatto che questo modello economico è manipolatorio e crea forme immanenti di violenza, e dunque a un processo di responsabilità e riparazione. Come abbiamo già detto, il controllo è una forma di violenza, e i soggetti già bersaglio di prevaricazione e abusi vengono ulteriormente fragilizzati da questa infrastruttura che normalizza l’esposizione mediatica.
Quali possono essere esempi o idee di politiche di contrasto sia dall’alto che dal basso?
Pur essendo descritte come neutrali o progressiste, le nuove tecnologie riproducono ed esacerbano la disuguaglianza storica. Il capitalismo della sorveglianza è stato imposto in una quindicina d’anni dalle grandi aziende, che costituiscono un blocco monopolistico impegnato nel rendersi indispensabili anche nella vita delle governance statali. Con il Covid ne abbiamo visto all’opera la testa d’ariete, e le richieste di aiuto ai centri antiviolenza sono aumentate considerevolmente. Occorre avviare un processo di “coscientizzazione” delle donne, che non sia solo relativo all’uso – tutte sappiamo usare questi strumenti: le interfacce prevedono un carico cognitivo molto basso, poiché il loro consumo deve essere industrialmente globalizzato e disponibile fin dalla più tenera età.
Che vuol dire “coscientizzarsi”?
Coscientizzarsi significa saper problematizzare la propria posizione situata e discernere le motivazioni intrinseche dei prodotti digitali che ci vengono offerti gratuitamente. Le donne devono poter riconoscere la violenza che abbiamo normalizzato attraverso l’uso quotidiano di questi strumenti. Al contempo, occorre avviare progetti di riduzione del rischio e del danno non colpevolizzanti, che includano una nuova cultura della sessualità con una specifica formazione per le operatrici, per chi si occupa di educazione e accompagnamento di persone minori.
Barbara Leda Kenny
11/6/2024 https://www.ingenere.it/




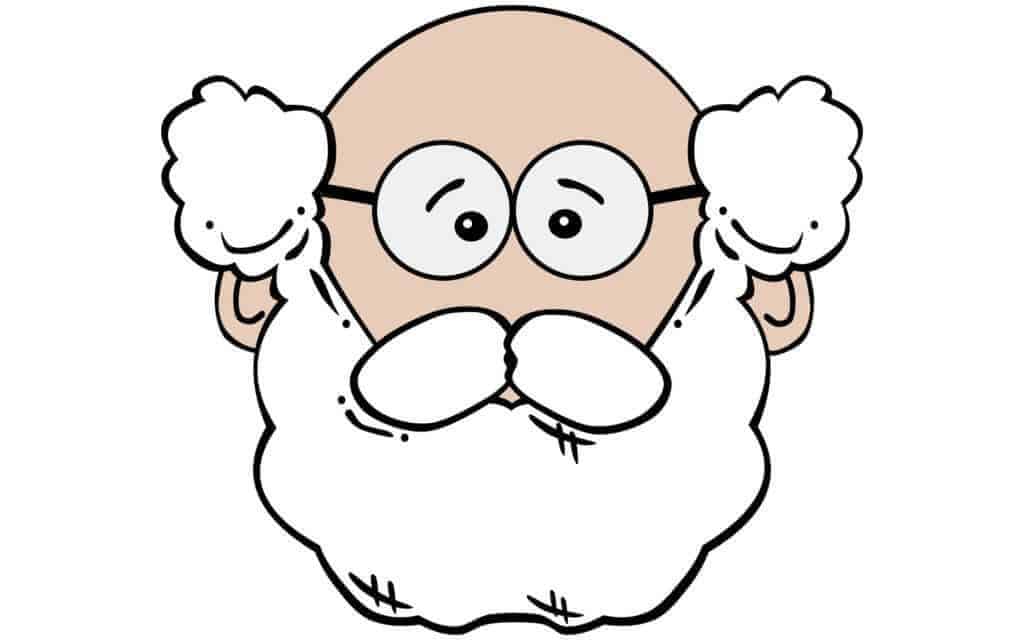





Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!