Che c’è dopo il neoliberismo?
Cédric Durand
Daniel Finn
L’economista Cedric Durand analizza la fase che si apre dopo la lunga turbolenza seguita alla crisi del 2008 e alla pandemia, segnata dal predominio del capitale finanziario che lascia il campo a un nuovo scontro interimperiale, alta inflazione ed emergenza climatica
L’economista francese Cédric Durand, autore di Fictitious Capital: How Finance Is Appropriating Our Future e di How Silicon Valley Unleashed Techno-Feudalism, ritiene che la tanto attesa fine del neoliberismo sia finalmente vicina. Dopo il crollo del 2008, la finanza si è affidata al sostegno dello Stato per rimanere in piedi, gli Stati uniti hanno iniziato a minare le istituzioni economiche globali che hanno tanto contribuito a creare e c’è stata una rinascita della politica industriale mentre i governi si scontrano con i limiti del mercato. Alcuni aspetti dell’emergente ordine post-neoliberale creano condizioni promettenti per i lavoratori e per la società, ma l’intensa competizione tra Stati uniti e Cina potrebbe avere pericolose conseguenze geopolitiche.
Come distingueresti, in termini generali, l’era neoliberista dalle fasi precedenti dello sviluppo del capitalismo?
Se confrontiamo l’era neoliberista con l’era del capitalismo del dopoguerra, talvolta definita «età dell’oro», possiamo caratterizzarla attorno a tre pilastri. Il primo è la finanziarizzazione, con l’aumento dei redditi derivanti dalla finanza e l’egemonia degli interessi finanziari sulla politica. Il secondo è la liberalizzazione, un cambiamento globale delle regole per favorire i mercati, sia all’interno che all’esterno dei vari paesi attraverso la liberalizzazione del commercio e degli investimenti. Di cui un aspetto importante è la liberalizzazione dei mercati del lavoro, che ha portato a un calo significativo del potere contrattuale dei sindacati. Il terzo pilastro è la globalizzazione, con l’aumento della portata delle importazioni e lo sviluppo di catene globali del valore. Ciò ha comportato una pressione salariale soprattutto sui lavoratori del settore manifatturiero.
Alla base del neoliberismo c’è una forte enfasi ideologica sulle virtù della concorrenza. L’agenda neoliberale tra gli anni Ottanta e la crisi finanziaria del 2008 è stata fondamentalmente una forma di politica attiva che ha sostenuto l’iniziativa privata orientata al profitto. Il rovescio della medaglia di questa caratteristica è stata l’ostilità verso la regolamentazione del mercato, lo Stato sociale e la politica industriale. A livello internazionale, ciò ha comportato il rafforzamento dei diritti di proprietà e una profonda integrazione globale, che è andata oltre le regole del commercio e degli investimenti per includere standard e convergenze normative.
Per i paesi del Sud globale, c’è stata una forte pressione per ridurre lo stato di sviluppo sotto la minaccia delle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e delle condizioni imposte dalle istituzioni finanziarie internazionali. Lo abbiamo visto nella crisi latinoamericana degli anni Ottanta, nelle riforme post-sovietiche in Europa orientale e nella crisi finanziaria asiatica di fine secolo. In tutti questi casi, la Banca mondiale e soprattutto il Fondo monetario internazionale sono intervenuti per promuovere un’ agenda fortemente neoliberista.
Quali sono stati, secondo te, gli sviluppi più importanti per il sistema capitalistico mondiale tra il crollo del 2008 e l’inizio della pandemia da Covid-19?
Se ci concentriamo sulla politica economica, due elementi principali sono cruciali.
Il primo è che le banche centrali sono dovute intervenire come mai avevano fatto prima per quanto riguarda il sistema finanziario. C’è stato il quantitative easing e la promessa di Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea, di fare «whatever it takes» per sostenere l’euro. Il ruolo delle banche centrali è diventato fondamentale per sostenere il settore finanziario, poiché la finanza non era in grado di autosostenersi. Più a fondo, l’idea di un sistema globale con un coordinamento stabile basato sui mercati finanziari è svanita. Da allora, i prezzi finanziari sono stati determinati politicamente dalle banche centrali senza più la pretesa che i mercati potessero allocare in modo efficiente le risorse e guidare il processo di accumulazione. Il mito di un sistema di mercato che si autoregola, una volta stabilite le norme, si è esaurito.
Il secondo importante sviluppo è il cambiamento della posizione degli Stati uniti nei confronti della globalizzazione. Washington si è costantemente allontanata dalla posizione favorevole dei decenni precedenti. Nella Wto, ad esempio, l’amministrazione Obama ha smesso di nominare persone nell’organismo di Appello già nel 2011. Dal 2019, non ci sono stati abbastanza giudici per far funzionare il meccanismo di risoluzione delle controversie della Wto, quindi Washington, dopo la lunga lotta a partire dagli anni Settanta per creare una specifica architettura, l’ha eliminata.
Perché lo ha fatto? L’amministrazione Obama ha spiegato di essere frustrata dall’incapacità della Wto di contenere la Cina. Non erano soddisfatti del fatto che le sue decisioni non sostenessero le misure a difesa dei produttori statunitensi dalle importazioni cinesi e ritenevano che tali decisioni non riconoscessero il livello di sostegno statale che la Cina forniva alle sue aziende.
Ci sono altri esempi che potremmo citare. Nelle relazioni tra Stati uniti ed Europa, abbiamo assistito alla fine del Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (Ttip), che aveva lo scopo di approfondire lo spirito della globalizzazione. La dichiarazione più chiara delle motivazioni alla base di questo allontanamento dall’ordine mondiale neoliberale è venuta da Brian Deese, il dirigente della Black Rock che Joe Biden ha nominato direttore del Consiglio economico nazionale. Deese ha affermato che non esiste una soluzione basata sul mercato in grado di fronteggiare l’ascesa della Cina.
Che impatto ha avuto la pandemia sulla gestione del capitalismo globale e, in particolare, pensi che abbia lasciato delle eredità, al di là dell’approccio di gestione immediata della crisi adottato nel 2020?
In primo luogo, c’è stata allora una sensazione popolare molto diffusa che l’economia non rappresentasse tutto e che lo Stato dovesse intervenire per affrontare questioni più importanti. In questo senso, ci siamo trovati un po’ come in una guerra. Questo ha creato un contesto in cui si potevano immaginare altri modi di organizzare l’economia. Anche se quello stato d’animo non è paragonabile a quanto provato nel corso delle guerre mondiali del secolo scorso, è stato in ogni caso il momento più drammatico almeno per una generazione. Credo che avrà un effetto significativo sulla coscienza delle persone e sul loro senso delle possibilità politiche. In secondo luogo, e più concretamente, è stato possibile elaborare un’agenda sulla necessità di resilienza a livello statale e sull’importanza dei piani di emergenza, guardando strategicamente alle catene di approvvigionamento e chiedendosi quali forme di lavoro siano essenziali. L’esperienza di aver valorizzato il lavoro e i beni in modo diverso dalla sola valutazione monetaria è stata molto importante. Temo che non lascerà un’impronta duratura sul modo di pensare della gente, ma noi, a sinistra, dobbiamo puntare sul fatto che quello è stato un momento di verità riguardo alle questioni economiche. Il terzo punto riguarda la definizione delle politiche. Isabella Weber ha svolto un lavoro fondamentale nello spiegare perché i prezzi dei prodotti e dei servizi essenziali non dovrebbero essere lasciati al mercato. Esiste un’argomentazione relativa al controllo dei prezzi, alla gestione delle forniture e all’uso di tali strumenti per affrontare gli shock interni che prima della pandemia non veniva affatto ascoltata. Non è ancora un’argomentazione mainstream, ma ora è molto più facile spingere in questa direzione. Questo ha molte implicazioni per il futuro, soprattutto per quanto riguarda la trasformazione ecologica.
Come valuti il programma di politica economica dell’amministrazione Biden nel suo intero mandato? In che modo si è differenziata dalla gestione economica di Bill Clinton negli anni Novanta o di Barack Obama dopo il 2008?
Dobbiamo essere chiari fin dall’inizio sul fatto che ci sono state molte continuità. Non c’è stata alcuna trasformazione ecologica. In termini di disuguaglianza, non c’è stato alcun cambiamento drammatico, nonostante la retorica. Sul piano internazionale, l’amministrazione Biden è stata molto aggressiva, soprattutto nel sostegno a Israele.
Tuttavia, ci sono state differenze sostanziali nella politica economica tra Clinton e Obama, da un lato, e Biden, dall’altro. Durante l’era Clinton, è stata posta una forte enfasi sul pareggio di bilancio. Sotto Biden, nonostante le pressioni interne, il Tesoro ha deciso di mantenere un significativo deficit pubblico, giustificando questa scelta come una forma di economia ad alta pressione, utilizzando una spesa più elevata da parte del governo federale per sostenere ed espandere l’occupazione.
Un altro punto di differenza è stata la posizione esplicitamente pro-sindacale di Biden, che si è manifestata quando si è presentato al picchetto dei lavoratori dell’auto in Michigan nell’autunno del 2023. L’esatto opposto della famosa reazione di Ronald Reagan allo sciopero dei controllori di volo del 1981. Nell’ambito della politica antitrust, è stata importante la nomina di Lina Khan a capo della Federal Trade Commission. Khan è stata molto aggressiva contro le Big Tech, allontanandosi da una consolidata regolamentazione antitrust in genere molto favorevole alle grandi aziende e per cui il controllo statale è molto difficile.
Il sociologo economico Fred Block ha pubblicato recentemente una ricerca secondo la quale esisterebbe, negli Stati uniti, uno Stato nascosto orientato allo sviluppo che opera attraverso organismi come la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) e i National Institutes of Health (Nih). La portata di questo Stato nascosto è aumentata drasticamente nell’ultimo decennio.
Sotto Obama sono stati compiuti timidi passi in questa direzione coinvolgendo il settore manifatturiero, ma Biden ha abbracciato esplicitamente la politica industriale attraverso programmi come il Build Back Better e l’Inflation Reduction Act. Nel 2022, Biden ha dichiarato che gli investimenti federali a sostegno della produzione di chip per semiconduttori avrebbero attratto gli investimenti del settore privato. A ciò va contrapposta la richiesta di Milton Friedman, nei primi anni Ottanta, di smantellare la National Science Foundation (Nsf): a suo avviso, lo Stato non avrebbe dovuto sostenere alcuna forma di ricerca e sviluppo.
Ci sono ancora molti problemi, naturalmente. Uno di questi è che questo Stato orientato allo sviluppo è fortemente condizionato a favore della Difesa. Circa la metà dei finanziamenti federali per ricerca e sviluppo negli Stati uniti riguardano esigenze militari. Questo è molto pericoloso e significa anche che importanti aree di ricerca civili, come quelle riguardanti la crisi ambientale, rimangono sotto finanziate. Inoltre, Block e i suoi colleghi notano come ci sia scarsa condivisione dei guadagni tra il settore pubblico e quello privato. Molti soldi vanno al settore privato per sostenere l’innovazione, ma torna indietro molto poco. Si pensi a Google che riceve denaro dall’Nsf per sviluppare il suo algoritmo, o alle elargizioni a Elon Musk da parte di varie agenzie pubbliche per Tesla, mentre continua a promuovere un’agenda libertaria sul piano economico.
Che paragone si può fare tra l’approccio dell’amministrazione Biden e gli altri governi di centro-sinistra al potere negli ultimi anni?
Con l’eccezione della Spagna, dove c’è stato un certo tentativo di aumentare i salari e rafforzare i sindacati, non abbiamo visto nulla che si avvicini all’ambizione dell’amministrazione Biden, nonostante tutti i limiti che ho menzionato. In Europa In particolare, non abbiamo avuto lo stesso tipo di sostegno per i sindacati, la spesa pubblica o la politica industriale. Non c’è stata alcuna rottura con la tradizionale politica neoliberista.
Quanto è importante l’ascesa della Cina per i politici statunitensi ed europei e quali misure hanno adottato finora per rispondere?
La posizione degli Stati uniti e, in una certa misura, dell’Europa è stata quella di reagire in modo aggressivo al recupero della Cina, cercando di chiudere i mercati in cui ritengono che le imprese cinesi minaccino le loro principali capacità economiche. Questo è il caso soprattutto dell’industria green, dove la Cina si è mossa molto più rapidamente degli Stati uniti e dell’Europa nella produzione di auto elettriche e pannelli solari. Un punto problematico, perché almeno in questi settori la Cina ha fatto quello che avremmo dovuto fare noi in Europa e negli Usa. Avremmo dovuto sostenere maggiormente quelle industrie che ci avrebbero permesso di abbandonare i combustibili fossili. In effetti, stiamo punendo la Cina per la nostra debolezza e incapacità di affrontare le sfide del nostro tempo. A un livello più profondo, dovremmo riconoscere che esistono significative differenze di politica nei confronti della Cina tra Stati uniti ed Europa, con gli Stati uniti che hanno deciso di affrontare la Cina in modo aggressivo mentre l’Europa non si è spinta nella stessa direzione. Per esempio, i produttori tedeschi hanno detto chiaramente che non vogliono affatto staccarsi dalla Cina; anzi, stanno espandendo le loro attività in quel paese.
All’interno degli STESSI Stati uniti sembrano esserci punti di vista divergenti. Da un lato, le industrie manifatturiere e il settore militare spingono per una posizione più aggressiva. Dall’altro lato, c’è l’industria finanziaria, che ha ottenuto importanti vantaggi dalla liberalizzazione del mercato cinese dei servizi finanziari e vuole trarne beneficio. Questa divergenza determina dei problemi per la sinistra, perché i settori che spingono per opporsi alla Cina sono gll stessi che sarebbero più coinvolgibili in un’agenda pro-lavoro rispetto agli attori finanziari.
Quello a cui stiamo assistendo è una vera e propria contraddizione del capitalismo. Stiamo tornando alla classica rivalità interimperiale. C’è stato un periodo in cui la relazione tra Stati Uniti e Cina era reciprocamente vantaggiosa dal punto di vista del capitale, con la Cina che produceva beni manufatturieri a basso costo per il mercato americano, mentre gli Stati uniti potevano accedere a una vasta offerta di manodopera a basso costo e inviare molti investimenti all’estero. Ora stiamo assistendo a una dinamica a somma zero, che il capitalismo non è molto in grado di gestire. La competizione si sta spostando dalla sfera economica a quella militare, portandoci in una situazione che appare molto pericolosa.
Cosa pensi si possa apprendere dalla relazione sulla competitività nell’Unione europea di Mario Draghi e quali sono le misure che probabilmente verranno adottate dall’Ue e dai suoi Stati membri in risposta ad alcune delle sfide individuate dallo stesso Draghi?
Draghi ha individuato un dato molto importante: la drammatica incapacità degli Stati europei di gestire la propria economia al pari delle altre grandi economie, come Cina e Stati uniti. Dall’inizio del XX secolo fino al 2008, l’aumento del Pil pro capite è stato più o meno lo stesso per gli Stati uniti e l’Eurozona. Da allora, tuttavia, il divario è aumentato in modo significativo. È avvenuto quando le economie dell’eurozona hanno scelto di attuare dure politiche di austerità, con un conseguente forte calo relativo. Anche in questo caso, dopo la pandemia da Covid 19, le politiche espansive in Europa sono state meno incisive che negli Stati uniti, il che ha determinato un’altra divergenza. Se l’Europa si sta allontanando dagli Stati uniti in termini di Pil pro capite, non è perché ci stiamo muovendo verso nuovi indicatori di ricchezza o nuove ambizioni ecologiche. È semplicemente perché siamo meno coerenti dal punto di vista della gestione macroeconomica. Riconoscere questo problema, come fa il rapporto di Draghi, è un passo importante. Identifica la necessità di maggiori spese e investimenti. Tuttavia, quando si entra nei dettagli di ciò che il rapporto propone, dubito che si possa arrivare a esiti positivi. Per esempio, sostiene che l’Europa manca di competitività, ma non è così. In realtà, l’Europa è molto competitiva: nel complesso, ha un’eccedenza commerciale. Quindi, nel confronto con gli Stati uniti, il problema dell’Europa non è che ha bisogno di una maggiore competitività, ma piuttosto di una maggiore produttività, che non è la stessa cosa. Questo è legato alle politiche di innovazione e allo sviluppo delle imprese. È molto importante sottolineare questa differenza.
Un’altra questione fondamentale è che molti paesi europei hanno adottato standard neoliberali più rigidi rispetto agli Stati uniti, soprattutto in materia di politica fiscale. In Germania c’è il «freno al debito», che fa parte della Costituzione e che blocca un approccio fiscale più attivo. Ciò contribuisce alla mancanza di dinamismo dell’economia tedesca. Anche la politica europea della concorrenza rappresenta un ostacolo a qualsiasi tipo di solida politica industriale. Sebbene ci siano stati alcuni cambiamenti a livello di discorso pubblico, ci vorrà tempo per abbandonare il paradigma che si è instaurato nel corso dei decenni. La relazione di Draghi non affronta gli aspetti legati al quadro dell’integrazione europea e non si intravede un percorso chiaro verso la trasformazione di tale quadro, il che è molto preoccupante.
Draghi osserva come l’Europa abbia mancato la trasformazione digitale. Non solo negli Stati uniti, ma anche in Cina e persino in Russia, ci sono forti imprese tecnologiche nazionali che forniscono servizi di tipo nuovo. In Europa non ci sono aziende che forniscono questi servizi, il che significa che gli Stati, le aziende e i cittadini europei sono sottomessi a interessi aziendali di difficile regolamentazione perché hanno sede all’estero. L’approccio adottato finora dall’Ue, incentrato sulla protezione dei dati a livello individuale, non è all’altezza di questa sfida, che richiede un ambizioso progetto pubblico per fornire servizi digitali di base a livello locale e proteggere la sovranità degli Stati europei. A un livello più fondamentale, le politiche economiche su entrambe le sponde dell’Atlantico non dovrebbero puntare ad accelerare la spirale produttivista-consumistica, ma promuovere una trasformazione degli stili di vita, con servizi pubblici più forti e garantendo una rete di sicurezza per la popolazione e un riequilibrio del nostro rapporto con la natura.
Se la politica industriale è tornata all’ordine del giorno in tutte le principali economie capitalistiche, quali forme potrebbe assumere nei prossimi anni?
Non c’è dubbio che la politica industriale sia tornata. Si sta passando da un approccio orizzontale, che comportava sussidi indiscriminati alle imprese, a obiettivi più mirati con un mix di strumenti. Le tariffe commerciali – ad esempio contro le auto cinesi – fanno parte del kit di strumenti della politica industriale. Anche le sovvenzioni e i prestiti sono molto importanti. Ciò che ci manca finora diventa chiaro se pensiamo in particolare alla trasformazione ecologica. Dobbiamo andare oltre l’idea di rendere più ecologiche le attuali strutture economiche. La logica della legge sulla riduzione delle emissioni negli Stati uniti è quella di promuovere automobili, abitazioni e processi industriali più ecologici. Ma la nostra crisi ambientale è più ampia delle emissioni di carbonio e dei cambiamenti climatici, anche se questi sono già un problema enorme. Dobbiamo affrontare anche gli inquinanti chimici, la perdita di biodiversità e molti altri problemi. Abbiamo bisogno di una pianificazione ecologica, non solo a livello di particolari settori economici, ma anche tra i settori stessi. È ovvio che le automobili devono essere più ecologiche, ma dobbiamo pensare anche ad abbandonare l’automobile per passare al trasporto su rotaia. Non è possibile farlo offrendo sussidi all’industria automobilistica. L’idea di considerare i legami intersettoriali e di trasformare la struttura della produzione era una caratteristica degli Stati in via di sviluppo, ma non se ne parla più molto. Dobbiamo avere un processo di deliberazione e fare delle scelte sul tipo di società in cui vogliamo vivere e sullo stile di vita che vogliamo avere. Nel frattempo, dobbiamo anche costruire scenari tecnologici ed ecologici che supportino questi modi di vivere.
Quali pensa siano le principali conseguenze dell’aggravarsi della crisi ambientale per le dinamiche del capitalismo globale?
Possiamo già vedere alcuni settori che si preoccupano dell’impatto delle catastrofi legate al cambiamento climatico, come gli uragani. Ciò significa costi assicurativi elevati, con gli assicuratori sempre più riluttanti a offrire copertura ad alcune regioni o ad alcuni tipi di rischio, per cui gli attori privati saranno più esposti. Questo potrebbe ripercuotersi su vari settori dell’economia. Il pericolo di un’accelerazione nella successione di cattivi raccolti è un’altra grande minaccia, più diretta per le popolazioni del Sud globale. Ma avrà anche ripercussioni importanti per l’economia mondiale nel suo complesso, con l’aumento dei costi che peserà sia sull’offerta che sulla domanda di prodotti agricoli.
Ma credo che la conseguenza principale sia che lo Stato dovrà intervenire sempre di più per affrontare le conseguenze del degrado ambientale. Questo approccio da Big-State al capitalismo sarà molto importante.
In che misura si trasformerà in una crisi classica del capitalismo? Non sono del tutto sicuro di quali siano le implicazioni. Ritengo che una parte dei costi sarà assorbita da tassi d’investimento più elevati. Ora stiamo vivendo una significativa diminuzione dei livelli dei prezzi, ma credo che ci siano pressioni di fondo verso prezzi più elevati, legati ai costi ecologici e ai costi di smantellamento di alcune forme di infrastrutture che non saranno più necessarie.
Nel complesso, credo che ci sarà una dinamica che genererà un’inflazione più alta rispetto alla fase precedente, che porterà a una relativa diminuzione del peso della finanza. Questa è la mia scommessa, anche se devo riconoscere che non si è ancora concretizzata in misura significativa e gli attori finanziari si muoveranno con forza per proteggere i loro redditi. Il settore finanziario privato si è orientato verso partenariati pubblico-privati per proteggersi dall’inflazione e dagli altri rischi che sta affrontando. La sinistra dovrebbe opporsi esplicitamente spiegando che il tentativo di offrire protezione politica ai possessori di attività finanziarie limiterà la nostra capacità di affrontare le catastrofi che si stanno già moltiplicando.
Quali implicazioni avranno queste nuove condizioni economiche sulla lotta di classe e sui programmi politici delle forze di sinistra?
La mia idea è che la situazione generale dovrebbe essere più favorevole al lavoro rispetto ai decenni precedenti. Negli ultimi anni negli Stati uniti abbiamo assistito a un aumento dei salari, anche se non spettacolare – in effetti, i lavoratori a basso salario sono ancora al livello del 2020 in termini di reddito. Ma con livelli di occupazione più elevati e alcuni segnali di rafforzamento dei sindacati, ci stiamo muovendo verso una migliore posizione negoziale. Ciò significa che possiamo essere più ambiziosi. Anche perché molte delle argomentazioni che abbiamo dovuto portare avanti negli ultimi decenni – contro l’idea dell’auto-equilibrio dei mercati, contro la negligenza delle politiche industriali, ecc. – fanno ora parte del discorso mainstream. Possiamo chiedere la democratizzazione dell’economia e la pianificazione democratica, invece di adottare una posizione puramente difensiva.
Tuttavia, dovremmo essere molto preoccupati per l’evoluzione dell’economia mondiale. Penso che ci sia un rischio significativo di guerra, poiché la rivalità interimperiale sta ora accelerando. Stiamo vivendo un arretramento rispetto al periodo dell’iperglobalizzazione. Quel periodo ha avuto conseguenze negative per il lavoro, in particolare per i lavoratori del settore manifatturiero. Allo stesso tempo, però, avevamo un nuovo ordine internazionale e gli attori principali del neoliberismo erano le banche e le imprese internazionali. Oggi c’è il rischio che le regole dell’economia internazionale siano sempre più decise dall’establishment della Sicurezza nazionale, soprattutto negli Stati uniti. Questa prospettiva non è affatto positiva per la sinistra a livello internazionale. L‘agenda della pace e dell’internazionalismo dovrebbe essere molto importante nel prossimo futuro.
Cédric Durand è professore di economia politica all’Università di Ginevra e membro del Centre d’Économie Paris Nord. È autore di Fictitious Capital: How Finance Is Appropriating Our Future e di How Silicon Valley Unleashed Techno-Feudalism: The Making of the Digital Economy, dal quale è tratto questo testo, pubblicato da JacobinMag. La traduzione è a cura della redazione.


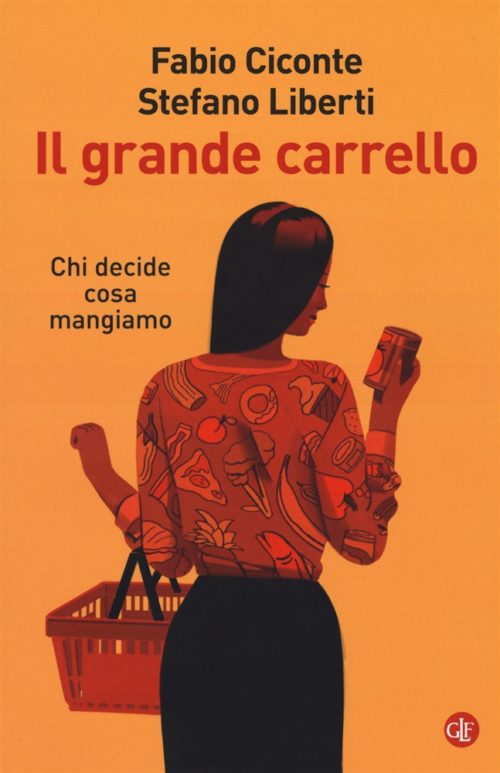







Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!