Comandati dall’algoritmo
Il cyberpadrone ha un ruolo profondamente politico: esercita il dominio nascondendo le relazioni di potere, atomizzando la forza lavoro e illudendo i consumatori di avere il controllo
C’è un nuovo manager: l’algoritmo. Cyberboss, libro recentemente pubblicato da Craig Gent, uno dei direttori del giornale britannico Novara Media, approfondisce il ruolo di quello che l’autore chiama il «management algoritmico», mettendo a fuoco questioni come il controllo nel luogo di lavoro e l’attuale funzione dei sindacati. Questo in un contesto in cui si discute, da una parte, di un possibile passaggio dal capitalismo al tecnofeudalismo, dato l’immenso potere delle corporation del web, dall’altra, di atomizzazione, data l’opprimente solitudine e la mancanza di organizzazione politica. A tutto ciò si aggiunge il tema dei grandi venditori di fumo intenti a produrre contenuti da essere consumati religiosamente online. Insieme a Gent, parliamo di questo mondo tanto opprimente quanto irreale.
In Cyberboss, approfondisci la relazione tra i sindacati e i luoghi di lavoro dominati dal management algoritmico. Come viene influenzato il loro ruolo da queste nuove forme di management? La sinistra discute abbastanza nel dettaglio delle pratiche e degli approcci specifici adottati dai sindacati?
Da almeno quarant’anni, se non di più, i sindacati sono sotto minaccia, ed è comprensibile che in un contesto tale ci concentriamo sulla loro difesa. Tuttavia a volte a sinistra l confondiamo le attività dei sindacati, specialmente quelli più grandi, con le attività della classe lavoratrice stessa… ma non sono la stessa cosa. Io sono stato attivo nei sindacati per quasi vent’anni. A volte è un lavoro bellissimo, capace di trasformare la realtà ottenendo delle vittorie, ma altre volte è una vera lotta interna tanto quanto esterna. Dentro ai sindacati ci sono buone e cattive strategie dentro ai sindacati, e ci sono sindacati buoni e meno buoni. Qui nel Regno unito ci sono vari esempi di sindacati che si sono distrutti a vicenda, e di altri che hanno distrutto i loro stessi iscritti.
Il management algoritmico è un’enorme sfida per queste organizzazioni. In parte perché è legato alle tecnologie nel processo professionale, e in parte perché riguarda il management: due aree che i sindacati hanno storicamente difficoltà ad affrontare. Infatti, nel Regno unito, il riconoscimento del diritto del datore di lavoro a fare del management (Right to Manage) è semplicemente il modello della maggior parte degli accordi firmati dai sindacati.
Ci troviamo a lavorare in delle vere e proprie tirannie. Dovremmo quindi parlare di democrazia nel luogo di lavoro: qual è la relazione tra management algoritmico e lotta per la distribuzione di potere nelle imprese?
Il management algoritmico allontana ancora di più i lavoratori e le lavoratrici dalla redistribuzione del potere e distrugge qualunque sembianza di potere nella loro vita lavorativa quotidiana. Questi sistemi, essenzialmente, sono una tecnologia politica molto più che economica. Rubano ai lavoratori molte delle condizioni preesistenti necessarie per realizzare dei tentativi, anche limitati, di organizzarsi. Nel libro analizzo una serie di metodi clandestini praticati dai lavoratori che ho intervistato, che eseguono con il fine di limitare la disuguaglianza di potere e informazione nelle imprese. Anche loro efntaizzano proprio questo punto in merito a ciò che possiamo chiamare democrazia, ma anche controllo sul luogo di lavoro. Il loro obiettivo è pretendere un minimo di controllo e di autorità su come si svolge il loro lavoro. La sorveglianza dei lavoratori non è una novità del management algoritmico, è un suo rafforzamento. Inoltre, anche se la stabilità lavorativa o i salari migliorassero, queste tecnologie renderebbero in ogni caso il lavoro incredibilmente abusante e atomizzante.
Che impatto credi abbia il crescente management algoritmico sulla «classe professionale-manageriale» e sulla sua posizione egemone nella sinistra liberale?
Io sono un po’ scettico rispetto al termine «classe professionale-manageriale», perché credo che «professionale» e «manageriale» siano due cose diverse, che non vanno necessariamente unite. Molti degli intervistati nel mio libro non sono ciò che si intende come professionisti appartenenti a questa classe, vale a dire laureati, colletti bianchi, ecc. Anche se nel libro mi occupo dei lavoratori che fanno parte della logistica, il management algoritmico è sempre più adottato da uffici universitari, studi legali, e da tutti i tipi di lavori tradizionalmente considerati colletti bianchi. Nelle mie ricerche ho visto che c’è una riorganizzazione del management: ho scritto sull’elevazione del ruolo di autorità dell’algoritmo, in un senso incorporeo, su come questo problematizza le tradizionali relazioni lavorative che potevano essere date per scontate. C’è, in particolare, una perdita di potere dei supervisori e dei quadri intermedi a favore dell’algoritmo, che viene dipinto come oggettivo e meno soggetto a errori. Questo sbocca anche in un fenomeno chiamato managerial distanciation (distanziamento manageriale), che descrive come i manager possano essere assenti dal luogo di lavoro sia fisicamente che moralmente. Così, la presenza manageriale e la responsabilità vengono trasferite all’algoritmo, il quale però non è tenuto a renderne conto.
Dici di essere scettico riguardo al termine «classe professionale-manageriale». Come percepisci l’idea che la sinistra sia egemonizzata da laureati scontenti la cui posizione di classe ha una certa ambiguità?
È vero che molti dei temi ai quali dà protagonismo la sinistra attuale rispecchiano i problemi affrontati da persone laureate declassate e senza futuro, una posizione di classe nella quale io stesso mi riconosco. Anch’io vorrei essere ricco e che la mia mente mi permettesse di avere una vita molto diversa da quella che ho avuto crescendo. Ma penso anche che la situazione sia più complessa.
Un altro elemento infatti è la professionalizzazione della politica, che trovo difficile da separare dai progetti di Jeremy Corbyn nel Regno unito, di Podemos in Spagna o di Syriza in Grecia. Questo è un problema: c’è una generazione di persone di sinistra che non può concepire la politica senza pensare al Partito laburista o a certi suoi rappresentanti parlamentari, che sono ogni volta di meno e incredibilmente limitati nei propri ruoli. È questo modello politico che ha portato i sindacati a pretendere sempre di meno. È il bread-crumbing (accontentarsi delle briciole) della politica.
Ci sono tantissimi concetti di sinistra che neanche teniamo più in considerazione: controllo dei lavoratori, libertà dal lavoro, azione diretta, ecc. Per esempio, oggi, quando le persone parlano di azione diretta si riferiscono, tra le altre cose, a una manifestazione; ma una manifestazione non è un’azione diretta, che consiste invece nel portare avanti la domanda stessa compiendo con l’azione alcuni dei suoi obiettivi. Ora questo ha luogo in pochissimi casi, alcuni di essi dentro al movimento per la Palestina.
Ci sono settori della sinistra per i quali l’automazione non solo è positiva, ma dovrebbe essere uno degli obiettivi più importanti di un progetto desiderabile. D’altra parte, possiamo osservare alcune tendenze anarco-primitiviste in certi settori della sinistra per la decrescita che sembra voler allontanarsi dall’industrializzazione in modo assoluto. L’automazione è l’altra faccia della dominazione algoritmica? C’è una parte della sinistra la cui ideologia entra in conflitto con l’uso sempre maggiore della tecnologia? Quale dovrebbe essere l’approccio socialista di fronte ai costanti progressi tecnologici?
Quando parliamo di tecnologia dobbiamo farci tre domande: Cosa fa? Chi serve? Chi danneggia? Non ci sono progressi tecnologici astratti. In questo campo, la questione della relazione tra tecnologia e potere dovrebbe sempre essere la prima a essere affrontata dai socialisti. L’idea della piena automazione che serve tutti, inclusa la classe lavoratrice, va bene come orizzonte utopico, ma non credo che dovremmo confondere la questione del progresso tecnologico con quella della liberazione politica. Non credo esista nessuna tecnologia che ci porti diretti alla liberazione politica che desideriamo. A meno che la classe lavoratrice la controlli pienamente, cosa altamente improbabile. Il management algoritmico ci insegna che è molto meno costoso e politicamente utile impiegare, sfruttare e poi rimpiazzare dei lavoratori che dei robot.
Io non sono un sostenitore della decrescita, ma in aree come la logistica c’è da dire che, oltre al male inflitto ai lavoratori, il management algoritmico danneggia anche il pianeta. Accelera infatti le catene di distribuzione, fa funzionare il delivery in giornata che crea un forte incremento delle emissioni inquinanti. Dovremmo essere disposti ad accettare una minore convenienza se ciò permette migliori condizioni lavorative, il che diventa ancora più importante se implica un minore impatto negativo sul pianeta.
Nel suo articolo There is No Red Pill nella rivista Damage, Sam Kriss racconta di una politica del Governo sudcoreano destinata a estinguere il contatto umano: robot come baristi, edicole self-service, servizi pubblici forniti da metaverso e, continua Kriss, anche nel mondo anglofono si sta andando in questa direzione con dei negozi «da dove puoi convenientemente uscire con la spesa fatta senza aver dovuto neanche avvicinarti a quegli schifosi degli esseri umani». Che forme prende, per esempio, nel Regno unito, questa realtà?
La cultura della convenienza funziona a servizio dell’estrazione di valore da parte del capitale, ma c’è anche la cultura della servitù: sistemi messi in atto da applicazioni come Deliveroo funzionano in un modo tale che è come se si stesse impiegando un servo per portarci ciò che desideriamo.
Inoltre, quest’ideologia della convenienza arriva a un punto tale che diventa, ironicamente, sconveniente anche per il consumatore. La grande catena britannica di pub Wetherspoons, per esempio, ha ora un’app che viene usata dai clienti al posto di ordinare fisicamente alla cassa. Così, passano molto più tempo a confermare che sono in quel preciso pub, il loro numero di tavolo, e poi a guardare un intero menu su uno schermo piccolissimo invece di avere in mano un normale menu cartaceo. Tutto questo per evitare di andare a ordinare alla cassa. Quello che dicono i consumatori è che, di questo sistema, apprezzano il non dover rivolgere la parola a nessuno. Percepiamo gli individui come dei servi o non li percepiamo affatto.
Siamo inondati da opzioni, spesso in forma di cultura o di informazione. Dagli anni Novanta in poi, la «fine della storia» – e poi «la fine della fine della storia» – è particolarmente rappresentativa di questo fenomeno: viviamo circondati dalla copia di una copia, inondati da messaggi privi di basi reali. La politica stessa ne è un esempio: è dappertutto, persino negli angoli più personali delle nostre vite, ma gli unici spazi, come sindacati o partiti politici, attraverso i quali la politica e la democrazia sono riuscite a effettuare delle trasformazioni sociali, sono sempre più svuotati. L’antagonismo di classe è assente e il sistema di produzione e proprietà impera fondamentalmente indiscusso.
I cocktail tiki sono un chiaro esempio di questo. Sono una specie di cocktail tropicali, molto diffusi. La cultura del tiki ha un’estetica polinesiana. C’è persino un genere musicale che si chiama tropicalismo. Questi cocktail e questa musica non hanno origine in Polinesia, ma sono stati creati da americani che negli anni Cinquanta avevano fatto ritorno dalla guerra del Pacifico. Fu per loro un modo di immaginare una cultura del Pacifico alternativa. La cultura tiki ha tutta quest’aria di autenticità, un’autenticità che invece non corrisponde ad alcuna realtà. È quello che Jean Baudrillard chiama un simulacro iperreale (hyperreal simulacrum): ha un carattere iperrealista, ci si può confrontare con esso, ma è fondamentalmente un simulacro, non esiste e non è mai esistito.
Anche i grandi successi della piattaforma streaming Netflix possono essere considerati un simulacro iperreale: all’apparenza impattano la nostra realtà, ma la verità è che il loro posto nella nostra società è basato su numeri gonfiati, su informazioni fasulle della loro audience, e su tutta una realtà costruita attorno all’iper-segmentazione dell’esperienza personalizzata dello spettatore.
Tiare Gatti Mora, laureata presso la King’s College London, è una giornalista italospagnola che collabora come giornalista audiovisiva e militante con media e organizzazioni italiane, spagnole e anglosassoni.







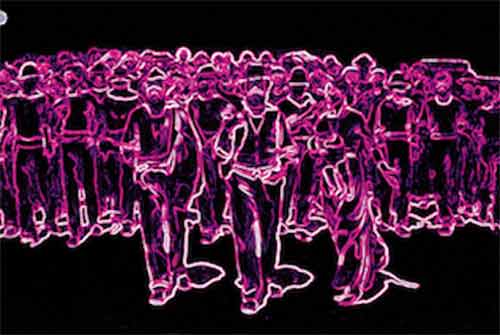


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!