CONTRATTI A TERMINE E “BUFALE” MILANESI
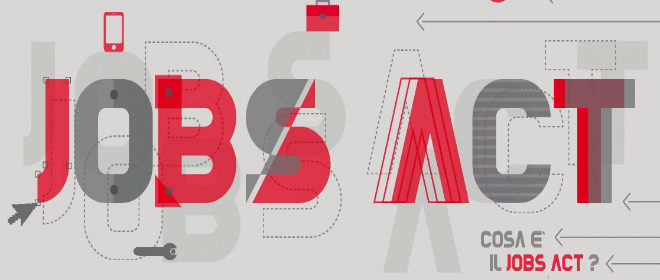
Già in altra occasione, scrivendo di revisionismo occulto e/o mascherato, avevo accennato a un angoscioso “grido di dolore” che, immaginavo, si levasse dal “Monumentale” di Milano (eterna dimora di Anna Kuliscioff, pseudonimo di Anna Moiseevna Rozenstejn), nel rilevare la stupefacente superficialità delle considerazioni espresse da Walter Galbusera – Presidente della Fondazione dedicata alla rivoluzionaria russa naturalizzata italiana – rispetto ai possibili rischi di rigurgiti fascisti; in Italia come (già realizzatosi) in altri paese europei.
All’epoca, il motivo del contendere fu rappresentato da quello che Galbusera – nel tentativo di ridicolizzarlo – definì: il “patentino antifascista” che alcune amministrazioni locali medio-grandi, quali Torino, Padova, Vicenza e Milano sembrava si apprestassero a rilasciare solo a coloro che, nel richiedere l’utilizzo di sale e spazi pubblici, avessero assunto l’impegno di riconoscere e rispettare i principi e i valori della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista!
Assolutamente non condivisibile, inoltre, la nota finale dell’articolo attraverso la quale, l’ex Segretario generale della Uil lombarda, definiva “brillante” l’Editoriale di un giornale di provincia che aveva sottolineato l’assonanza tra il metodo adottato durante il “ventennio” mussoliniano – i professori universitari obbligati, pena l’esclusione dalla cattedra, a giurare fedeltà al fascismo – e l’iniziativa delle suddette amministrazioni. Così, a Padova e nelle altre tre città, nel 2018, s’invertivano gli addenti: l’uso del suolo pubblico al posto delle cattedre universitarie e la dichiarazione di antifascismo, a quella di fedeltà al PNF.
Un’analogia assurda ed improponibile; al limite dell’apologia di reato!
Anche qualche giorno fa, al Monumentale, si sarà, probabilmente, avvertito qualcosa di paragonabile a quello che gli inglesi, simpaticamente, tradurrebbero in “Anna Kuliscioff is spinning in her grave”.
Un preoccupato Galbusera, rilevava, infatti, che, in applicazione di quanto previsto dalle nuove norme in materia di durata massima dei contratti a termine (di cui al decreto legge 12 luglio 2018, nr 87), molte aziende private, al pari di quelle pubbliche, sarebbero state costrette a licenziare i lavoratori – non rinnovando loro preesistenti contratti a termine – e ad assumerne altri. In particolare, la Sea Handing, la Milano ristorazione e l’Amsa (tutte aziende pubbliche) per complessivi 700 lavoratori.
Il Presidente della Fondazione, evidenziava, quindi, ben tre questioni che, a parità di saldo occupazionale (sostanziale sostituzione dei precedenti 700 occupati con altrettanti disoccupati) rappresentavano, a suo parere, altrettante negatività; effetto delle nuove disposizioni: 1) la “dispersione” delle professionalità ormai acquisite dai 700 lavoratori a termine giunti a scadenza; 2) la loro (forzata) sostituzione con nuovi lavoratori non ancora sufficientemente pronti a svolgere gli stessi compiti e, quindi, da “formare”; 3) la presenza di troppi ostacoli a una più facile gestione dei contratti a termine (il che avrebbe potuto favorire(!), a suo parere, la trasformazione degli stessi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato).
L’articolo si apriva con quello che avrebbe dovuto, evidentemente, rappresentare un titolo accattivante: “Il decreto dignità e le prime vittime: 700 contratti in bilico a Milano”, per introdurre gli effetti negativi prodotti dalle modifiche introdotte dal nuovo Ministro del Lavoro.
Tutte motivazioni, serie e condivisibili, solo in apparenza; giusto per strappare qualche plauso di solidarietà da parte di lettori sprovveduti.
Infatti, in ossequio a una corretta informazione, vanno fatte alcune precisazioni.
In questo senso: Galbusera affermava che i nuovi limiti di durata temporale, posti dal recente decreto 87/2018, avrebbero indotto molte aziende, sia pubbliche che private, a non rinnovare (più corretto, forse, parlare di: prorogare) i contratti a termine giunti a scadenza per evitare il rischio di “Aprire contenziosi con possibili sentenze di assunzione a tempo indeterminato per lavori di carattere stagionale o limitato nel tempo”.
Al riguardo, l’ex dirigente Uil, oltre a non indicare la durata inizialmente prevista per i suddetti contratti, introduceva un elemento fuorviante che, se non dettato dalla scarsa conoscenza della norma, era da ritenere di carattere esclusivamente strumentale.
Infatti, egli paventava il rischio – in capo agli imprenditori – di possibili sentenze giudiziarie di trasformazione di rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato facendo (in modo inesatto) riferimento a contratti stipulati per lavori stagionali o limitati nel tempo (di natura, dichiaratamente, temporanea).
In realtà, il decreto 87/2018 (convertito in legge 9 agosto 2018, nr. 96), invece – contrariamente a quanto lascerebbe intendere Galbusera – proprio limitatamente ai contratti stipulati a fronte di esigenze stagionali e/o limitate nel tempo, consente il rinnovo e la proroga (oltre il primo limite dei 12 mesi) senza pretendere l’indicazione di alcuna “causale” (la cui mancanza, per i non stagionali, può, effettivamente, produrre la trasformazione del rapporto).
Sventato, quindi, il tentativo di far impropriamente considerare a carattere stagionale e/o limitato nel tempo i contratti cui si riferisce Galbusera – resta la mancanza indicazione della durata iniziale prevista per i 700 contratti.
La soluzione è quella di procedere per ipotesi.
In un primo caso, si potrebbe considerare che la stessa fosse stata inizialmente fissata per un periodo inferiore o uguale ai 12 mesi e che, prima della scadenza naturale, le aziende interessate avessero chiesto di andare oltre i 12 mesi. Normale, quindi, ai sensi del suddetto decreto 87/2018, vietare la proroga dei contratti, in assenza dell’indicazione – da parte delle aziende richiedenti – di specifiche esigenze: 1) temporanee ed oggettive, estranee all’attività ordinaria, 2) connesse a incrementi temporanei dell’attività.
Quindi, come si vede, nessuno scandalo né anomalia. Se l’azienda non è in condizione di motivare adeguatamente la richiesta di rinnovare un contratto di lavoro temporaneo, perché meravigliarsi e lamentarsi di una norma che – giustamente e a rigore di logica – non glielo consente?
Nel secondo caso, si potrebbe ipotizzare che la durata dei contratti a termine sottoscritti fosse stata, in origine, già indicata per un periodo inferiore o pari ai 24 mesi; il periodo massimo consentito dal decreto legge 87/2018 (che aveva ridotto i 36 mesi di durata massima prevista dal decreto legislativo 81/2015).
Ebbene, anche in questo caso, ci si dovrebbe porre una domanda più che legittima:” È possibile continuare a consentire alle aziende di ricorrere alla proroga di contratti di lavoro a tempo determinato anche in quei casi in cui, già utilizzati per ben 24 mesi, essi appaiano, evidentemente, ingiustificati – assolutamente arbitrari – e, in sostanza, tesi a coprire carenze di organico tutt’altro che temporanee?”.
Anche qui, un pizzico d’onestà intellettuale, nonché l’indisponibilità a consentire il ricorso a facili “scorciatoie” e palesi tentativi di reiterare condizioni di vera e propria “sudditanza psicologica” nei confronti di milioni di lavoratori – forzatamente ed arbitrariamente – “temporanei”, imporrebbero di considerare più che legittimi i nuovi limiti imposti dal c.d. decreto dignità.
Soprattutto, in virtù del fatto che, sostanzialmente, essi finiscono con l’incidere in modo quasi irrilevante rispetto alla diffusa condizione di precarietà determinata dalle diverse tipologie contrattuali disponibili.
Chiarito questo: anche rispetto alla terminologia utilizzata, sarebbe sempre auspicabile evitare le facili strumentalizzazioni.
Galbusera, infatti, definisce “a rischio” i 700 posti di lavoro, coperti con i suddetti contratti a termine, lasciando intendere che la mancata concessione del rinnovo (o della proroga) comporterebbe, automaticamente, la “perdita” di 700 posti di lavoro; con altrettanti nuovi disoccupati milanesi in più.
Non è proprio esattamente – ed inevitabilmente – così!
Anzi, parlare in questi termini – con tanta semplicità e, direi, superficialità – rappresenta una forzatura che definirei quasi una forma di “sciacallaggio”; a danno di quanti dovessero dare per inevitabile tali conseguenze.
In realtà, il ragionamento da fare è di una semplicità sconcertante e solo chi si preoccupa di garantire e tutelare interessi confliggenti con quelli dei lavoratori, è interessato a complicarlo e a renderne problematici gli aspetti.
La prima cosa da tenere presente è che nessun datore di lavoro – e, lo ripeto, nessuno di loro – ha mai avuto interesse ad assumere un lavoratore in più rispetto a quelli che gli garantiscono la completa operatività della propria azienda. Se, ad esempio, la forza lavoro occorrente per fare fronte alle esigenze produttive dell’azienda “X” è pari, complessivamente, a 125 unità, non ci sarà mai e poi mai un datore di lavoro disposto ad assumere un 126° lavoratore.
È quindi scontato che le aziende che, complessivamente, avevano assunto i 700 lavoratori, necessitavano, ai fini produttivi, della loro opera. Ora, Galbusera ci dice che, alle stesse aziende, le nuove norme impediscono il rinnovo (o la proroga) dei 700 contratti perché non sono in condizione di dimostrare (le aziende) – come previsto dal decreto dignità – la “temporaneità” delle loro esigenze.
Come si arriva a tutto ciò?
All’epoca della prima stipula dei contratti a termine, le norme non prevedevano che le aziende, cui fa specifico riferimento Galbusera, indicassero i motivi del ricorso a tale tipologia contrattuale e, quindi, dettero corso ai contratti senza alcun problema.
Una volta giunti a scadenza quei contratti, le aziende vorrebbero rinnovarli (o prorogarli), ma, intanto, le norme sono (leggermente) cambiate e, per poter procedere come gradirebbero, dovrebbero indicare le esigenze temporanee che richiedono l’impiego di lavoratori a tempo determinato.
Le aziende non sono in grado di dimostrare la temporaneità delle loro esigenze produttive.
Ciò dimostra, salvo prove contrarie, che, probabilmente, sin dalla sottoscrizione dei primi contratti a termine, le esigenze delle suddette aziende non presentavano il carattere della temporaneità e, di conseguenza, avrebbero dovuto fare ricorso ad assunzioni con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Le previgenti norme, però, non impedivano loro di utilizzare – anche senza alcuna indicazione delle motivazioni – i contratti a termine e loro li sottoscrissero.
La logica conseguenza che se ne deduce è che, se, oggi, le aziende in questione chiedono di continuare a utilizzare i 700 lavoratori, le esigenze produttive hanno, verosimilmente, il carattere della continuità nel tempo, piuttosto che quello della temporaneità (che non riescono a dimostrare)!
Perché, allora, non procedono ad assunzioni con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, piuttosto che pretendere di continuare a reiterare rapporti a termine?
Attenzione, la domanda che si pone non è peregrina, come, invece, qualche “saputone” (di parte) pretenderebbe di qualificarla.
Infatti, fino a qualche anno fa, i datori di lavoro potevano dichiarare – senza ragione, ma lo facevano lo stesso – che evitavano di assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (preferendo ricorrere a quelli a termine), perché questo avrebbe significato farsi per sempre “carico” del lavoratore; salvo avviare una procedura di licenziamento individuale che, 99 volte su 100 si sarebbe rivelata: lunga, costosa e sempre dall’esito incerto.
Ebbene, oggi, grazie al superamento dell’art. 18 dello Statuto, alla sostanziale abrogazione della c.d. “giusta causa” e alla novità rappresentata dal “Contratto a tutele crescenti”, i datori di lavoro non hanno più alcun alibi nel dichiararsi succubi di rapporti di lavoro (a tempo indeterminato) difficili – se non, addirittura, impossibili – da interrompere.
Tra l’altro, considerata ormai affermata e irreversibile la “deregolamentazione” di quello che, una volta, era l’essenza del famoso art. 18 (procedura, divieti, giusta causa, reintegra, ecc) – con conseguente “liberalizzazione” dei rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato – sarebbe stato logico, oltre che giusto, dal versante della tutela dei diritti dei lavoratori, che il lavoro a tempo determinato avesse mantenuto le proprie specificità. Invece, quella che non esito a definire “ingordigia” dei datori di lavoro, aveva trovato ampia disponibilità da parte dei governi – tutti di matrice liberista – succedutisi negli ultimi anni. Di qui, la sostanziale, riconferma, attraverso (anche) la legge 81/2015, della totale liberalizzazione dai “vincoli” che regolavano i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Perché, quindi, questa contrarietà alle norme previste dalla legge 96/2018, che, a giusta ragione, a mio avviso, tentava di porre un qualche limite al frequente e spesso ingiustificato ricorso ai contratti a termine?
Il (mio) fondato sospetto è che, in sostanza, in particolare negli ultimi 20/25 anni, sia stato avviato un perverso disegno teso a cercare di ridimensionare le conquiste legali e contrattuali che i lavoratori italiani avevano raggiunto in oltre cinquant’anni di lotte. È stata un’opera tenace, ma costante, di attacco frontale, in alcune occasioni e di lento aggiramento in altre; che ha raggiunto l’apice grazie all’azione del governo Renzi.
Colui cui è stato concesso di arrivare a fare tutto quanto – di assolutamente negativo per i lavoratori – non era stato concesso nemmeno a Berlusconi!
In estrema sintesi, dunque, il punto vero, purtroppo, è che un lavoratore con un rapporto di lavoro a termine è un soggetto – al pari di tutti coloro i quali scontano una condizione di sostanziale precarietà lavorativa – sul cui capo pende una terribile “Spada di Damocle”. Colui che non ha certezze e può, al massimo, aspirare solo a una proroga o a un rinnovo del contratto in essere – salvo sperare nella “lotteria” di un’eventuale trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, foss’anche solo “a tutele crescenti” – rappresenterà sempre, per qualsiasi datore di lavoro, il lavoratore “ideale”; restio a pretendere il rispetto dei propri diritti legali e contrattuali, disponibile a fare “buon viso a cattivo gioco” e obbligato, finanche, a ringraziare il proprio “Donatore di lavoro”!
Per concludere e al solo scopo di fornire una più corretta (e, direi, onesta) informazione, evidenzio che Galbusera, in un passaggio della sua breve nota, trova anche l’opportunità di affermare: “Una più semplice gestione dei rinnovi dei contratti a termine può favorire un processo graduale di trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato”.
Si tratta, in effetti, di un’ipotesi indimostrata e, a mio parere, sostanzialmente infondata perché rappresenta, tra l’altro, una vera e propria “contraddizione in termini”.
Non a caso, proprio l’esperienza del mercato del lavoro italiano insegna che quanto più si rendono facili – e con quanti minori vincoli possibili – le assunzioni attraverso le tipologie contrattuali c.d. “flessibili” (e i rapporti a tempo determinato vi rientrano a pieno titolo), tanto minore è la propensione dei datori di lavoro alla trasformazione dei contratti temporanei in rapporti di lavoro stabili.
P.S: Evidenzio che il ricorso a qualche eccesso di semplificazione dei concetti, prodotto nel corso di questa nota, non è stato causale. Si è inteso procedere in tal senso proprio allo scopo di dimostrare che, fin troppo spesso – da parte di coloro che non hanno interesse a rendere accessibili le conoscenze – si ricorre a “paroloni” e a strutture lessicali arzigogolate al solo fine di rendere vago e sfuggente il senso di cose terribilmente facili da intendere!
Così, ad esempio, non sarebbero sufficienti le pagine di questa breve nota per elencare tutte le motivazioni – assolutamente inconsistenti, a mio parere – espresse dai datori di lavoro e dai loro prezzolati “esperti”, a sostegno della bontà delle scelte tese a preferire la stipula di contratti a termine piuttosto che a tempo indeterminato.
NOTA
In effetti, a onore del vero, bisogna ammettere che il decreto 87/2018 sembrava voler avviare una vera “svolta” rispetto a quello che, in materia di lavoro, era stato l’orientamento prevalente di tutti i governi succedutisi negli ultimi anni; da Berlusconi a Renzi, passando attraverso Monti e Letta. Per la prima volta, infatti, ci si trovava di fronte a norme che non tendevano a peggiorare ulteriormente la già tanto precaria condizione dei lavoratori italiani.
Renato Fioretti
Esperto Diritti del Lavoro.
Collaboratore redazionale del periodico cartaceo Lavoro e salute
21/9/2018

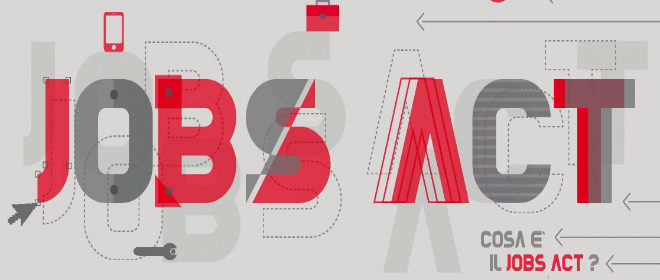







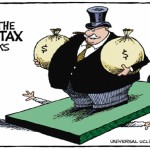
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!