Contro l’ideologia del merito, un’educazione controvento
Nel libro “L’asino mancino”, il professore di pedagogia Paolo Vittoria ripercorre la sua personale storia prima di allievo fragile e poi di insegnante per mettere in discussione un sistema basato su individualismo e competizione
di Paolo Vittoria
Vivendo al fianco di studentesse e studenti, sento che si respira un’aria molto pesante per quanto riguarda l’attesa, l’aspettativa, l’ansia. Un modello didattico che induce all’individualismo e alla competizione – il tanto decantato sistema delle competenze – gioca un ruolo decisivo in questo malessere. Del resto, se continuiamo ad utilizzare con naturalezza un vocabolario dove invitiamo ad accumulare, spendere, certificare competenze, crediti e debiti, cosa potremmo aspettarci? Così, attraverso il libro L’asino mancino. Archeologia di un’educazione, ho deciso di prendermi gioco dell’ideologia del merito, dell’eccellenza, raccontando da “prof” le mie fragilità, insicurezze di studente, e non solo.
Le difficoltà a scuola sono iniziate molto presto, già ai primissimi passi in cui non riuscivo a scrivere. Oggi comprendo che non sapevo scrivere perché ero mancino e, per mera superstizione, sono stato “istruito” come tanti altri, all’uso della mano destra. Quindi il mio esordio in una scuola che non segue i processi cognitivi del bambino, ma impone delle assurde forzature, è stato certamente faticoso, come la salita per un asino. Fabrizio De Andrè la descriverebbe come una creuza, una mulattiera.
Non me la sono vista meglio negli anni a seguire dove cercavo un cammino di senso tra bocciature e rimandi. Il cammino l’ho trovato, anzi lo cerco ancora, nell’insegnamento e nella scrittura dove prendo spunto da alcune vicende personali, anche goffe, da incontri, viaggi ma anche bocciature (non solo didattiche, ma esistenziali) come opportunità per parlare di scuola a partire dall’ultimo banco, dove generalmente sceglievo di rifugiarmi. Perché sono convinto che l’eccellenza e il merito non siano il punto di vista più giusto per capire l’educazione, che un sorriso valga molto di più di una lode o della certificazione di una competenza. Anche perché l’apprendimento non andrebbe certificato, ma avrebbe solo bisogno di trovare gli spazi e i tempi giusti. Ed allora… via libera a tutti gli asini, perché siano liberi di viaggiare.
“Sono convinto che l’eccellenza e il merito non siano il punto di vista più giusto per capire l’educazione, che un sorriso valga molto di più di una lode o della certificazione di una competenza”
Estratto dal libro L’asino mancino. Archeologia di un’educazione
Un “asino” come professore
Le prime volte hanno tutte un sapore speciale. E non si tratta solo di amore. Pensiamo anche ai bambini: è il festival delle prime volte. La prima volta che gattonano; la prima volta che camminano; la prima volta che sorridono, e così potremmo continuare di volta in volta. La primavera richiama al senso della prima volta, delle prime volte. Sbocciano i fiori come se non fossero mai esistiti eppure erano lì ad aspettare il primo sole per rivedere la luce. E così i frutti sugli alberi che magari sono secolari, ma ogni frutto ha nuova vita perché la stessa natura si rigenera. Ogni volta che entro in aula per me è come se fosse la prima. La prima volta che supero quella condizione di alienazione in cui mi trovavo e che rappresentavo simbolicamente in modo contestatario relegandomi all’ultimissimo banco, proprio all’angolo dove le due pareti potevano sorreggere il mio collo piegato per assopirmi.
In circolo per creare relazioni
Il primo banco mal lo sopportavo, sia perché mi metteva inesorabilmente di fronte alla cattedra, sia perché rappresentava un’adesione a un modello che la scuola proponeva in quel contesto e di cui non condividevo quasi nulla. In genere venivo interpellato o per l’interrogazione o per qualche richiamo.
Se l’educazione si costituisce come luogo di dibattito e, confronto, domande e inquietudini, si rende possibile l’espressione individuale e collettiva
Quando il dito della prof scorreva lungo il registro dall’alto in basso e arrivava negli ultimi cognomi un brivido gelido mi attraversava assumendo diverse temperature. Quando scendeva, oltrepassava il mio nome e risaliva tiravo un sospiro di sollievo, ma era tutto un “bluff” perché poi scendeva ancora e… tac! Colpito e affondato: il mio cognome riecheggiava in tutta l’aula fredda e umida. “Vittoria (servirebbero tre t perché quella era la pronuncia esatta con fare minaccioso) vieni alla lavagna”. Oltretutto, tranne che alle scuole elementari, non ci chiamavano mai per nome.
Quindi, via la cattedra, banchi e sedie in circolo, quando è possibile visto che – purtroppo – la tendenza è quella delle sedie fisse. In ogni caso stare in circolo, al di là della disposizione geografica, significa vivere di relazione, stare nella relazione. Se l’educazione si costituisce come luogo di dibattito e, confronto, domande e inquietudini, si rende possibile l’espressione individuale e collettiva che già inizia dal rispetto del chiamare gli studenti per nome e questo vuol dire lavorare affinché scuola e università siano spazi autenticamente democratici. D’altra parte, un Paese non è realmente democratico se non lo sono le sue istituzioni educative.
Insegnare dev’essere un’azione felice
Quello che scrutavo dall’ultimo banco era un metodo che portava a una conoscenza sempre uguale a sé stessa: situata in un luogo e in un tempo da cui non ci si muove in nome di un mero immodificabile trasferimento di nozioni. Studentesse e studenti così non si formano come soggetti della costruzione e ricostruzione della conoscenza, ma come oggetti di un discorso già preparato per loro. Così non si formano menti pensanti, ma teste obbedienti incapaci di portare il proprio vissuto interiore nell’esperienza di apprendimento. L’insegnante, sebbene in un ruolo diverso, è in realtà vittima dello stesso processo ed è per questo che molti dei miei professori non erano felici di insegnare.
L’insegnante, stando in dialogo con i propri studenti, quindi in un processo circolare e dialogico, per cui sempre aperto e imperfetto, si rigenera nello stesso atto di imparare e insegnare
Insegnare, invece, è un’azione felice perché porta a una continua rigenerazione: come la primavera, come la natura, come le invisibili cellule che ci permettono di vivere. L’insegnante, stando in dialogo con i propri studenti, quindi in un processo circolare e dialogico, per cui sempre aperto e imperfetto, si rigenera nello stesso atto di imparare e insegnare.
Perché quello che sa, appena entrato in aula, non lo sa più visto che si confronta con il sapere di altre persone che sanno altre cose o che hanno una sapienza, una saggezza diversa sugli stessi oggetti di conoscenza.
In questo sì, è importante che si riconosca anche come un asino, sia per la forza di caricare forti pesi sul dorso, sia per l’umiltà di sottoporre la propria conoscenza o saggezza alla saggezza o conoscenza di altre persone che devono essere messe nella condizione non solo di apprendere, ma di insegnare apprendendo.
Lavorare sulla saggezza
Parliamo di saggezza o conoscenza come due elementi differenti e dialoganti. Oggi comprendo che Dona Maria (che ha insegnato il portoghese in Brasile, nda) aveva pochi elementi di conoscenza della lingua, ma una saggezza infinita in grado di far crescere qualsiasi conoscenza a dismisura. In questo senso la saggezza sarebbe in un senso lato, il fermento, il lievito della conoscenza. Senza di essa la conoscenza non si coltiva.
D’altra parte, la conoscenza serve ad esempio a saper leggere uno spartito senza cui la saggezza della musica non troverebbe espressione. La scuola, quella scuola, dava solo conoscenze ma senza lavorare sulla saggezza. Ed erano anche conoscenze abbastanza neutre – senza sapore.
Noi invece dobbiamo lavorare sulla saggezza che dà vita alla conoscenza. Mentre le conoscenze possono dividere tra chi ne ha di più e chi ne ha di meno, la saggezza appartiene a tutti: dal professionista a chi non sa parlare bene ma parla con saggezza; da chi parla poco ma agisce con saggezza alla saggezza dei bambini a quella delle persone anziane; dalla saggezza del mondo contadino alla saggezza intrinseca ai proverbi; anche la saggezza di un animale, di un asino, o di un insetto, una formica, una stella.
Sono tutte saggezze destinate a crescere, che hanno in sé il seme della crescita e in cui non c’è una gerarchia. Un proverbio contadino può essere utile a un medico e viceversa, senza più o meno. E se c’è una luce della saggezza non è per oscurare gli altri, come nel fallimentare modello competitivo, ma per far luce. Oltretutto considerare che ogni umano – non solo – ma ogni elemento del regno animale, vegetale e minerale ha una saggezza, ci mette nelle condizioni di poter imparare sempre e da tutti, anche dal più piccolo e impercettibile elemento.
Ascoltare idee diverse
E non c’è insegnamento senza apprendimento. Un elemento però è indispensabile: ascoltare e far vivere le diverse idee. Impossibile che emerga saggezza senza che si possa esprimere un’opinione. Una scuola senza saggezza non è una scuola, ma una fabbrica di nozioni prodotte come in catena di montaggio, pronte per essere impacchettate, immesse e svendute al magnifico mercato delle competenze.
L’autore
Paolo Vittoria è professore di pedagogia generale e sociale all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha insegnato a lungo in Brasile all’Universidade Federal do Rio de Janeiro. Condirettore di Educazione Aperta. Rivista di Pedagogia Critica. Collabora con il quotidiano Il manifesto. Ha pubblicato il libro “L’asino mancino. Archeologia di un’educazione” (Bibliotheka Edizioni, 2024).
Per saperne di più
- Paolo Vittoria, L’asino mancino. Archeologia di un’educazione, Bibliotheka edizioni, 2024
- Made in Italy, il numero de lavialibera sulla scuola del ministro Valditara
- Tutti gli articoli de lavialibera sul diritto all’istruzione
- Tutti gli articoli de lavialibera sulla povertà educativa
6/4/2025 https://lavialibera.it/






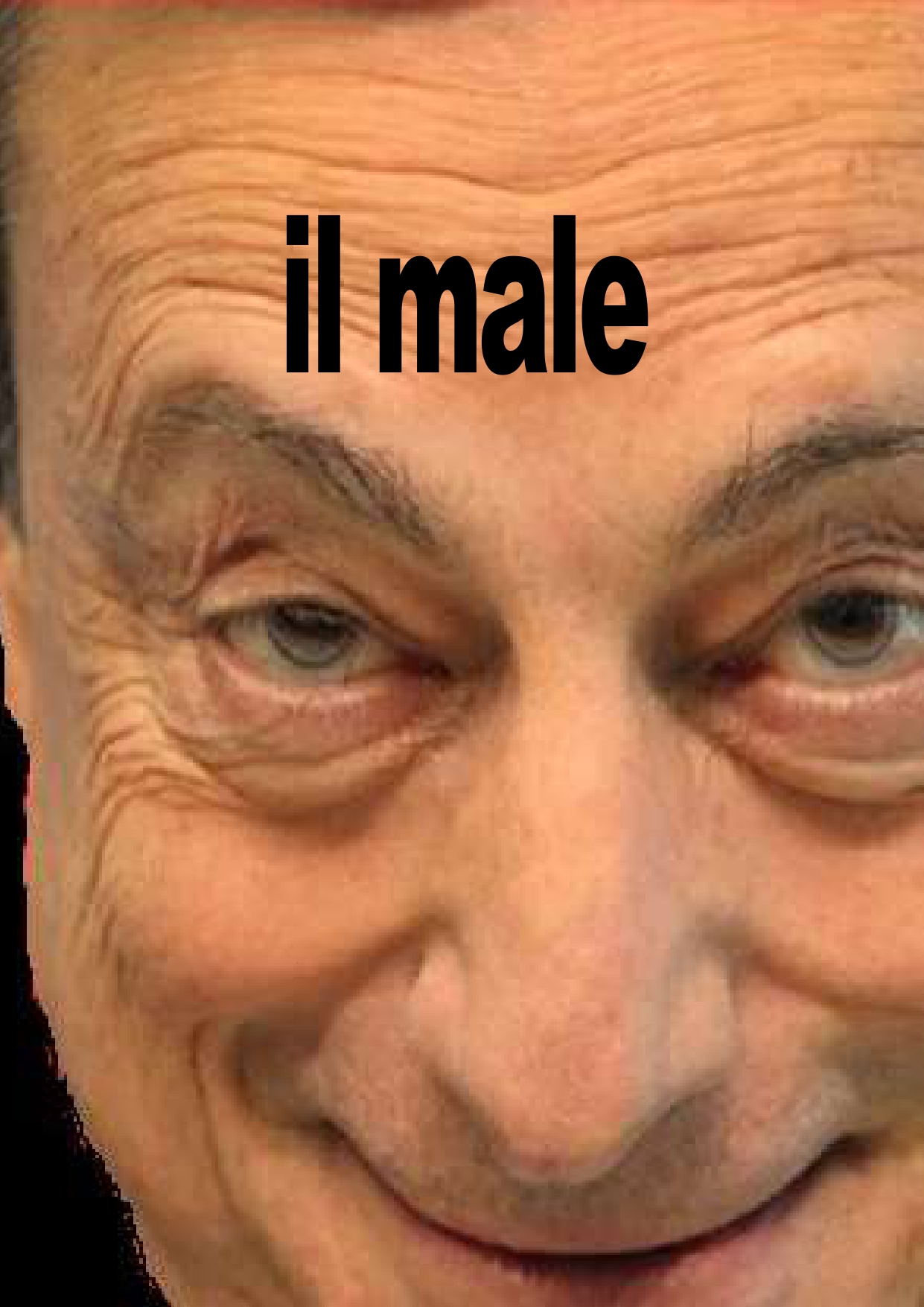
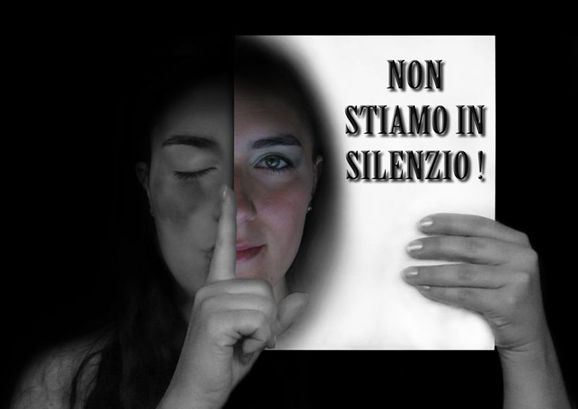


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!