Corpo e fiato: la resistenza delle donne palestinesi
«Discendo da marinai ribelli alle rive / Figlia delle onde e della memoria / Ultima superstite di coloro ai quali Sansone cedette la chioma / prima di insorgere come giovane vergine / ultima discendente della femminilità fresca e antica». Si apre così la poesia Mi rivelo di Fatena al-Ghurra, citata nell’ultimo trimestrale di «Dwf», storica rivista femminista, dedicato alle donne palestinesi.
Quei versi danno plasticità a una realtà radicata, rintracciabile nelle analisi e i racconti di Palestina. Femminismi e resistenza («Dwf», numeri 1-2 del 2018, edito da Associazione Utopia): la lotta delle donne palestinesi è corpo e parola.
Da oltre un secolo, fin dai primi anni del Novecento, le donne sono state parte attiva del movimento di liberazione nazionale, non mera appendice, e lo hanno fatto – lo fanno – in due modi: con il corpo (interposizione fisica, lavoro manuale, autogestione delle comunità occupate, resistenza in prigione, azioni armate) e con la parola (memoria orale, trasmissione della Storia e delle storie, mantenimento in vita dell’identità culturale e sociale).
Lo fanno nei campi profughi in Medio Oriente, come nei villaggi e le città dentro la Palestina storica consapevoli della necessità di dover superare barriere duplici: all’occupazione militare e la repressione israeliana si sommano i limiti di una società tuttora patriarcale. E che ha condotto a una doppia contraddizione: da una parte l’esaltazione della donna come anima della famiglia e della comunità, soprattutto nei periodi più duri (le due Intifada), che resta però ancorata alla cura e la gestione dell’ambito familiare e comunitario; dall’altra l’identificazione della donna nella Palestina, la terra, la nazione anelata, fisicamente rappresentata con una figura femminile in abiti tradizionali e capelli al vento, occhi grandi e luminosi, bellissima e forte.
La lotta delle donne palestinesi diventa così un’esperienza unica nel suo genere, per le caratteristiche dell’oppressione subita – un colonialismo di insediamento, dove l’obiettivo del colono non è il controllo e lo sfruttamento della popolazione indigena, ma la sua sostituzione – e per il percorso che ha compiuto il movimento delle donne all’interno del più vasto contesto della resistenza nazionale. Unico ma potenzialmente universale: difficile non vedere nelle forme di resistenza quotidiana delle donne di Palestina lo specchio di realtà altre, a partire dal più recente confederalismo democratico curdo nel nord della Siria (di cui l’esperienza della Prima Intifada è chiaro modello, voluto o meno) alle lotte per la terra in America Latina.
 Gli scritti delle autrici che hanno partecipato alla stesura del testo si muovono sui diversi piani della questione. Ognuna contribuisce con un angolo, un punto di vista che compone un quadro d’insieme. L’analisi della giornalista Cecilia Dalla Negra accompagna, attraverso la ricostruzione storica del movimento delle donne palestinesi, all’interno della soggettività che si fa collettività, prima del 1948 con le organizzazioni femministe e poi, dopo la Nakba, con quella che viene definita la politicizzazione del focolare domestico. Fino alla lotta armata e al fondamentale salto compiuto negli anni Sessanta e Settanta quando le donne palestinesi intersecano nella loro attività politica tre obiettivi: la liberazione della donna, la lotta di classe e la liberazione nazionale.
Gli scritti delle autrici che hanno partecipato alla stesura del testo si muovono sui diversi piani della questione. Ognuna contribuisce con un angolo, un punto di vista che compone un quadro d’insieme. L’analisi della giornalista Cecilia Dalla Negra accompagna, attraverso la ricostruzione storica del movimento delle donne palestinesi, all’interno della soggettività che si fa collettività, prima del 1948 con le organizzazioni femministe e poi, dopo la Nakba, con quella che viene definita la politicizzazione del focolare domestico. Fino alla lotta armata e al fondamentale salto compiuto negli anni Sessanta e Settanta quando le donne palestinesi intersecano nella loro attività politica tre obiettivi: la liberazione della donna, la lotta di classe e la liberazione nazionale.
Il corpo, dunque, strumento di resistenza ma anche mezzo di oppressione, perpetrata da un potere – quello di occupazione – che è per sua natura maschilista e patriarcale, nella struttura militare e politica. È l’analisi compiuta da Miriam Abu Samra, ricercatrice e attivista palestinese, che accende i riflettori sul sistema israeliano di occupazione, strutturalmente patriarcale: nello svilire il ruolo della donna palestinese considerata vittima di un popolo arretrato e selvaggio, nel ridurla a mera minaccia demografica (madre e allevatrice di futuri «terroristi»), nel controllarle il movimento, il tempo e lo spazio attraverso il sistema dei checkpoint, come un padre padrone.
Alla repressione dei corpi le donne reagiscono traslando quegli stessi corpi nella parola: Ruba Salih, antropologa palestinese, descrive attraverso la fisicità delle donne rifugiate in Medio Oriente i sentimenti individuali di sofferenza per lo sradicamento, di precarietà e vulnerabilità e la successiva opera di politicizzazione di quei sentimenti. Quella che Salih chiama «effetto politico dell’amore», «agency performativa», si fa memoria concreta e non statica: come un filo rosso la Palestina permea ogni generazione fornendogli gli strumenti politici per la resistenza quotidiana.
Gli esempi non mancano e «Dwf» li racconta: il villaggio dei pastori di At-Tuwani e il diritto all’istruzione, le prigioniere politiche, Gaza e la sua resilienza, l’arte narrata attraverso la produzione di scrittrici, musiciste, pittrici, grafiche. Un’opera completa che è un’ottima guida all’interno della composita realtà palestinese.
Chiara Cruciati
29/8/2018 Il Manifesto




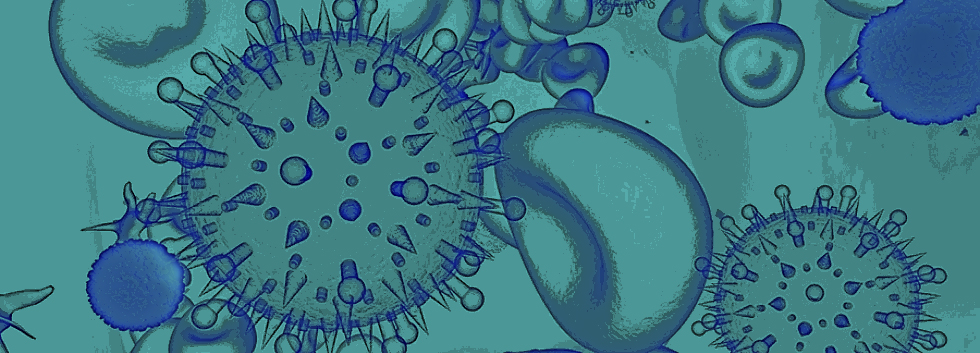






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!