Etica e Politica
La distruzione del sapere
Si può odiare con tutto il cuore una verità anche quando non c’è nulla da fare. La sentenza di una grave malattia, le distruzioni causate da un terremoto o la somma degli anni vissuti quando si arriva alla fine, non hanno un nemico contro il quale ci si possa scagliare; si bestemmia contro il fato o la vita, ma è un modo di fare, non una risposta. Quel che è accaduto non è colpa di nessuno, non c’è rimedio e si muore comunque.
Qualche volta usciamo da noi stessi e il male subìto si trasforma, si vorrebbe trasformato, in buona azione: In nome del padre o della figlia ci diamo da fare affinché la stessa sorte non tocchi a altri o almeno ci si prepari a renderla più lieve. Non c’è motivo di sorridere di questo conforto, anche la rivolta contro l’inevitabile è un principio di speranza: sotto i terremoti ci sono le case e gli anni non sono tutti uguali, ma non basta.
Il sapere necessario a uscire dal lutto non è disponibile sotto forma di un manuale di istruzioni ma va ottenuto con la forza e le difficoltà appaiono spesso insormontabili, serve tempo. La volontà da sola tiene sveglio l’istinto ma da solo l’istinto può andare in qualunque direzione. Una cattiva notizia segnala chi la riferisce, è vero, ma insieme a lui anche la conoscenza che l’ha prodotta.
Quando si passa sotto silenzio la fragilità dell’esistente, il colpevole è presto individuato, così come la constatazione rende tutti innocenti. In entrambi i casi chi volesse obiettare si troverebbe come Sansone tra le due colonne che lo tengono prigioniero, di fronte a una scelta obbligata tra la capitolazione e la rovina.
La teologia del male è lunga e distesa; quasi ogni religione ha il proprio demonio o punizione che deve essere inflitta per cancellare un’empietà che avrebbe sommerso il mondo. Ci sono dunque due princípi, la natura delle cose e la natura degli uomini. Ma lo stesso termine nasconde una differenza: la servitù non è contemplata dall’una né dall’altra. La certezza che la natura possa essere crudele nasconde alla società la divisione del lavoro, l’organizzazione dello sfruttamento cela la conoscenza dell’insensibilità del mondo. E così chi si trova di fronte alla contraddizione è addestrato a andare oltre, in una direzione o nell’altra, ma senza fare pause e, ovviamente, all’oscuro di quale sia la strada. La sofferenza che vede ovunque gli appare ora come caos al quale nessuno può sottrarsi se non per un colpo di fortuna, ora come il frutto di un privilegio individuale che dovrà essere smascherato a ogni costo. Quel che dovrebbe restare senza consolazione si trasforma in un processo contro i testimoni, dove il giudice è corrotto e la sentenza non porterà giustizia se non impiccherà l’accusa.
Il sapere che deve rendere liberi si trasforma, allora, nel nemico da sconfiggere; si odia chi ha da mangiare insomma, non che manchi a molti. Il fatto che un desco ben approntato sia appannaggio solo di alcuni fa sospettare che le pietanze e il tavolo collaborino volontariamente all’esclusione dei molti che potrebbero sedersi al proprio posto se solo non ci fossero tutte le pietanze e non fosse ora di cena.
È vero che la conoscenza – qualunque conoscenza, dalla tecnica alla metafisica – è uno strumento di oppressione. I bambini inventano lingue cifrate per tracciare un confine non valicabile, gli adulti usano il segreto bancario, un gioco e una frode ma in entrambi i casi la logica è la stessa: ci deve essere qualcuno da escludere affinché la minaccia sia sventata, a riprova che la colpa era sua. Ma formalmente nessuno viene escluso dai benefici di quel che sappiamo; i medici hanno giurato e curano tutti, un direttore d’orchestra non chiede la tessera a chi è seduto in sala dietro le sue spalle e persino i macchinari più complicati verrano messi a posto purché il cliente abbia i soldi per pagare. Prima ancora che gli infanti imparino i loro cenni segreti è il censo, e cioè la classe di provenienza, a separare chi potrà godere del sapere accumulato nel corso del tempo da coloro i quali cominceranno a odiarlo. Alla fine è il lavoro morto, di proprietà privata, che si prende la rivincita contro il lavoro vivo in vendita.
La prima speranza è che tutto sia più semplice di quanto appare. Ci deve essere da qualche parte un libro, un segreto, una formula che riparerà tutto. La difficoltà è un inganno o peggio un vezzo di coloro i quali saprebbero ben come risolvere il problema ma non lo vogliono dire per interesse personale. Lo spostamento è evidente: al posto del sacerdote che con una sola parola poteva resuscitare i morti, appare la menzogna che se solo fosse debellata restituirebbe al sacerdote il suo potere. Ma nel frattempo, nell’Occidente capitalista, e cioè dovunque, ognuno sente di avere il diritto d’essere il confessore di se stesso. La domanda sul perché mai qualcuno debba suonare il violino e altri possano solo ascoltare si muta nel sospetto che la musica sia un’arte demoniaca e se ne potrebbe certo fare a meno. I gusti personali, ultimo rifugio dell’individuo, diventano invece una buona scusa per consumare pessima merce e produrne di peggiore, con l’idea che in fondo ci si debba solo divertire e che il divertimento sia in questo modo, appunto, assicurato.
Il libro che bisogna studiare e sottolineare, il quaderno di appunti, la lezione della quale si capisce poco o nulla, lo stupido esercizio da ripetere cento volte, persino l’apprendistato più equivoco, sono reliquie da venerare in racconti sull’infanzia e non più azioni che allontanano, seppure di un passo, dalla servitù. È come la vecchia filastrocca che pretende che qualunque cosa possa essere detta in modo semplice, se qualcuno la conosce davvero, senza girarci tanto intorno. Al contempo però ognuno pensa che il suo sapere – sia un operatore di borsa o una giornalista televisiva – sia prezioso e personale e che il posto che occupa nella scala sociale sia dovuto a quella particolare qualità che pochi altri, o nessuno, possiedono.
L’emblema non sono più le chiavi inglesi o i dormitori allestiti in fretta e furia, ma il successo dei programmi televisivi dove si insegna che esiste un fattore misterioso, un talento frutto del nulla, che è dato a caso e non può essere sostituito. Ben inteso lo scopo non è quello di scovare chi sappia fare con facilità quel che a altri è difficile, ma piuttosto convincere che la vendita è all’incanto e il banditore deve sapere il fatto suo per ottenere il meglio dagli acquirenti.
Il sapere deve essere un segreto, la domanda è se sia semplice o non piuttosto una verità che sarà rivelata quando saremo pronti a riceverla; nel primo caso la propaganda è politica, nel secondo lo è l’ideologia. L’interesse di alcuni a nascondere la realtà si accorda perfettamente con il risentimento di coloro ai quali la realtà è stata nascosta e adesso vorrebbero tutto indietro senza pagare un soldo alla schiavitù. Il sillogismo secondo il quale chi è stato oppresso abbia diritto ad avere e sapere tutto quello che hanno avuto e saputo gli oppressori è, più che errato, una replica della medesima logica, dove le ferite della storia sono guarite in un momento e i debiti vengono rimessi con un atto di volontà. Così ridotti non si odia solo il sapere che è stato reso monopolio dalla divisione del lavoro, ma persino lo studio che al sapere porta. Tutti gli scienziati mentono non solo perché io non posso sapere quel che loro invece possiedono ma in fondo perché il metodo della conoscenza è un grande imbroglio contro il quale ci si può ribellare solo scovando da qualche parte un’altra strada, neutra, possibile, serena e che non abbia nulla a che fare con la storia della civiltà.
Mentre nessuno si sognerebbe di fare il chimico senza conoscere almeno la tavola degli elementi, il linguaggio permette, apparentemente, di riflettere la realtà a chiunque abbia la competenza minima necessaria per formulare enunciati di senso compiuto. Una frase che contenga solo sciocchezze, però, è formalmente identica al suo opposto e per distinguerle è necessario sapere se la terra sia piatta ovvero rotonda. La conoscenza sino a che non diventa un saper fare è indistinguibile dalla magia ma purtroppo non vale il contrario: Il sapere sembra una stregoneria a coloro i quali ne sono stati esclusi e proprio il motivo dell’esclusione è la prima conoscenza che manca loro. È così che il linguaggio, la sintassi e la grammatica, perdono la loro storia, nella somiglianza esteriore tra un enunciato e l’altro. Se un termine qualsiasi indica solo se stesso e le relazioni con altri suoi simili, una struttura insomma, allora o si ricostruisce la storia sociale di quella struttura o tutto il passato viene consegnato all’oblío. Come se il fatto di essere figlio di schiavi non contasse affatto nella vita di una persona, si pretende che anche il privilegio alla fine si riduca a nulla, perché entrambi, lo schiavo e lo schiavista, possono in teoria usare le stesse parole e lo stesso linguaggio. Solo che non sono le medesime parole né la lingua è una sola.
Si detesta quel di cui si ha bisogno, non il superfluo. La frase minima: “non ne ho voglia” significa letteralmente due cose diverse se a pronunciarla è un portabagagli di un resort di lusso o l’ospite appena arrivato. Questo sapere è nascosto nel linguaggio: Non abbiamo abbastanza parole e la differenza va perduta non appena l’equivalente universale è rispettato, ci si capisce, e questo è quanto. Che poi uno capisca che deve ubbidire e l’altro che gli è concesso di comandare non è cosa inutile alla sopravvivenza del potere e anzi: Tanto più il sottomesso se la prenderà con le parole che non servono a nulla, tanto più il comando sarà nascosto e il punto di accesso al sapere allontanato.
I moderni tentativi di emendare il linguaggio dall’alto non colpiscono il bersaglio. Eliminare il genere dei sostantivi, per esempio, o duplicare l’appartenenza, non rendono le donne più colte o gli uomini meno ignoranti. È la trappola della forma: Lo sfruttamento non consiste nel genere maschile o femminile del termine ma nel fatto che venga usato allo stesso modo per indicare due cose diverse. Non si tratta di etimologie, bensì di storia sociale. Nessun azzeccagarbugli potrebbe spaventare un contadino se dietro il suo latino non ci fosse il potere di far rispettare quelle frasi con la forza. E alla fine non solo l’ignorante odierà la lingua morta ma sognerà persino di averla in possesso per poter anche lui far applicare quel potere. Che quella lingua fosse viva un tempo non gli passa nemmeno per la testa, così come non sa che l’analfabetismo non dipende dalle “umili origini” delle famiglie ma dal costo di riproduzione di una manodopera che al tempo non serviva affatto sapesse leggere e scrivere.
La distruzione del sapere procede per salti, non si dimentica un poco alla volta ma una volta per tutte. Il libro che non sarà più aperto non esercita alcuna influenza e il fatto che continui materialmente a esistere è un’eredità con il beneficio di un inventario che non verrà mai compiuto. Poiché la quantità di conoscenza accumulata è enorme ci si difende cominciando a circoscrivere l’area nel tempo e nello spazio. Se non posso sapere quel che mi serve ritaglierò una parte abbastanza piccola di realtà sulla quale mi illuderò di avere il controllo, la materia è indifferente. Sono solo gli ultimi dieci anni che contano, solo quei cento chilometri quadrati, quell’elenco delle vittime, quelle cause segnalate nell’ultimo rapporto. Anche con le migliori intenzioni si riduce tutto quello che potrebbe spiegare un evento a un quaderno di appunti da consultare quando, da esperti, si viene intervistati. La verità è ridotta a competenza just in time, come se il problema fosse solo quello di far arrivare in tempo una spiegazione prima che l’ascoltatore si spazientisca. Il tempo della produzione e il luogo dello spaccio (oramai universale) sono diventati il modello di ogni conoscenza riconosciuta come tale. Quei pochi che si ostinano a prenderla alla larga perché credono che senza sapere il costo del rame in Cile non si possa parlare di poesia in Italia sono oggetto di scherno anche quando non fanno nemmeno in tempo ad aprire bocca prima che si passi a altro. Non hanno alcuna autorità insomma, in una società dove il prestigio si misura sui seguaci e poi, segretamente, sugli indici di vendita. E di nuovo un giovane che guardasse come funzionano le cose troverebbe patetici gli studiosi e le loro fatiche, e giudicherebbe, a ragione, che il tempo e lo spazio non hanno nulla a che fare con la tecnica che costruisce gli aeroplani e permette di riprodurre cento volte di seguito un brano senza neanche alzare un violino.
Il rovescio della medaglia ha la stessa faccia: Uniformità a quel che funziona e non importa se non si sa come e perché. Il fatto che nella minima macchina messa al lavoro, sia un computer o un permesso di soggiorno, siano sussunti i rapporti sociali e il loro divenire storico, diventa un ostacolo alla comprensione di quel che accade e quindi se ne fa volentieri a meno. Poiché non può essere spesa, la storia di una cosa diventa letteralmente invisibile e sotto la benda gli sciocchi sorridono. Lo scambio della conoscenza con la funzionalità è vantaggioso: Si risparmia tempo e fatica e la certezza di essere dalla parte giusta della riva viene dato in sovrappiù.
Al posto del processo lungo il quale storia e coscienza insegnano quali siano gli errori e come ce ne si potrebbe liberare, viene messa, in alto, la singola esperienza personale. Non è solo per gioco che migliaia di racconti, discussioni e feste tra amici si concludano con il fatidico: “A me è capitato che…”. Il gioco non varrebbe la candela se non apparisse più reale una disavventura sui banchi di scuola rispetto alla struttura che educa l’occidente del capitalismo maturo. Non c’è bisogno di pensare per avere la certezza di essere; il corpo, la memoria, il sentimento non fanno altro che ripeterlo, ma si tratta di percezione e non di coscienza. Il dubbio, a ben guardare, non riguarda l’essere in vita e presenti, quanto la coscienza e i suoi intoppi.
L’esperienza individuale dovrebbe essere il riassunto di quella collettiva ed ereditare da questa il sapere. Così come nella lingua ogni parlante somma in sé tendenzialmente tutto quanto nei secoli è stato detto, allo stesso modo il sapere individuale discende da quello collettivo. È storico per definizione e non può essere suddiviso in parti, ma cancellato sì, ed è per questo che andrebbe preservato. Ma l’illusione è quella di sostituire al sapere l’esperienza personale perché più facile da interpretare, più certa e a disposizione di tutti. L’idea che da qualche parte dentro di me sia in fondo contenuto tutto riafferma al contrario la solitudine dell’individuo borghese che immagina solo lupi, e va bene, ma ignora che siano animali che vivono in branco. Pensare di non avere niente a che fare con gli altri non significa solo disconoscere i debiti e i privilegi, ma anche vietarsi la comprensione di quel che in noi accade. Nessuno può più scrivere: “De’ remi facemmo ali al folle volo” senza la patria potestà di Dante Alighieri, e chi immagina di farlo è meno se stesso di quanto sarebbe riconoscendo quel verso come parte del suo passato. Non si tratta di memoria; chi non ha studiato chimica non sa come sia fatta l’ammoniaca, ma può riconoscere l’origine di quella sostanza nella conoscenza altrui e sa che può disporne in quanto membro di una società fondata sulla divisione del lavoro e sullo sfruttamento. Questo “sapere” non cambia la sostanza dell’ammoniaca né la sua azione sulla materia, ma restituisce un pezzo di coscienza a chi lava i pavimenti e a chi paga perché i suoi vengano puliti da altri.
Il sentimento individuale va a spasso insieme alla menzogna. Per guadagno si mente, oppure per vergogna, paura, per nascondere le colpe. L’etica non comporta alcun obbligo alla verità se la verità è inutile e infligge una pena anziché lenire un dolore. Riferire una brutta notizia quando non c’è niente da fare è una forma di potere che andrebbe impiegata solo in mancanza di ogni alternativa. Mentire per una buona causa, però, non è meglio. L’esagerazione, l’affermazione errata o l’omissione che si fanno in nome di un bene superiore non differiscono in sostanza dalle frasi che direbbe chi cercasse di imbrogliare il prossimo vendendo beni che non sono suoi e che sa benissimo torneranno al legittimo proprietario non appena avrà girato l’angolo. Ci si giustifica dicendo che quel che non è accaduto avrebbe potuto esserlo invece e che la messa in scena servisse solo a rendere palese quel che comunque è sotto gli occhi di tutti; ma se così fosse stato, a che scopo la messa in scena? Se ogni uomo sa perfettamente che i cavalli dei circassi bevono sangue, chiederebbe Kafka, a che scopo mentire quando hanno la biada in bocca?
Se non ci si fida è meglio cambiare nome alle cose. Tra realisti e nominalisti la sfida è stata vinta secoli fa, eppure rimane il sospetto se tra quei frati che sostenevano l’immutabilità dei concetti a dispetto di ogni uso non ce ne fosse uno al quale la libertà scritta in ferro sopra i cancelli non avrebbe fatto rizzare la schiena un poco prima dei benefattori anglosassoni.
Quando si mente in nome della verità in realtà si sostituisce il fragile intelletto con la ben più robusta indignazione, la conoscenza col sentimento. Ma, di nuovo, nessuno si sognerebbe di farlo sopra un campo di grano o dentro a un motore a scoppio, solo alcune conoscenze vengono scartate a favore della vittoria, e tutte sono etiche. L’antica alleanza tra vero e giusto viene spezzata in favore di prospettiva così che l’immagine risulti ben esposta, e il pubblico contento. Alla fine dei conti l’appello è alla rabbia, e più è finto il sapere che la suscita, maggiore sarà la possibilità di controllare la direzione dello sfogo verso bersagli inermi o addirittura inesistenti.
Lo sproporzionato aumento apparente dei luoghi dai quali ci si può rivolgere a tutti ha modificato non solo il pudore ma anche i luoghi stessi. Il lavorío necessario cinquanta anni fa per avere una poesia pubblicata su carta, dalla questua alla selezione, è diventato inutile quanto la brutta poesia che si scrive, a favore di una illusione di realtà, di una illusione di sé, che neanche l’assenza di qualunque risposta riesce a smascherare. E nel frattempo i luoghi valgono sempre meno. Qualche grande casa editrice continua ancora a programmare le proprie uscite su base economica – il che significa, ben inteso, recensioni e propaganda – ma la maggior parte delle testate campa sotto la panca delle visitazioni, perché quel che vendono è in realtà la pubblicità allegata al verso o al romanzo autobiografico. L’idea che scrivere non sia affatto facile fa capolino solo quando si tratta di organizzare un corso di “scrittura creativa” o una rassegna di libri per bambini. Se tutti possono scrivere ma nessuno legge, il valore di verità che speravamo contenuto in un’opera d’arte scompare, e nessuno sarà più disturbato da una così crudele vista.
Resistono, perché necessarie alla produzione in senso stretto, le aree di sapere più vicine alla tecnica, e anzi sviluppano la propria influenza anche al di fuori del loro campo specifico. Ma il loro discorso, quando giunge in fondo, non è diverso dalle chiacchiere fatte per gioco dai vecchi di fronte a un cantiere aperto. La quantità di sapere incorporata rende impossibile anche al più volenteroso dei neofiti capire di cosa si stia parlando o dove si trovino le sedi decisionali, con il risultato di una fede assoluta o del dubbio che si tratti solo di un grande imbroglio. Insomma, mentre il capitale mette al lavoro la tecnica come fosse una risorsa naturale, il sapere si vede solo per mezzo dei suoi risultati e spaventa; la proprietà privata dei mezzi di conoscenza è una delle forme di distruzione del sapere.
Il narcisismo non è più, in qualche modo, interdetto, ma è una soddisfazione menomata, perché lo specchio è divenuto nel frattempo pubblico e ci si congratula con se stessi mediante l’illusione che anche gli altri lo sappiano. Si spera che l’esibizione abbia successo e in caso contrario si tratta solo di rincarare la dose. Non ci si sente ormai più inadeguati, solo non compresi, e se qualcosa va storto si dà la colpa all’invidia.
Sarebbe stupido rimpiangere i tempi nei quali per fare una cosa era necessario saperla fare, ma il narcisismo colpisce la conoscenza in tutti gli ambiti dove non è necessaria una prova, e più è fragile l’Io che ne soffre più la risposta offerta dalla società dei consumi indica la fiducia o la stima per quel che si fa come soluzione al problema. Così consumo e narcisismo vanno di pari passo, e l’elogio di se stessi moltiplica all’infinito il feticcio di una cosa che dovrebbe, in teoria, essere un riconoscimento strappato a forza, ma di fatto è così a buon mercato che non c’è quasi chi non si possa permettere di acquistarlo.
Oramai si parla quasi solo di se stessi, come una monade senza finestre ma in grado di fagocitare tutto quel che accade. Con noncuranza si ammirano i miliardari e il loro successo, senza alcuna conoscenza, però, di come sia stato costruito. È una cecità volontaria, contrappasso del narcisismo, che nasconde quel che non si vuole vedere. L’Io dice: Potrei essere come loro, con un poco di fortuna, e nel frattempo si benda per non sapere come avvenga la selezione. Da sempre esistono leggende che narrano di un reietto diventato imperatore sopra coloro che un tempo lo avevano espulso: è l’illusione della liberazione individuale. Non importa quanto male sia organizzato il mondo, c’è sempre una possibilità di cavarsela se si sarà abbastanza forti, abbastanza convinti, abbastanza astuti. L’inganno è dunque questo: Bisogna sapere come funzionano le cose e al contempo fare finta che il merito sia nostro. Chi denuncerebbe che la lotteria è truccata dopo aver avuto in sorte un biglietto vincente?
Prima di distruggere il sapere bisogna convincere il mondo della sua inutilità. Cento anni fa gli anarchici pensavano che la conoscenza fosse la prima cosa che veniva negata agli sfruttati, avevano ragione. Fioriscono i luoghi dove si pretende di fare controinformazione, ma i segreti che svelano sono identici, per forma e logica, al complotto che si intenderebbe denunciare. Il sapere viene venduto e acquistato come ogni altra merce, solo che il capitale lo mette al lavoro mentre i segregati si illudono che sia la conoscenza a sfruttarli e non il capitale. È la scienza a sostituire gli operai con macchine sempre più intelligenti o l’interesse privato in luogo pubblico? La domanda appare oziosa solo perché il risparmio di lavoro scompare sotto nuove mansioni che vengono richieste a chi lavora. Tutti devono essere pronti a imparare quel che serve a far funzionare la macchina, discutere di chi sia il posto di conducente o quali sedili siano ancora disponibili è come cantare senza conoscere la melodia, insensato e dannoso.
Questo insegnano a chiunque apra un libro, che se ne può fare a meno, come di ogni merce, a patto di aver introiettato per tempo la legge secondo la quale quel libro è stato prodotto, il sapere in esso contenuto accumulato, il profitto distribuito e gli esclusi redarguiti per la loro inefficienza. Si può piangere sopra il latte versato, insomma, non sapere chi è stato a gettare la ciotola. Alla fine resta la colossale appropriazione del sapere da parte di chi lo sfrutta e una moltitudine di ignoranti che non sanno neppur bene cosa gli abbiano sottratto e perché.
I tavoli avranno anche grilli metafisici per la testa ma per restare in piedi devono avere le quattro gambe al loro posto, e di misura uguale. È questo che sembra insopportabile al falegname, come fosse una riduzione della sua libertà, non il fatto che di quel mobile a lui resterà solo una minima parte e l’idea che aveva in testa prima di montarlo. E così il primo sapere a essere distrutto non è la grammatica o la semina, la salute sui luoghi di lavoro o il taglio delle stoffe, ma i processi in base ai quali queste conoscenze sono state catturate. Se il tutto è falso, è colpa sua.
Ezio Partesana







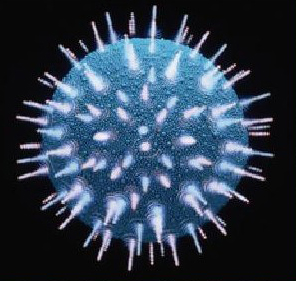


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!