Flat tax: non è solo questione di soldi
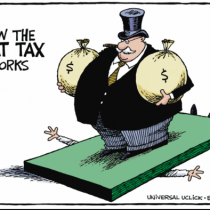
Si avvicina una nuova tornata elettorale e si torna a parlare di tasse. Non per ricordare agli italiani che la Costituzione ci richiama al «dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale», ma per assicurarci che saremo liberati da ciò che nell’immaginario collettivo si sta affermando come un’angheria.
Messaggio indirizzato soprattutto ai più ricchi che avendo di più sono anche quelli che hanno la sensazione di pagare di più. E poiché a determinare gli importi fiscali è l’aliquota, ossia la percentuale di tassazione, tutti i governi italiani degli ultimi trent’anni si sono prodigati per abbassare le aliquote sui redditi più alti, fino ad arrivare ad oggi che si propone la flat tax, letteralmente tassa piatta (si veda: La flat tax, un’ipoteca sul nostro futuro). Vale a dire aliquota unica, magari del 15%, sia che si guadagni 20mila euro che due milioni di euro l’anno. Unico elemento d’abbattimento il carico familiare, anch’esso però uguale per tutti, per cui il principio alla fine non cambia.
Un principio, quello della flat tax, opposto all’imposta progressiva che spacchetta ciò che guadagniamo in scaglioni applicando a ciascuno di essi aliquote differenziate. Molto basse sui primi gradini per diventare sempre più alte su quelli aggiuntivi. Una gradualità basata sulla constatazione che il reddito risponde a bisogni diversi via via che cresce: le quote più basse non possono essere toccate o devono essere toccate poco perché servono per i bisogni fondamentali. Viceversa le quote che si aggiungono sono accantonate o spese per beni di lusso, per cui possono essere tassate più pesantemente senza paura di compromettere la vita delle famiglie, ma anzi migliorandola perché si arricchiscono di servizi pubblici. Dunque la progressività è un principio fondamentale di equità, che però i sostenitori della flat tax contestano sulla base di due argomentazioni: ostacola la crescita e incentiva l’evasione. Ma è proprio così?
Secondo certe teorie è bene che i soldi rimangano in tasca a chi ne ha molti per avere chi investe invece che consumare. E poiché l’investimento è ritenuto sinonimo di crescita, la conclusione è che la concentrazione fa bene alla collettività. Ma in un articolo apparso il 5 gennaio 2019 sul New York Times, Paul Krugman dimostra che negli Stati Uniti il massimo livello di crescita si è avuto negli anni Sessanta del secolo scorso, quando sopra il milione di dollari (valore di oggi) si pagava una tassa del 70%.
Il fatto è che la crescita è un fenomeno complesso che si avvera solo se si realizzano varie condizioni che stanno in equilibrio fra loro: capitali che investono, ma anche adeguata capacità del sistema di assorbire ciò che viene prodotto; altrimenti i capitali non si indirizzano verso gli investimenti produttivi, ma verso quelli finanziari che, oltre certi limiti, mandano il sistema in tilt come è successo nel 2008. Per questo l’equa distribuzione dei redditi è un importante fattore di stabilizzazione.
Anche rispetto all’idea che le alte aliquote favoriscono l’evasione fiscale, ci sono studi che smentiscono questo luogo comune. Mettendo a confronto i livelli di pressione fiscale con i livelli di economia sommersa esistenti nei vari paesi (dati OCSE e Fondo Monetario Internazionale), Rocco Artifoni dell’associazione Ardep, dimostra che non esiste correlazione automatica fra i due fenomeni perché ci sono Paesi con alta pressione e bassa evasione fiscale e al contrario Stati con bassa pressione e alta evasione fiscale. Ad esempio Francia e Svezia, rispettivamente con pressioni fiscali del 46,2% e 44% del PIL hanno entrambi un tasso di economia sommersa attorno all’11%. Viceversa l’Italia, con una pressione del 42,4% ha un sommerso pari al 22,97% del PIL, in buona compagnia con Messico e Turchia che registrano economie sommerse rispettivamente del 28% e del 27,4% pur avendo pressioni fiscali del 16,2% e del 24,9% del PIL.
Mentre l’effetto positivo della flat tax su crescita ed evasione è tutto da dimostrare, si può dire per certo che impoverisce le casse pubbliche. Nel caso italiano c’è chi parla di 50 miliardi, chi di 15, ma tutti concordano che una perdita ci sarebbe e che sarebbe importante. Del resto già le controriforme attuate dal 1983 al 2017, che hanno ridotto la cumulabilità dei redditi e abbassato l’aliquota più alta dal 72 al 43%, hanno prodotto gravi distorsioni.
Secondo una ricerca di Cadtm su fisco e debito, nel solo 2016 il trattamento fiscale più favorevole rispetto al 1980 ha consentito ai percettori di redditi superiori ai 250.000 euro di trattenere per sé 4,7 miliardi di euro, invece che versarli allo Stato. Una conferma di come un fisco poco progressivo o addirittura piatto contribuisca fortemente ad accrescere le distanze fra i più ricchi e il resto della popolazione. E se non bastasse può essere utile un raffronto storico: nel 1991, quando la controriforma era già in corso, ma non in fase così avanzata come oggi, l’1% delle famiglie più ricche possedeva il 6,2% del patrimonio complessivo detenuto dalle famiglie. Nel 2015, la loro quota la troviamo quasi raddoppiata all’11,7%.
L’assurdo è che mentre in Italia si propone la flat tax, negli Stati Uniti si sta tornando a discutere della necessità di aumentare di nuovo le aliquote sui redditi più alti se non al 91%, come esisteva fino al 1963, almeno al 70%, come era previsto fino al 1981.
La principale esponente di questa istanza è la deputata democratica Alexandra Ocasio-Cortez, che chiama in causa più esigenze compresa quella di garantire maggiori entrate alle casse federali considerato che gli Stati Uniti sono il Paese che in termini assoluti ha il debito pubblico più alto del mondo. Ma più che una questione di soldi, l’onorevole Ocasio-Cortez ne fa un problema di democrazia, di coesione sociale, perfino di felicità. Negli Stati Uniti le disuguaglianze hanno raggiunto livelli da brivido anche grazie a un fisco accomodante: l’1% più ricco ormai detiene il 40% di tutto il patrimonio posseduto dalle famiglie. Una concentrazione di ricchezza che si traduce inevitabilmente in una concentrazione di potere economico e politico. Del resto non c’è bisogno di andare oltre oceano per constatare come ricchi magnati, proprietari di testate televisive e giornalistiche, riescano ad arrivare alle massime cariche dello Stato grazie alle enormi somme investite nelle campagne elettorali, ormai non più definibili competizioni politiche, bensì esercizi di marketing.
Ma le disuguaglianze sono un acido che corrode la società ancora più nel profondo, perché intacca l’anima delle persone. Nel suo volume Why men rebel, il sociologo americano Ted Gurr introduce il concetto di “frustrazione da deprivazione relativa” per descrivere quel sentimento di insoddisfazione mista a risentimento che si prova di fronte a chi ha più di noi, non per meriti conquistati sul campo ma in forza di privilegi e posizioni di rendita. E se la rabbia diventa estesa e profonda può sfociare in vere e proprie proteste che a seconda della piega che prendono possono diventare anche violente. Così le disuguaglianze conducono alla disgregazione sociale anche per la perdita di fiducia che si insinua fra le persone.
Una ricerca condotta nel 2016 da Eric Gould per conto del Fondo Monetario Internazionale conferma: «le disuguaglianze abbassano il sentimento di fiducia verso gli altri, non solo negli Stati Uniti, ma in tutte le economie avanzate». E se la preoccupazione del Fondo è per le ripercussioni che l’abbassamento di fiducia può avere sulla crescita economica, la nostra preoccupazione è per la felicità delle persone, perché senza fiducia non può esistere coesione sociale e senza coesione sociale non può esistere quel senso di solidarietà che permette anche ai più deboli di trovare serenità.
Francesco Gesualdi
17/04/2019 www.pressenza.com

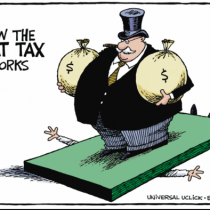








Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!