Fragilità: una chiave per aprire molte porte. Forse tutte
Quando ho saputo che il tema di questo numero di Malacoda sarebbe stato “la fragilità”, ho provato un piacere inatteso in questi tempi bui, attraversati però – ogni tanto – da lampi che fanno un po’ di luce. Del resto per me ragionare di fragilità è una cosa di tutti giorni, da sempre, dalla preistoria. Da quando, all’età di quattro anni più o meno, sperimentai l’esperienza di un abbandono notturno traumatico e lacerante, dal quale forse non mi sono mai ripreso davvero del tutto e che racconto sin dal titolo del mio ultimo libro: La notte più buia. Come se non bastassero i colpi subiti nella prima infanzia, ci ho messo poi del mio scegliendo, a tempo debito, di iscrivermi a Medicina. Una scelta che rivendico ma che, insieme a tante sicurezze e conferme, non poteva non squadernarmi davanti, nella teoria e ancora di più nella lunga pratica, il repertorio infinito di tutte le possibili fragilità umane, fisiche e psichiche.
Fragilità individuale
C’è stata una fase della mia vita, quando studiavo Patologia medica – molte centinaia di pagine in tre grossi volumi – in cui mi ero convinto che le malattie erano così tante che non potevano non rappresentare la regola piuttosto che l’eccezione. Vale a dire che essere affetti da una di esse fosse un’evenienza più probabile che essere sano. Che poi se si guarda alla cupa realtà di gran parte del pianeta – laddove la patologia si mischia con la fame, lo sfruttamento, le carestie, i cambiamenti climatici e le guerre – risulta essere una visione per nulla catastrofista ma del tutto aderente alla realtà. L’esperienza sul campo, da medico e da militante politico, mi fece poi scoprire che anche nei paesi così detti evoluti e fortunati, come è genericamente ritenuto il nostro, non è che si potesse stare molto più allegri. Specie se uno era un po’ curioso – magari comunista – e andava a ficcare il naso nelle baraccopoli romane degli anni Settanta, prima di Petroselli, per capire come vivevano gli ultimi e i diseredati, magari ammucchiati in dieci in una stanza senza servizi. Una realtà dura da vedere (molto di più da vivere) ma che mi svelò una cosa che già avevo abbondantemente intuito. E cioè che alle mille vie naturali della sfiga, per così dire fisiologica, che rendono i nostri corpi e le nostre menti vulnerabili, caduchi, naturalmente deperibili e mortali, andavano aggiunti i guai, se possibile ancora maggiori, che derivavano dalla povertà, dallo sfruttamento, dall’esclusione sociale, dall’ignoranza, dalla rassegnazione.
Fragilità sociale
Si delineava all’orizzonte una verità meno scontata rispetto alla presa d’atto di una sofferenza diffusa che dipendeva dai traumi naturali della vita e dai lutti: la constatazione di una seconda tipologia di sofferenza che si distribuiva non secondo l’arbitrio del caso ma secondo precise ragioni di classe. Che non riguardavano solo i più miseri e i rifiutati, i sottoproletari, ma anche un proletariato vasto e prevalente che, nonostante fosse occupato e avesse un lavoro, accedeva in misura minima al benessere che era esploso con il boom degli anni Sessanta. Insomma appariva chiaro che all’esistenza di una fragilità individuale andava affiancata un’altra cosa, non meno perniciosa e patogena: la fragilità sociale. Non naturale e nemmeno inevitabile ma conseguenza prevedibile e prevista di un modello di società in cui la diseguaglianza, nonostante il dettato costituzionale, era la regola costitutiva e non l’eccezione. Per completare il lungo itinerario di questa mia iniziazione, non posso non riferire un’impressione che, in questi primi decenni della mia vita, mi aveva prodotto lo studio del modo di manifestarsi della fragilità. Si trattava di un’impressione probabilmente derivata più dall’occhio clinico del medico che dall’analisi critica del militante che sognava la rivoluzione. Era la constatazione che l’appartenenza a classi sociali privilegiate dei pazienti di cui mi capitava di occuparmi, sebbene li mettesse al riparo di alcune fattispecie di calamità, in alcun modo scalfiva l’evidenza di una condizione di precarietà, più o meno consapevole, che sempre di più mi appariva strutturale in moltissimi di loro, specie se la mia osservazione si spingeva ad azzardare una visione meno istantanea e sincronica.
Fragilità come dato ontologico. Uguaglianza
È facile immaginare come i miei studi di geriatra e gerontologo possano aver confermato ciò che una visione diacronica di un vissuto bio-psicologico non poteva non confermare: la fragilità rappresenta un dato ontologico connesso con l’esperienza del vivere. Lo è sempre e invariabilmente, anche se in misura diversa da caso a caso, sino al punto da configurare un’evidenza sconcertante per come e per quanto sia poco tenuta in considerazione. Vale a dire: acquisito che ogni individuo è diverso dall’altro, un’osservazione disincantata e attenta, clinica, antropologica, epistemologica, dimostra che esiste un tratto che tutti i gli umani condividono più o meno consapevolmente. Si tratta appunto della fragilità. Non fosse altro, anche nell’uomo e nella donna più sani attraenti e performanti, che per l’inevitabile asimmetria fra i propri desideri e la possibilità di realizzarli. Fra questi immancabilmente e sistematicamente c’è quello di sopprimere l’idea della morte che è intrinsecamente dolorosa e quasi intollerabile. La difficoltà di farlo per tutti, ricchi e poveri, consegna invariabilmente a un destino di fragilità. Naturalmente questa circostanza, evocata con spericolato schematismo, nulla toglie alla constatazione che il fatto che gli uomini e le donne siano ontologicamente fragili non giustifica che la distribuzione delle risorse e delle opportunità di vita debba essere disuguale.
Al contrario, l’individuazione della fragilità come tratto comune e condiviso dovrebbe porsi come presupposto di un’uguaglianza delle opportunità che non è naturale, nel senso che non si realizza spontaneamente, ma è interesse vitale degli uomini nella loro totalità e, oggi, più che mai del pianeta stesso. Del resto non è difficile dimostrare la giustezza di questo assunto, specie dopo l’esperienza trasversale e planetaria della pandemia che ha fatto milioni di morti e quella della guerra ancora in corso in Ucraina che espone al rischio di una catastrofe nucleare un numero incalcolabile di persone, le quali rispetto a questo rischio sono tutte perfettamente eguali e vulnerabili, persino, stavolta, a prescindere dalla collocazione di classe.
Fragilità rassegnata, fragilità ribelle
Giunto a questo punto, è forse il caso di fare una piccola pausa di ricapitolazione, utile e necessaria a riempire i serbatoi di carburante per un viaggio che è appena all’inizio. Ciò che finora è emerso può essere riassunto in tre punti. Il primo è che la fragilità riguarda ontologicamente ciascuno degli esseri fornito di coscienza (fragilità individuale); il secondo è che esiste una fragilità prodotta da condizioni sociali sfavorevoli più o meno scandalosamente penalizzanti (fragilità sociale); il terzo è che rispetto alla fragilità individuale in sé gli uomini sono tutti uguali, anzi questo dato rappresenta il principale presupposto teorico/pratico del concetto di uguaglianza, a prescindere da criteri ideologici di valutazione. C’è poi un corollario che arricchisce la fenomenologia del tema che riguarda coloro i quali, più sfortunati, presentano contemporaneamente motivi individuali e sociali di fragilità. Della serie: non c’è limite alla malasorte.
Se si fa uno sforzo per andare appena un po’ più in profondità, sarà facile comprendere e riconoscere come della fragilità, nelle due sue varianti individuale e sociale, esistano in realtà due sottospecie. La fragilità rassegnata e quella ribelle. La prima è quella che caratterizza singoli individui o gruppi sociali che sopportano passivamente la condizione di minorità derivante dalla (maggiore o minore) propria vulnerabilità. Si parla qui di patologie mentali o fisiche o di condizioni di oppressione legate storicamente ad uno status socialmente sfavorevole, che va dalla schiavitù fino a condizioni meno estreme ma ugualmente penalizzanti. La seconda è quella che riguarda, viceversa, individui e gruppi sociali, che riconoscono la propria condizione di afflizione, di fragilità in senso lato, ma non si rassegnano ad essa. Anzi proprio grazie ad essa reagiscano e di essa fanno il presupposto, la leva, di una rivolta, di una ribellione capace di assumere le forme più varie e variamente efficaci (dal Luddismo alla Rivoluzione d’Ottobre), in grado di testimoniare comunque uno slancio vitale, individuale, di gruppo o di classe, che proprio dalla fragilità prende le mosse.
E’ appena il caso di notare come nel corso dei secoli questa variante della fragilità, sia individuale che collettiva, sia stata oggettivamente repressa da una dottrina fondata sulla speranza post-mortem e sulla provvidenza, che ha oggettivamente frenato gli istinti di rivolta e di emancipazione di singoli individui, di classi sociali e di popoli interi vittime di dittature tiranniche. Un’influenza che va oltre quella espressa dalla Chiesa Cattolica, investendo anche altre religioni e comunque il peso di un senso comune che riconosce nelle gerarchie del potere un bene in sé e di questo convince anche coloro che di queste gerarchie sono vittime. E, badate, mai come oggi questa macchinazione è attiva con l’aiuto decisivo della rivoluzione tecnologica e informatica. Lo è fino al punto che persino la Chiesa di Papa Francesco, in qualche misura, si ribella ad essa. Ma a parte questa notazione, per ritornare al punto, appare accecante l’evidenza della plausibilità di quanto affermato se si pensa a parabole individuali e collettive di rivolta alla fragilità e al bisogno, che riguardano singole figure e/o masse di popolo.
Alcuni esempi
Per quanto riguarda le prime, è sin troppo facile citare, a titolo di esempio, i vertici intellettuali del nostro Ottocento e Novecento, letterario e filosofico: Giacomo Leopardi e Antonio Gramsci: campioni assoluti di fragilità (affetti entrambi da una gravissima forma di morbo di Pott) e, insieme, di potenza intellettuale. È mia personale convinzione che, nel caso di entrambi, la fragilità non solo non abbia ostacolato la loro incontenibile forza poetica e investigativa, ma sia stata un presupposto di essa, l’”elemento negativo” di un processo dialettico che ha prodotto la “sintesi” di un’eccezionale capacità creativa e filosofica. Ancora più facile dimostrare come qualsiasi rivolta, a partire da Spartaco, per arrivare al 14 luglio della Bastiglia, alla Comune di Parigi, alla Rivoluzione d’Ottobre, a quella cinese, alle Quattro giornate di Napoli, a Castro e al Che, in tutti i casi, abbia avuto all’origine una condizione di diffusa afflizione e di fragilità che uomini capaci e coraggiosi seppero trasformare in forza rivoluzionaria. Su questa falsariga si potrebbe continuare a lungo senza trascurare esempi meno nobili e feriali di riscatto che riguardano singole e minute esperienze quotidiane che ciascuno di noi ha potuto osservare nella propria vita.
Come nani sulle spalle dei giganti
Forse è giunto, però, il momento di portare a valore l’ordine sparso di queste considerazioni, di dare loro un senso capace di andare oltre, nel migliore dei casi, i sentimenti di chi guarda con occhio compassionevole il sofferente che gli è a fianco, o peggio nasconde la propria fragilità, illudendosi di gareggiare con maggiori possibilità nella frenetica corsa al successo che oggi domina le relazioni umane. Ebbene, dopo lunghe riflessioni, mi son convinto che per andare oltre, come spesso accade, bisogna guardare indietro. E ho cercato di farlo, aiutato fra l’altro dalla mia personale internità alle vicende dell’arte che tanto hanno da dire sui rapporti fra fragilità e mondo creativo, antico e moderno. Mi ha aiutato un filosofo al quale sono molto grato: Emanuele Severino, un grande filosofo, che ha affrontato il tema scottante dell’origine della filosofia smontando la “colta” vulgata fondata, come spesso accade, sulla cattiva traduzione di una parola greca: “Thaumazein” da cui “Thauma”.
Una parola usata da Platone e Aristotele per “nominare” l’origine della filosofia. Bene, Severino ha dimostrato che “thaumazein” non significa essere “colti da meraviglia” ma, piuttosto, essere “colti da sgomento, angoscia, fragilità” di fronte all’enormità del mondo e all’angoscia della sofferenza e della morte. Ecco quindi che Severino spiega come la filosofia non nasce dalla curiosità ma dall’angoscia, dal terrore, in fondo dalla fragilità consapevole, alla quale, si vuole dare una risposta. Ecco profilarsi una pista suggestiva. Perchè allora – mi sono chiesto – dopo decenni di corsia ospedaliera e di convivenza con il mondo del dolore, non provare a dare un senso a tutto questo? Perché non ritenere che il “thauma” (la fragilità) sia coessenziale all’esperienza dell’esistere e che oltre alla filosofia, per esempio, abbia dato origine anche all’arte? L’attività umana in sé materialmente più inutile ma più sublime, così ben studiata da Georges Bataille (Lascaux. L’origine dell’arte). E ancora perchè non ritenere, provando alla stregua di un nano che sale sulle spalle di giganti come Platone, Aristotele, Severino, che tutto, tutta la vita, tutta la storia non siano altro che una risposta dialetticamente scaturita dall’esperienza della fragilità?
Le dinamiche della dialettica heghelo-marxista possono venirci in soccorso per dare rigore a questa intuizione. Ma in fondo è semplice: la fragilità è la tesi, la rivolta è l’antitesi e la storia, per come si è svolta e si svolge, è la sintesi, in cicli che si ripetono sempre in nuove forme e che, da un certo momento in poi, hanno trovato nella lotta di classe il loro motore principale. Una lotta che comunque trova sempre nella fragilità delle classi subalterne e in quella dei singoli individui la sua scaturigine. C’è poi quella fragilità che non ce la fa a ribellarsi, non si può dimenticarla. Oggi, più che mai, è ad essa che si deve guardare: per dare coraggio ai singoli e trasformare in forza e rivolta la precarietà delle masse sconfinate degli offesi.
Post scriptum
Per chi fosse interessato ad approfondire i temi che ho cercato di portare a sintesi in questa riflessione, mi permetto di segnalare un mio breve saggio, uscito per i tipi di Mimesis nel 2017, dal titolo Elogio della fragilità, nella seconda edizione del quale fu pubblicato un Manifesto della fragilità che raccolse moltissime e autorevoli adesioni ( http://www.esseblog.it/manifesto-della-fragilita/ ).
Roberto Gramiccia
22/10/2023 https://www.malacoda.it/
Foto: Olio su tela, Incubo, 1962, Ennio Calabria




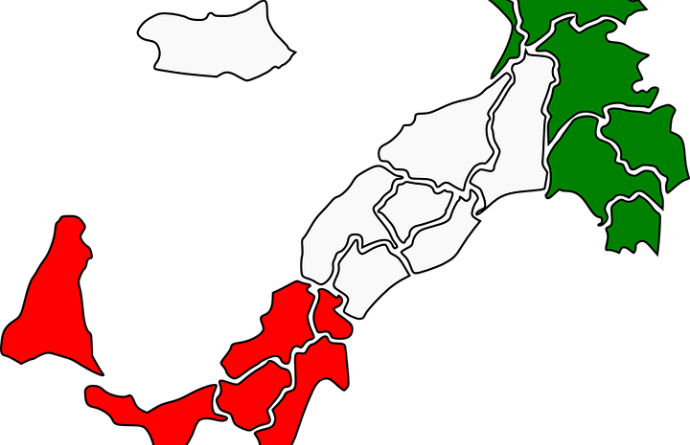





Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!