Gli artigli dell’alta finanza sul cambiamento climatico

A differenza di alcuni anni fa, alcune delle più blasonate istituzioni di potere sembrano essersi convertite all’ambientalismo. Per capire il perché ed evitare le spiegazioni più irragionevoli e superficiali occorre affondare la lama nello strato sottostante: quello degli interessi dominanti.
Prima di tutto va osservato che da svariati anni il cambiamento climatico è stato indicato da rapporti, documentati, gruppi ecologisti e le maggiori istituzioni hanno fatto orecchio da mercante, accontentandosi di qualche piccolo tocco cosmetico completamente irrilevante. Negli ultimi anni si sono accumulate avvisaglie temibili sulle relative ricadute, e dalle fonti più impensate.
L’amministrazione Trump a novembre 2018 pubblicò il gigantesco Fourth National Climate Assessment, un rapporto di 1500 pagine che prefigura delle ricadute importanti per gli USA. Si tratta di una pubblicazione che riassume un programma di ricerca direttamente condotto dal governo federale, il quale prevede che il paese stia già subendo le conseguenze del cambiamento climatico in termini di maggiori disastri naturali, e tutto ciò avrebbe un peggioramento significativo e crescente.
Solo pochi mesi fa il Direttore dell’Intelligence Nazionale (ODNI; un organo di coordinamento delle svariate agenzie nel perimetro della comunità dell’intelligence USA creato da Bush nel 2008) ha pubblicato uno scarno rapporto che qualifica il cambiamento climatico come una minaccia alla sicurezza nazionale per via di crescenti conflitti, migrazioni climatiche, competizione per le risorse.
Anche il mondo della finanza mostra di occuparsi della questione. È passato quasi completamente sotto silenzio una interessante iniziativa promossa dalla Banca di Francia, o meglio dalla ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), un organismo ad essa associato.
Gli stress test sono analisi delle attività bancarie introdotte dopo la crisi del 2007-08, volte a verificarne la solidità rispetto ad eventuali shock esterni, per minimizzare il famoso rischio sistemico. Rischio di far detonare da un qualche genere di crisi una reazione a catena che possa mettere a terra l’economia generale – e incidentalmente, spennare gli azionisti.
In generale tali tipi di analisi si sono dimostrate eccessivamente blande e non costituiscono assolutamente una garanzia che il rischio indotto dalla curvatura finanziaria dell’economia attuale sia stato portato sotto una soglia ragionevole. Ma mostra che una preoccupazione per i rischi c’è, e quanto meno intende rassicurare gli investitori.
Gli stress test della Banca di Francia hanno operato delle modalità di analisi direttamente volte ai rischi determinati dal cambiamento climatico. Essi hanno coinvolto 9 gruppi bancari e 22 organismi assicurativi (tutti solo francesi), includendo quindi circa il 75% dei portafogli assicurativi e l’85% di quelli bancari.
Purtroppo anziché un esame severo gravido di conseguenze incisive (come in effetti sono gli stress test normalmente, al di là dei conflitti di interesse e dei parametri completamente inadeguati che per esempio in Ue hanno guidato il processo), si tratta di un esame molto più morbido ed amichevole; l’adesione era volontaria. Forse per questo i risultati alla fine sembrano abbastanza rassicuranti. In ogni caso è un tipo di valutazione assai complessa, che ha preso in considerazione diversi scenari di evoluzione delle condizioni climatiche e le varie possibilità che esse possano influire negativamente. La metodologia si concentra sui settori specifici: in caso di scenario A o B cosa accadrà all’industria chimica, alla metallurgia, e come la implicazione di banche e assicurazioni in esse può rappresentare un rischio. Appaiono assai più a rischio le assicurazioni, vista la prevedibile moltiplicazione di eventi calamitosi che farebbero lievitare il costo delle polizze, tagliando fuori di fatto alcuni settori, per tariffe troppo onerose.
Il punto debole non è solo quello; in effetti i regolatori francesi hanno parlato di un esperimento pilota,e niente impedirebbe di replicarlo con maggiore incisività e minor indulgenza. La pecca è che si tratta di approcci di mercato che difficilmente arriveranno a molto, trattandosi di forme di regolazione tutte interne al sistema.
E comunque si può considerarlo un indizio importante della paura e incertezza che cova sotto la cenere; già il fatto che alcuni problemi degli istituti francesi siano emersi può considerarsi un mezzo miracolo, visto che nessuno di essi ha alcun interesse a mostrare in pubblico le criticità che possono gettare un velo di dubbio sulla loro affidabilità.
Se sotto sotto fa capolino la coscienza presso l’oligarchia mondiale che le dinamiche dominanti accrescono i rischi per le società e le economie (e, conseguentemente, per i suoi profitti) il risultato sarà forse di mettere in discussione l’orientamento privatistico-mercatista?
Ovviamente no.
Nel corso della conferenza COP 26 a Glasgow sul clima Mario Draghi ha affermato:
Non è un problema di soldi. Oggi abbiamo capito una cosa: a prescindere dal fatto che si tratti di nuove tecnologie o programmi infrastrutturali per l’adattamento ai cambiamenti climatici, il denaro può non essere più un vincolo se portiamo dalla nostra parte il settore privato. Parliamo di decine di trilioni di dollari.
Facendo eco ad un altro ex banchiere, Mark Carney, governatore della Bank of England fino a marzo 2020, secondo cui:
“Se guardiamo alla situazione oggi, vediamo che ci sono 130mila miliardi di dollari [sic!] nel core della finanza globale che in modo crescente cercano progetti ad emissione zero, e sarebbero lieti di andare presso una grande impresa […] per prestarle i soldi o investirci se hanno dei piani per abbattere le emissioni”.
Si comincia a capire dove si vuole andare a parare. L’ex governatore non parla a titolo personale, ma a nome di un gruppo chiamato Glasgow Financial Alleance for Net Zero (GFANZ) che comprende 450 soggetti appartenenti ad ogni segmento del settore finanziario: assicurazioni, banche, agenzie di rating, consulenza finanziaria, un po’ tutti insomma: da McKinsey a Deutsche Bank, da Morgan Stanley ai Lloyd. Tutti appassionatamente dediti al fine di decarbonizzare l’economia, con altisonanti dichiarazioni e patinate brochure con illustrazioni di pale eoliche nel verde.
Negli anni scorsi aggressive lobby legate a pensatoi liberisti e a gruppi evangelici (che negano che gli esseri umani possano modificare l’assetto naturale; solo Dio può farlo, naturalmente) hanno cercato di minimizzare l’impatto del cambiamento climatico screditando coloro che lo sostenevano. Adesso pare che la strategia sia cambiata: l’alta finanza ha deciso di precipitarsi a mettere le sue luride zampacce sul tema per imporre le proprie “soluzioni”.
Fra coloro che suggeriscono di cogliere l’occasione per trasformare la crisi ambientale da problema in opportunità non ci sono solo coloro che intendono costruire una società più ecologica, più giusta e con economie soggette ad una programmazione pubblica che rigetti la supremazia del mercato; presso il gruppo GFANZ l’opportunità pare essere non quella di cambiare il sistema in modo sostanziale, ma di rinvigorirlo volgendo a vantaggio dei soggetti dominanti e padronali l’energia politica, col mitico “capitalismo verde”.
Già il fatto che la punta di diamante della finanza globale investa in un enorme numero di attività ambientalmente dannosissime con pochi imbarazzi dovrebbe indurre qualche sottile dubbio sulla genuinità di un tale afflato ecologista. Una analisi di Moody’s Investors Service a novembre scorso ci ha rivelato che le istituzioni finanziarie delle 20 principali nazioni continuano ad investire allegramente in attività ad alta emissione di carbonio, per una esposizione attuale di 22mila mld $. Un altro rapporto della società di consulenza USA segnala che ciò comporta crescenti rischi di crediti inesigibili dovuti alle catastrofi ambientali.
Se vediamo le linee di proposta di GFANZ leggiamo di tre livelli specifici: nuovi investimenti di capitale, gestione degli investimenti già esistenti e advocacy presso presso (altre) potenti corporations. Il primo elemento, accostanto al citato discorso di Draghi fa emergere le (non troppo sorprendenti) implicazioni: dato che la conversione dell’assetto economico in chiave ambientale comporterà grandissimi costi, per sostenerli sarà indispensabile la cooperazione del settore privato. Ricorda abbastanza la gestione dei servizi per i cittadini con partnership pubblico-privato, che in generale finivano bene per il privato e maluccio per il pubblico (sia nel senso dello Stato, che alla fine doveva cacciare i soldi per remunerare la controparte, sia per i cittadini-fruitori, che si trovavano con bollette esose e servizi non sempre all’altezza). Qui si parla di nuovi investimenti, e presumibilmente di prodotti finanziari “green” – campo in cui la Commissione UE si è già assai portata avanti, vedendo la finanza “verde” un’occasione per affermare la potenza dell’euro e fattore di maggiore competitività mondiale – lo scrivente ha approfondito questo tema sul secondo numero della Fionda.
Le conclusioni che possiamo trarne sono essenzialmente due:
Prima: il piano dei dominanti funzionerà se riusciranno ad intercettare il favore popolare per una risposta al cambiamento climatico ammettendone la realtà e significatività. Presumibilmente i pezzi dell’establishment occidentale più compromessi verranno sacrificati o si troverà il modo di allungare loro qualche tozzo di pane come compensazione. Presumibilmente ci saranno degli scontri sotterranei e probabilmente la sgradevole combriccola dai connotati antiscientifici e clowneschi dei pensatoi antiambientalisti quali l’Heartland Institute verrà seriamente marginalizzata – assieme a personaggi quali il “noto climatologo” Marcello Dell’Utri che nel 2009 firmò una risoluzione senatoriale che escludeva l’impronta umana dalle cause del riscaldamento climatico.
Seconda: nonostante le altisonanti dichiarazioni dell’oligarchia Ue e le montagne di policies ambientali, di documenti programmatici e green deal, resta il mercato come cardine del sistema, e la indiscussa priorità degli interessi privati come chiave di volta delle politiche pubbliche tanto nelle proposte istituzionali sul tavolo che quelle caldeggiate da conglomerati quali il GFANZ.
Keynes a proposito dell’automatismo di mercato riguardo gli investimenti (per il quale basta abbassare il tasso d’interesse per determinanre massicci investimenti) aveva usato la metafora del cavallo, che si può portarlo all’acqua ma non si può costringere a bere. Lo stesso si può dire di investimenti realmente incisivi sulle nocività ambientali: il solito mercato non basta, ci vuole lo Stato come elemento di programmazione e non solo di regolazione.
Matteo Bortolon
7/1/2022 https://www.lafionda.org/


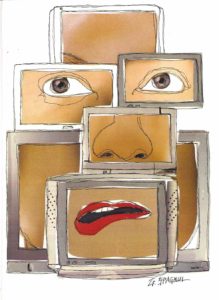







Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!