Gramsci in carne e ossa

Torino, via dell’Arcivescovado. Notte fonda, primissimi anni Venti del Novecento. Alla porta dell’Ordine Nuovo si presenta un signore dall’accento meridionale che chiede di parlare con Antonio Gramsci. Il signore dall’accento meridionale è insistente, pretende subito un colloquio col direttore della rivista (perché l’Ordine Nuovo non era solo il giornale degli operai torinesi, era anche il giornale di Antonio Gramsci).
Ma a Torino nei primi anni Venti il clima politico è teso e all’ingresso dell’Ordine Nuovo ogni sera i lavoratori delle fabbriche fanno i turni a difesa del giornale; tutti si aspettano che prima o poi le squadre fasciste si presenteranno per devastare la sede. La struttura è stata fortificata, gli operai hanno in spalla il fucile e tra il portone e le stanze della redazione si trovano un lungo corridoio, un cortile, un cancello, filo spinato, cavalli di Frisia, bombe a mano e mitragliatrici – o almeno così si dice… La guardia di turno squadra il signore (forse napoletano) per capire se si tratti di una spia della Fiat, di un fascista o di un poliziotto (o tutte e tre le cose), e gli dice che per parlare con Antonio Gramsci si dovrà mettere una benda sugli occhi, così da non poter scoprire nulla riguardo la difesa militare del giornale. A quel punto il tipo sospetto va su tutte le furie, gira i tacchi e fa per andarsene, ma dopo pochi passi si volta e urla: «Dite a Gramsci che è venuto Benedetto Croce!».
Quando Gramsci seppe dell’incidente avvenuto ne fu dispiaciuto ma ne rise anche, perché proprio non riusciva ad immaginare il più importante personaggio della cultura italiana bendato e barcollante in cerca di Gramsci. Ne rideva perché Antonio era un uomo dall’umore semplice: socievole, sorridente, che esplodeva spesso in allegre risate giovanili che mettevano tutti di buon umore. Risate buffe che «saltellavano a scatti», le risate di un uomo che «non si impermaliva mai». Un uomo abituato alle barzellette, alla compagnia e agli scherzi (fatti e ricevuti). Questa è l’immagine di Gramsci che ci arriva nitida dai suoi amici e compagni, le cui testimonianze (che compongono il corpo di fonti all’origine di questo articolo) non solo arricchiscono di dati biografici, ma ci aiutano a comprendere meglio il contesto (duro ma spesso felice) in cui si sviluppò il suo pensiero. Insomma, non l’eroe tragico e serioso che di solito si immagina. E anche se il poeta Corrado Alvaro lo definì «l’immagine di un Leopardi passato per la Val Padana col socialismo», Gramsci con Leopardi condivideva ben poco se non un’intelligenza viva, vorace e universale. In Gramsci non c’era traccia di pessimismo se non il famoso «pessimismo dell’intelligenza», che però secondo lui doveva servire per prevedere di volta in volta la peggior situazione possibile, «di modo da poter mettere in movimento tutte le riserve di volontà e ottimismo, per essere in grado di abbattere l’ostacolo». Com’è noto però Gramsci con Leopardi condivideva un corpo segnato dalla stessa malattia, il morbo di Pott. Una malattia che spesso gli procurò lo scherno da parte dei poveri d’animo e di coloro che non sapevano cosa rispondere di fronte a una schiacciante superiorità dialettica. Come quella volta nel 1925, quando i fascisti interruppero il suo unico discorso tenuto alla Camera dei deputati urlandogli: «Taci Rigoletto!». O ancora, quando durante il periodo dell’Università alcuni compagni del corso di Filosofia teoretica dissero al professor Annibale Pastore: «Si guardi da Gramsci non è che un gobbo» – «Sì, lo è ⎯ rispose lui ⎯ ma che gobbo!». Proprio come Cezanne diceva di Monet: «Non è che un occhio, ma che occhio!».
La malattia perseguitò Gramsci per tutta la vita, aggravandone le sofferenze carcerarie che lo portarono alla morte e complicandogli non poco la quotidianità. Ci si potrebbe quindi interrogare a lungo su cosa ne sarebbe stato di Gramsci se non fosse stato affetto dal morbo di Pott, ma probabilmente, come disse Giuseppe Amoretti con parole d’affetto: «Antonio non poteva essere altrimenti e un Antonio Gramsci diverso o migliore non era pensabile. Egli doveva essere quello che natura e società avevano fatto fiorire, e la sua sorte fisica e umana doveva essere una gran sorte singolare, come le sorti dei geni e degli eroi, per i quali non vi può essere né gioia, né dolore ma solo una gran via fiorita da percorrere sino in fondo».
Ma a Torino, in quei primi anni Venti, non c’era tempo da perdere e gli interrogativi esistenziali per Gramsci passavano spesso in secondo piano. Era un lavoratore infaticabile e aveva un solo datore di lavoro: la classe operaia. Ma avere a che fare con gli operai delle fabbriche torinesi non era affatto semplice, perché Gramsci (a differenza di molti intellettuali di ieri e di oggi) non pensava ai lavoratori come a dei soggetti passivi. Come dirà Umberto Calosso, in una seduta dell’Assemblea Costituente, per Gramsci la classe operaia era «l’aristocrazia del genere umano» e come tale andava trattata. Il rapporto tra intellettuali e masse doveva essere sì «educativo» ma l’insegnamento e la cultura dovevano muoversi in entrambe le direzioni: dai lavoratori agli intellettuali e viceversa, andando a costruire una reale pedagogia politica di massa. Per Gramsci non «si andava» alla classe operaia, non «si scendeva» tra i lavoratori a portare il verbo: per Gramsci «si saliva alla classe operaia». La prospettiva era quindi ribaltata in partenza e le parole di Giuseppe Ceresa (allievo di Antonio in carcere) spiegano perché Gramsci fosse percepito come un intellettuale diverso da tutti gli altri: «Vicino a lui non sentivamo quel peso, quel distacco che quasi sempre avverte un operaio quando parla con un intellettuale. Egli non ci trattava né ci considerava come dei semplici strumenti materiali dello sconvolgimento sociale, incapaci di assurgere a protagonisti coscienti e intelligenti della rivoluzione».
E fu per mettere in moto quella pedagogia politica di massa che Gramsci, nel 1919, si inventò l’Ordine Nuovo. Oltre a Gramsci c’erano altri tre redattori: Angelo Tasca, convinto pacifista della prima ora, il futuro segretario del Pci Palmiro Togliatti e Umberto Terracini che nel 1948 firmerà la Costituzione italiana in qualità di presidente dell’Assemblea costituente. Tutti meno che trentenni e tutti perseguitati in seguito da Mussolini: Tasca e Togliatti saranno costretti all’esilio mentre gli altri due riceveranno, nel 1928, condanne per 45 anni di galera dal Tribunale fascista. E tutti e quattro, come dirà Terracini, accomunati solamente da una vaga passione per la cultura proletaria: «Volevamo fare, fare, fare».
E il lavoro da fare certo non mancava. Il grande massacro del ’15-’18 si era concluso solo pochi mesi prima e non aveva portato nulla alle classi popolari se non un milione di morti. Torino era una polveriera, la rabbia proletaria si toccava con mano e gli operai non credevano più al “radicalismo parolaio” del Psi, un partito che col termine rivoluzione riempiva i propri roboanti comizi, ma che non era capace di indicare la via per passare dalla teoria alla pratica. Nel frattempo però, nel 1917, la Russia aveva suonato il campanello: Marx era grande, Lenin il suo profeta, «Pane, pace e terra» era la parola d’ordine. L’Ottobre Rosso era la speranza degli oppressi e i bolscevichi l’esempio da seguire per i settori più politicizzati della classe operaia italiana e mondiale. E in Italia i più bolscevichi di tutti erano proprio i quattro redattori torinesi dell’Ordine Nuovo.
La scintilla non poté che scoccare e nel giro di un paio d’anni il movimento operaio divampò: gli scioperi si susseguivano in un clima pre-insurrezionale, le fabbriche venivano occupate, gli operai si armavano tramutandosi in Guardie Rosse e, soprattutto, la produzione nelle fabbriche proseguiva anche durante le occupazioni. Quella che fino ad allora era nota come la città dell’automobile diventava la città dei Consigli di fabbrica, la città che i giornalisti di tutto il mondo andavano a visitare: la «Mecca del comunismo italiano», la «Pietrogrado d’Italia». Il potere operaio si affermava, quindi, non solo sul piano “militare” ma anche, e soprattutto, sul piano dell’intelligenza collettiva di una classe lavoratrice capace di sostituirsi ai padroni. E i padroni ne rimasero, giustamente, terrorizzati. Quel mondo alla rovescia era infatti uno scandalo intollerabile e solo il fascismo riuscirà a riportare l’ordine che le istituzioni liberali non erano più in grado di costruire a partire dal consenso. Un ordine e un consenso che le classi dirigenti seppero ri-ottenere solo con l’uso del bastone.
Ma nel ’19-’20 la marcia su Roma era ancora lontana, e l’Ordine Nuovo era un pullulare di attività. La redazione del giornale era ormai l’epicentro della lotta politica cittadina e ogni giorno, ogni pomeriggio, vi si svolgeva la “processione”. Dall’ufficio di Gramsci passavano tutti: compagni di Sezione e della Frazione comunista; i dirigenti del movimento giovanile e femminile; i capi sindacali. Passavano intellettuali, guardie rosse, ex docenti universitari di Antonio, compagni di base, semplici senza partito. Come si può immaginare, questo quotidiano lavorìo serviva affinché l’Ordine Nuovo non perdesse mai il contatto col movimento politico reale, però il continuo via vai creava anche qualche problema a Gramsci, che spesso non riusciva neanche a terminare gli articoli che gli venivano richiesti. E certe volte, come racconta Mario Montagnana (redattore del giornale), Gramsci andava letteralmente obbligato a scrivere: «Alle 9 o alle 10 di sera, in un momento in cui non vi erano ‘visitatori’, un redattore andava da Gramsci e gli diceva a bruciapelo: ‘Adesso non entra più nessuno fino a quando non sia pronto l’articolo’. Un giro di chiave alla porta; un compagno nel corridoio per allontanare gli ‘scocciatori’ e dopo un’ora o un’ora e mezza Gramsci ci consegnava finalmente in due o tre foglietti grandi come il palmo della mano, un articolo tracciato con una scrittura fitta, nitidissima, quasi senza una correzione».
Però, fatta eccezione per questi piccoli inconvenienti, quel continuo via vai pomeridiano permise di concretizzare l’obiettivo che la rivista si era posta sin dal suo primo editoriale: diventare una palestra di «volgarizzazione intelligente», come più tardi dirà Pia Carena, di tutte le tendenze politico-culturali più avanzate dell’epoca. E tale volgarizzazione servì a realizzare quella che più avanti diventerà una delle ossessioni di Gramsci: la formazione dei quadri di partito. Gramsci infatti cominciava a intuire che costituire un ristretto gruppo di alti dirigenti era di gran lunga più semplice che formare una vasta massa di dirigenti intermedi. Dirigenti che dovevano rappresentare il fior fiore della classe lavoratrice andando a costituire la spina dorsale di una grande organizzazione rivoluzionaria. E in questo processo di formazione si esprimevano tutta la pazienza, e la potenza, pedagogica di Gramsci, il quale continuamente spronava i compagni allo studio per convincerli che non esistevano i rivoluzionari da barricata e i rivoluzionari da tavolino ma che tutti dovevano impossessarsi della cultura in quanto essa è la più grande alleata dell’azione. E nel procedere in quest’opera «maieutica» Gramsci criticava sempre gli errori dei compagni, ma nella sua critica – racconta Montagnana – «non vi era mai nulla di negativo, nulla di scoraggiante, nulla che facesse perdere ai compagni la fiducia nelle proprie forze»: quella di Gramsci era una severità rivoluzionaria profondamente umana, sempre impersonale e che si sviluppava nella quotidianità.
Non bisogna però illudersi del fatto che Gramsci fosse solo un Socrate dal cuore dolce; egli era infatti estremamente severo e impietoso non solo con gli avversari ma anche con tutti quei compagni che, una volta raggiunta la maturità politica erano tenuti a essere sempre impeccabili diventando a loro volta maestri per gli altri. Particolarmente significativa a riguardo è una lettera che Gramsci spedì nel 1924 a Vincenzo Bianco, nella quale ricordava come a uno dei suoi primi allievi di redazione (Andrea Viglongo) facesse «riscrivere gli articoli da capo fino a 3-4 volte, di modo che passassero da otto colonne di lunghezza a una e mezzo», per giungere poi all’impietoso epilogo: «e Viglongo, che prima era un pasticcione, finì per scrivere abbastanza bene, tanto che poi immaginò di essere diventato un grand’uomo e si allontanò da noi. Perciò non farò più il pedagogo ai giovanotti del suo tipo: se potrò ancora, lo farò solo con gli operai, che non aspirano a diventare grandi giornalisti della borghesia».
Ma per noi, che siamo abituati a pensare Gramsci quasi esclusivamente come un intellettuale, potrebbe suonare strana l’affermazione di Giovanni Parodi, secondo il quale la scrittura fu la parte minore dell’attività storica e pratica di Gramsci, mentre «il suo più grande contributo è stato dato attraverso l’insegnamento orale e pratico». Parodi era appunto la perfetta incarnazione del dirigente operaio, entrato in fabbrica a 14 anni, che elevò la sua cultura politica (e il suo sapere tecnico) fino al punto di poter condurre la produzione dello stabilimento Fiat Centro durante l’occupazione delle fabbriche. E a testimonianza di quel «mondo alla rovescia» che fu la Torino del primo dopoguerra, rimane una celebre foto che ritrae gli operai seduti alla scrivania di Giovanni Agnelli. E tra di loro, a dirigere il consiglio di fabbrica, c’è proprio Giovanni Parodi.
Arrivati a questo punto si potrebbero scrivere molte pagine per cercare di spiegare quale fosse l’irripetibile alchimia che si creò attorno all’Ordine Nuovo. Quale trucco si celava dietro la figura mitica di Antonio Gramsci? Come fu possibile che una rivista che trattava temi altissimi e complessi sia diventata «il giornale degli operai»? Per quale motivo le Guardie Rosse si sarebbero fatte uccidere pur di difendere l’Ordine Nuovo dai fascisti? Ma soprattutto: come si creò quel circuito di affetti, solidarietà e lotte durissime per cui un trentenne d’oltremare, occhialuto, mingherlino e scapigliato divenne rappresentante e interprete degli interessi della classe operaia?
Se dovessimo limitarci a dare una sola risposta questa dovrebbe prendere le mosse proprio dalla biografia di Gramsci. Gramsci infatti, pur provenendo da una famiglia della piccola borghesia, visse in gioventù anni di estrema miseria a causa della carcerazione del padre condannato per peculato nel 1900. E anche se un’intelligenza eccezionale trasformò Antonio in una delle menti più luminose della cultura europea, questo non cancellò la memoria di una vita caratterizzata dagli stenti e dalle privazioni materiali, causate da un repentino declassamento sociale. Basta inoltrarsi un po’ nella biografia di Gramsci per scoprire che arrivò all’Università di Torino con una borsa di studio talmente misera da obbligarlo a scegliere tra l’acquisto della legna per la stufa e la cena. Oppure, come ci racconta Camilla Ravera: «Gramsci non aveva mai molti soldi, e quelli che aveva li spendeva in libri. A volte, ne aveva così pochi che non poteva comperare neanche i calzini e andava al giornale con ai piedi solo le scarpe». Lo stesso Togliatti, orfano di padre, pur essendo di origini modeste, non doveva pagare l’affitto perché viveva in famiglia, mentre la madre di Antonio doveva indebitarsi per mandare i soldi al figlio. Inoltre, in Gramsci, sardo fino al midollo, restava vivissimo il ricordo della vita miserabile, solitaria e incerta di molti suoi conterranei. E proprio nei ricordi di Teresa, la sorellina prediletta di Antonio, si può trovare una delle immagini più significative dell’infanzia sarda di Gramsci. Un’infanzia in cui, non potendosi permettere di comprare alcun giocattolo, Nino e Teresina i giocattoli avevano imparato a costruirseli: «Io facevo delle bambole di canna che rivestivo con piccoli pezzi di stoffa colorata, Nino faceva barche, velieri, o dei buffi uccellini col pennacchio in testa. Poi organizzavamo delle lotterie. Ogni pezzo aveva un numero e tutti i ragazzi del vicinato, figli di proprietari benestanti, venivano a tentare la fortuna. Invece dei soldi ci davano una mela o una pera».
Per cercare però di sfuggire al puro sentimentalismo si potrebbe dire che la capacità di ascolto e l’empatia di Gramsci furono certamente fondamentali, ma probabilmente il segreto del piccolo sardo si nascondeva nel rarissimo allineamento di una testa prodigiosa, di una forma mentis da intellettuale e di un vissuto materiale tanto simile a quello di un proletario. Forse fu solo questo il segreto di Antonio, che permise di portare al mondo colui che Sandro Pertini definì: «L’uomo politico di più forte ingegno incontrato sul mio cammino, la cui morte lasciò, non solo per il Partito comunista (ma per tutto il movimento operaio italiano e internazionale) un vuoto profondo, un vuoto che non è stato più colmato da nessuno».
Lorenzo Alfano
Laureato in Storia contemporanea. Appassionato lettore di Antonio Gramsci, durante l’anno passato ha avuto modo di collaborare con la Fondazione Gramsci potendo riordinare, impaginare e studiare un vasto corpo di testimonianze inerenti la vita di Antonio Gramsci. L’autore ha potuto accedere a questo materiale grazie al lavoro pregresso di Maria Luisa Righi e Francesco Giasi, lavoro senza il quale non sarebbe stato possibile scrivere neanche una riga di questo articolo. L’autore ringrazia inoltre Fabio Dei per averlo introdotto per primo alla lettura dei Quaderni del carcere.
22/1/2020 jacobinitalia.it


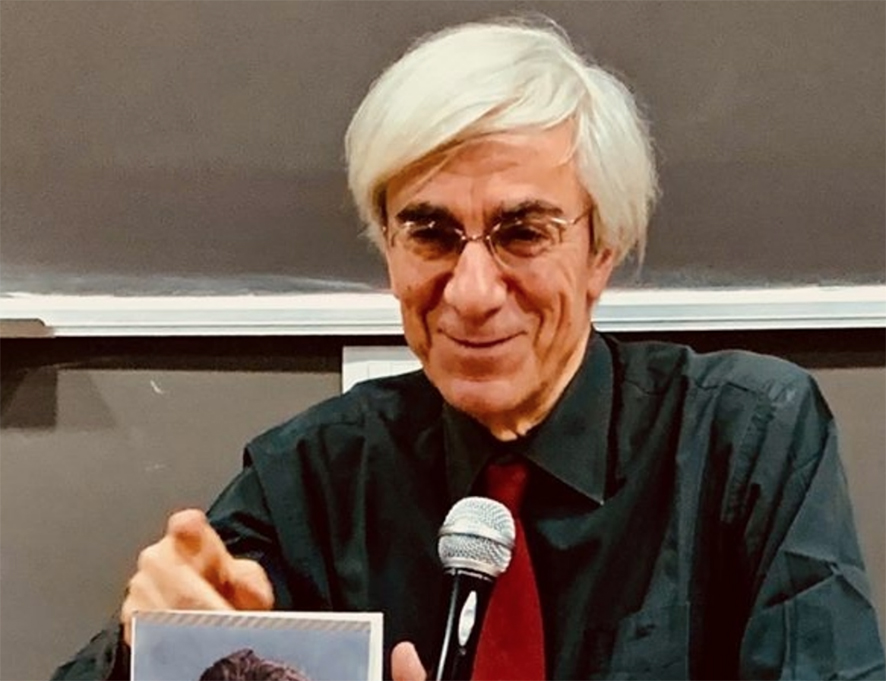







Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!