Il dissenso non piace all’establishment
La repressione dell’opinione contraria e della protesta è, da sempre, una componente del governo delle società, ché il potere, qualunque esso sia, non ama essere criticato, contestato, sovvertito. Ma le iniziative legislative contro gli “ecovandali” e la contestazione del delitto di associazione per delinquere ad alcuni di loro da parte della Procura di Padova sono campanelli di allarme di una più generale svolta autoritaria.
di Livio Pepino
Accade nel Bel Paese. Di fronte alle colorite azioni dimostrative degli attivisti di Ultima Generazione per richiamare l’attenzione sul disastro ambientale incombente l’establishment dà il peggio di sé. Da un lato il consiglio dei ministri e alcuni parlamentari di Fratelli d’Italia fanno a gara nel preannunciare interventi legislativi che prevedono sanzioni amministrative (ammenda da 10.000 a 60.000 euro e divieto di avvicinarsi a una distanza inferiore a 10 metri ad edifici “sottoposti a tutela”) e penali (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per chi «rende in tutto o in parte inservibili» ovvero «deturpa o imbratta edifici pubblici o di culto ed edifici sottoposti a tutela come beni culturali». Dall’altro la Procura della Repubblica di Padova contesta a cinque attivisti ambientali il delitto di associazione per delinquere finalizzata al deturpamento di beni culturali (sic!), accompagnando l’inizio dell’azione penale con perquisizioni e controlli prolungati della Digos. C’è da non crederci, anche se – temo – dovremo abituarci al moltiplicarsi di iniziative del genere.
Nell’attesa, alcune considerazioni si impongono. Non sulla condivisibilità o meno delle azioni dei militanti di Ultima Generazione (in merito alle quali le valutazioni possono ben essere diverse come mostrano, in questo sito, gli articoli di Pasquale Pugliese e Tomaso Montanari) né sulla bizzarra idea che i comportamenti sgraditi si contrastino con la moltiplicazione dei reati (quando già esistono fattispecie, come quelle degli articoli 518 duodeciese 635 del codice penale, che puniscono il deterioramento o il danneggiamento di beni culturali e non) o con grottesche e irrealizzabili zone rosse ad personas adiacenti agli edifici di interesse artistico (che renderanno impossibile passeggiare per Roma, Firenze o Venezia…) e neppure su un’inesistente pretesa di impunità per condotte illecite o, comunque, vietate dall’ordinamento (per le quali le risposte repressive sono messe nel conto dai movimenti, ma che spesso si sviluppano, impropriamente, con modalità sproporzionate e abnormi). Il punto su cui è opportuno soffermarsi è più generale e riguarda lo stato, nel nostro Paese, della libertà di manifestare e di esprimere il proprio dissenso.
La repressione dell’opinione contraria e della protesta è, da sempre, una componente del governo delle società: per la decisiva ragione che il potere, qualunque esso sia, non ama essere criticato, contestato, sovvertito. Per questo il conflitto tra autorità e libertà è una costante nella storia, da Antigone ai giorni nostri. Ovviamente il problema si pone in modi diversi nei regimi autoritari e nelle democrazie ché queste ultime (in quanto governo di tutti o, comunque, inclusivo) dovrebbero garantire in maniera estesa il dispiegarsi del dissenso e minimizzarne la repressione. La realtà, peraltro, propone scenari diversi. La criminalizzazione e la repressione dell’opinione e della condotta dissenziente, nelle piazze e nei tribunali, è, infatti, tuttora un fenomeno diffuso in maniera capillare ovunque, come segnala il Rapporto 2022-2023 di Amnesty International su diritti umani e repressione delle proteste nel mondo nel quale si legge: «In 77 dei 156 Stati analizzati, sono state arrestate persone che difendono i diritti umani. Maltrattamenti, in molti casi assimilabili a tortura, si sono riscontrati in più della metà dei paesi. È stato fatto un uso illegale della forza nei confronti dei manifestanti in 85 Stati».
L’attacco al diritto di protestare e la conseguente repressione assumono forme diverse anche per le modalità eterogenee con cui il dissenso e la protesta si atteggiano. Permangono, anche nei sistemi democratici, forme di repressione diretta che si estendono fino a colpire condotte lecite e non violente, espressione di diritti costituzionalmente garantiti: è il caso dell’impedimento di manifestare in alcune aree territoriali (le cosiddette zone rosse) o per alcune tipologie di soggetti (basti pensare al “blocco”, sul nascere o nel corso dello svolgimento, di cortei studenteschi o di spezzoni alternativi di cortei istituzionali) ovvero, in altro campo, della dilatazione a dismisura del concetto di diffamazione con riferimento alla contestazione di politiche ambientali o sociali e via elencando. Ma la forma di repressione e criminalizzazione più diffusa in tali contesti è quella indiretta, che si realizza non vietando o impedendo in modo esplicito comportamenti dissenzienti o contestativi ma disincentivandoli in varie forme o rendendoli difficili e rischiosi. Mi limito ad alcuni esempi: (a) la militarizzazione di interi territori o del percorso di cortei e manifestazioni (con ovvi effetti di intimidazione e provocazione); (b) l’uso abnorme della forza nelle operazioni di ordine pubblico (diventato regola a partire dalla prova generale del luglio 2001 a Genova in occasione del G8); (c) i controlli preventivi in occasione di manifestazioni, tesi a ritardare l’arrivo nel luogo convenuto di chi vuole parteciparvi); (d) la dilatazione, nel caso di eventi di massa, delle ipotesi di concorso di persone nei reati commessi da alcuni, fino a realizzare quella che è stata definita una “responsabilità da contesto”; (e) la formulazione, in sede giudiziaria, di imputazioni abnormi (di cui quella di associazione per delinquere sopra ricordata è solo l’ultimo esempio), l’uso di misure cautelari a tappeto e l’applicazione di pene spropositate anche per fatti di modesta entità; (f) le ingenti richieste di danni, in ipotesi a dir poco dubbie, anche da parte di Ministeri e di pubbliche amministrazioni; (g) un uso senza precedenti di misure di prevenzione e di fogli di via e divieti di dimora.
A questo variegato armamentario repressivo si sono aggiunti, da ultimo, due ulteriori tasselli: l’irrigidimento della legislazione penale e l’impegno concorrente di politica, apparati repressivi e media nella costruzione del nemico interno. Quanto al primo profilo, che ha avuto come ultima manifestazione il recente decreto legge anti rave, le tappe fondamentali sono state il decreto legge n. 113/2018 (primo decreto Salvini), con cui si è ripristinato in toto (salvo il caso, introdotto in sede di conversione, di ostruzione stradale realizzata con il solo corpo [sic!]) il reato di blocco ferroviario e stradale e sono state aumentate in modo abnorme le pene stabilite per il reato di invasione o occupazione di terreni o edifici (con forbice da uno a tre anni di reclusione nell’ipotesi base e da due a quattro anni in quella aggravata) e introdotta la possibilità, nell’ipotesi aggravata, di procedere a intercettazione di conversazioni o comunicazioni e il decreto legge n. 53/2019 (secondo decreto Salvini), con cui sono stati introdotti, in caso di fatti commessi nel corso di manifestazioni, rilevanti aumenti delle pene previste per l’oltraggio, la resistenza e violenza a pubblico ufficiale, l’interruzione di pubblico servizio, la devastazione e il danneggiamento (con forti limitazioni all’applicazione della sospensione condizionale della pena) e si è prevista l’impossibilità di proscioglimento per particolare tenuità del fatto addirittura in caso di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in tale contesto. Quanto al secondo fenomeno, la saldatura tra media, politica e apparati repressivi sta diventando ferrea e sta veicolando un (infondato) pensiero dominante, avallato anche a sinistra, secondo cui c’è oggi, nel conflitto sociale, una particolare violenza da affrontare con misure draconiane, fino a punte di grottesco, come l’evocazione a ogni pie’ sospinto di un pericolo anarchico o la qualificazione dell’imbrattamento dimostrativo dell’ingresso del Senato come “attacco al cuore dello Stato” (sic!).
Niente di nuovo sotto il sole, ma un indubbio salto di intensità e di qualità e l’affacciarsi di rischi elevati per la stessa tenuta della democrazia (almeno come l’abbiamo conosciuta e teorizzata). Con alcune chiose. Primo. I destinatari degli interventi repressivi si stanno, almeno in Italia, modificando. Inevitabilmente, perché cambiano i protagonisti del conflitto: assai meno il mondo del lavoro e molto più l’arcipelago variegato degli ambientalisti (che ha avuto il suo prototipo nel movimento No Tav). Secondo. La mancanza di una rappresentanza istituzionale di questo settore e di questi interessi (non diversamente, peraltro, da quello del lavoro…) rende verosimile un’ulteriore dilatazione della repressione, perché da sempre quel che non si gestisce in termini di partecipazione viene scaricato sugli apparati repressivi. Terzo. Tutto ciò accade – ed è la cosa più grave e preoccupante – senza opposizione quando non addirittura nel generale disinteresse, a differenza di quanto sta avvenendo, seppur con riferimento a settori diversi, in altri paesi occidentali (dalla Francia alla Germania, dal Regno Unito a Israele). È tempo di interrogarsi sul perché, magari proseguendo nell’analisi iniziata da Sergio Labate.
da VolerelaLuna
18/4/2023


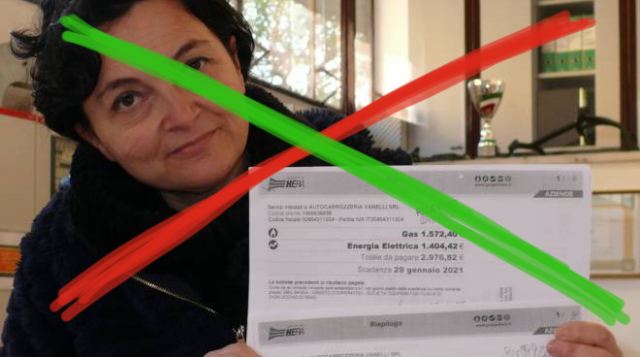







Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!