Il Governo Renzi e il lavoro pubblico

Il Governo in carica, fin dal suo insediamento, non ha fatto mistero di privilegiare il rapporto con le imprese private piuttosto che il rapporto con i lavoro dipendente e le sue organizzazioni di rappresentanza. In questo quadro generale, non fa certo eccezione la considerazione riservata al lavoro nei servizi pubblici. La concezione di lavoro pubblico dell’attuale Governo ben si abbina con la sua politica fiscale, la quale pone al centro l’impresa quale beneficiaria di risorse e provvidenze pubbliche, nella speranza che queste vengano reinvestite. Naturalmente, lo strumento che si presta a mettere in pratica tale concezione è una riduzione della spesa pubblica. L’idea di fondo è che la spesa per i servizi pubblici non costituisca altro che una sottrazione di risorse al settore privato. Dunque, bisogna ridurre la spesa e abbassare le imposte ai privati affinchè questi abbiano più risorse a disposizione. A questo fine non si disdegna di cogliere qualunque buona occasione per mettere sotto accusa il lavoratori pubblici. Ma additare il pubblico impiego quale mera fonte di spreco è in realtà un attacco al ruolo redistributivo dello stato.
1) La propaganda
Il 14 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato alcuni decreti attuativi relativi alla riforma Madia della Pubblica Amministrazione. Uno di questi decreti (inserito all’ultimo momento fra i decreti da emanare in attuzione della legge delega sulla PA, per cavalcare l’onda del caso Sanremo) prevede, per i casi di falsa attestazione della presenza in servizio, la sospensione senza contraddittorio dal lavoro entro 48 ore e, entro 30 giorni, la chiusura del procedimento disciplinare con il licenziamento. Ora, chi discorda sul fatto che, se si dimostra l’avvenuta assenza ingiustificata dal lavoro la sanzione non debba essere il licenziamento? Nessuno. Tanto è vero che detta fattispecie sanzionatoria è già prevista nei codici disciplinari dei vari comparti del pubblico impiego. Ma, per un governo che fa dell’aspetto comunicativo una ragion d’essere, la tentazione di ottenere un facile consenso facendo leva su un’indignazione preconcetta è troppo forte. Basta infatti l’impatto mediatico fornito ciclicamente dalla notizia di qualche “furbetto del cartellino” per convincere l’opinione pubblica che il maggior problema del settore pubblico è l’assenteismo, elevando la questione al livello di uno dei maggiori aspetti critici del paese. Un’altro esempio: lo scorso anno, alla reggia di Caserta, i rappresentanti dei lavoratori hanno indetto, debitamente e con ampio anticipo, un’ assemblea dei dipendenti (non tutti i diritti previsti dallo statuto dei lavoratori sono stati, finora, aboliti). Il motivo? La carenza di personale che costringe gli addetti al lavoro straordinario, anche se con una piccola particolarità: lo straordinario non veniva pagato. Ebbene, i responsabili organizzativi, piuttosto corrivamente, non hanno pensato di rendere noto all’utenza, magari affiggendo dei cartelli, che la reggia sarebbe stata chiusa per qualche ora. Apriti cielo! Le proteste dei visitatori sono state incanalate in un pretestuoso attacco contro i sindacati, rei, pur avendo esercitato un diritto, di danneggiare l’immagine del paese e provocare un’emorragia di turisti. Il governo, anche in quella occasione, subodorando una facile popolarità, ha subito annunciato provvedimenti punitivi da manuale. Da tempo si sente parlare dell’avvento di una costituzione materiale in luogo della costituzione formale, ma che lo statuto dei lavoratori fosse stato soppiantato da un fantomatico statuto del turista, proprio ci mancava. Il paese si regge a malapena sui sacrifici di coloro che riescono tuttora ad assicurare un minimo livello di servizi, ma bisogna dare l’immagine che tutto è efficiente. Il miracolo è che tale livello minimo dei servizi viene ancora erogato nonostante le cosiddette “riforme” del pubblico impiego, non grazie alle riforme del pubblico impiego.
2) La situazione reale
In Italia il personale totale (sia in regime di diritto pubblico che in regime di diritto privato) impiegato nelle amministrazioni pubbliche ammontava a fine 2012, a 3.344.000 unità mentre in Francia ammontava a 5.509.800 e in Gran Bretagna a 5.703.000. La consistenza numerica aveva iniziato a calare dal 2002. Nel 2014 il personale stabile ammontava a 3.041.227 unità (-5,5 % rispetto al 2001). Fra il 2009 e 2015, nel solo comparto “enti locali” la forza lavoro è calata di 62.000 unità (13%), al quale andrebbe sommata l’espulsione di migliaia di precari. Nello stesso comparto, causa la continua riduzione dei fondi per la contrattazione decentrata, fra il 2011 e il 2014 vi è stato un alleggerimento delle retribuzioni reali del 1,3% che ha interessato quasi esclusivamente i lavoratori a basso reddito, assoggettati peraltro, di un meccanismo di incentivazione distorto con il quale si punta, dietro il paravento del merito, a innescare una competizione tra poveri. L’ultimo contratto di lavoro del pubblico impiego è stato stipulato nel 2008. Nonostante la pronuncia che ha sancito l’incostituzionalità dei provvedimenti legislativi che, a partire dal 2010, hanno disposto la sospensione delle procedure contrattuali riguardanti gli incrementi retributivi (il blocco della contrattazione), il governo tergiversa, dato che il rinnovo dei contratti confliggerebbe con la politica di deflazione salariale raccomandata dall’Unione Europea. Soltanto nel 2015, si registra una perdita di 443 euro in media rispetto all’anno precedente. La beffa è che, nella legge di stabilità riferita al 2016, il Governo si è limitato a stanziare, per il rinnovo dei contratti di lavoro dei dipendenti pubblici, appena 300 milioni (si calcola che ciò corrisponda a circa 7 – 8 euro lordi in busta paga). La ricerca del risparmio a tutti i costi non ha soltanto colpito le già modeste retribuzioni del personale effettivo ma ha, da anni, portato ad una situazione per la quale un contratto precario è quasi un lusso. Proliferano forme collaborative quali voucher, lavoratori socialmente utili, prestazioni svolte da personale in prestito da parte di cooperative o altri enti terzi. Nonostante tali figure svolgano spesso le medesime attività del personale effettivo, uguali trattamenti economici e normativi sono un miraggio. Per non parlare dello scandalo legato agli appalti di servizi, particolarmente avvertibile nella sanità, con i quali si creano disparità di trattamento e di condizioni contrattuali fra lavoratori del settore sanitario pubblico e lavoratori del settore sanitario privato, nonchè fra lavoratori che vengono fatti transitare, a seguito di appalti di servizi che fanno perdere di vista la responsabilità del committente pubblico, dal regime contrattuale pubblico a quello privato con un immancabile peggioramento delle condizioni retributive e mansionali. Peggiorano, in generale, la qualità del lavoro, i ritmi e lo stress correlato, nonché, come detto, i livelli salariali . Con tanti saluti alla valorizzazione delle professionalità. Peggiora la percezione della qualità dei servizi da parte dei cittadini. Per effetto delle varie disposizioni che limitano il ricambio generazionale aumenta l’età media del personale pubblico, già oggi una delle più elevate d’Europa. Tutto questo non fa che determinare frustrazione e disaffezione al proprio lavoro, un processo incubatore di inefficienze che, di conseguenza, danno la stura a processi di privatizzione o esternalizzazione, cioè l’effetto atteso e, grazie al quale, è possibile giustificare nuove privatizzazioni o esternalizzazioni. La conclusione che si può trarre è quella che l’effetto della politica del lavoro pubblico seguita negli ultimi anni è stato un netto peggioramento delle condizioni di lavoro del pubblico impiego. Logica conseguenza è che in simili condizioni, i servizi, a dispetto della grancassa mediatica con la quale si pretende di proclamare una maggiore efficienza perseguita con meno risorse, non possono certo essere migliorati. La CGIA di Mestre ha reso noto uno studio secondo il quale, negli anni fra il 1995 e il 2015, vi è stato un raddoppio della lunghezza delle file agli sportelli e dei tempi di attesa.
Si obietterà che tutto questo è stato fatto perchè l’Italia ha un elevato debito pubblico. Le disposizioni finalizzate al contenimento della spesa per il personale sono rispondenti ad irrinunciabili esigenze di riequilibrio dei conti pubblici. Se non si riduce drasticamente la spesa potrebbe ripetersi quanto avvenuto nel 2011, con la presa di mira sui mercati dei nostri titoli del debito pubblico. A parte l’insensatezza di considerare il debito pubblico come un grandezza indipendente da altri parametri quali il risparmio privato e la crescita, ragionando in questo modo non si fa altro che confondere la causa con l’effetto. Ebbene, le riforme rivolte a snellire l’apparato pubblico e a contenerne i costi, si sono rivelate, dal suddetto punto di vista, controproducenti. Il debito ha proseguito la sua traiettoria ascendente. Il fatto è che per anni abbiamo assistito ad una presentazione della crisi distorta ed a senso unico. Essa sarebbe discesa da un eccesso di spesa pubblica e da una imperdonabile sproporzione tra salari e meriti dei lavoratori. I mercati, per definizione infallibili e veicoli di informazione perfetta, sanzionerebbero i paesi rei di dissolutezza e che non si dimostrano pronti nell’abbassamento dei salari e nell’abolizione di tutele e diritti del lavoro. Il rimedio? Prima di tutto ridurre la presenza dei servizi forniti dallo stato e lasciar fare al settore privato, reputato efficiente per definizione e dal cui operato deriverebbe benessere per tutti. E poi riformare il mercato del lavoro, liberalizzandolo e lasciando spazio al merito. In realtà, la crisi internazionale è dipesa dal debito privato, formatosi perchè negli ultimi decenni i governi, un po’ ovunque, hanno applicato le politiche che giusto finanza e gruppi privati hanno chiesto e ottenuto. Assenza di regole al movimento del capitale industriale (delocalizzazioni) e finanziario (speculazione), messa a vantaggio del profitto privato di beni pubblici quali acqua, viabilità, sanità, scuola, socializzazione delle perdite dei privati (a cominciare da quelle delle banche). Le politiche adottate dai governi negli ultimi decenni sono servite, e servono, a drenare enormi risorse verso le oligarchie finanziarie. Un modello di accumulazione che non poteva evitare di entrare prima o poi in crisi. Inoltre, nello specifico della situazione europea ed italiana, la crisi, con l’aggressione dei mercati finanziari nel 2011, è stata propiziata dall’insostenibile assetto liberista della UE statuito nei relativi trattati istitutivi, con i quali i paesi membri si sono di fatto privati della gestione della politica monetaria e fiscale (basti rammentare che un paese dotato del controllo della propria valuta non può fallire). Un assetto che può soltanto essere foriero di squilibri fra i vari stati membri e di conseguenti crisi.
3) Il ruolo ancillare dello stato
Siccome le condizioni della stragrande maggioranza dei lavoratori impiegati nel settore pubblico sono ben lontane dal costituire quella dispensa di privilegi di cui si favoleggia, evidentemente l’obiettivo dell’attacco deve essere un altro: indicare il servizio pubblico quale fonte di spreco e di inefficienza al fine di consolidare il predominio del mercato quale unico regolatore dell’economia e, di conseguenza, mettere a profitto con le privatizzazioni beni che per definizione dovrebbero restare “sociali”. Tralasciamo il discorso, che ci porterebbe lontano, sulla crisi di accumulazione nel quale il capitalismo si dibatte da decenni. Quello che interessa qui mettere in evidenza è una strategia, messa in atto da parte di certa politica compiacente, mirata ad assecondare gli interessi dei poteri che contano. Allora, attaccare il lavoro pubblico è un modo surrettizio di attaccare e depotenziare il ruolo del settore pubblico in generale. Per coloro che l’hanno scordato, sarebbe opportuno ribadire che i servizi pubblici universali costituiscono una forma di salario indiretto. Privatizzarli e renderli disponibili a pagamento danneggia in misura maggiore i percettori di redditi bassi (che solitamente sono lavoratori del settore privato già colpiti dalla crisi). Purtroppo, il fascino discreto del liberismo ha fatto breccia e si è insinuato anche negli strati sociali che dovrebbero trarre maggior beneficio dall’universalità dei servizi. L’individualismo solipsistico si è ormai incarnato a tal punto che, da parecchi anni, i media danno notizia della ricorrenza del cosiddetto “tax freedom day”, cioè il giorno nel quale il cittadino smette di lavorare per lo stato (come se esso fosse un’entità iperuranica) e finalmente inizia a lavorare per se stesso, vale a dire, nella percezione comune, per il benessere proprio.
Da troppo tempo, una politica “catturata” dagli interessi che contano non è in grado di cercare soluzioni che vadano al di là della limitazione dei diritti del lavoro e della provvista di incentivi alle imprese, pure in mancanza di una vera strategia industriale. Lo si è ben constatato con l’indiscriminata erogazione degli incentivi associati al contratto a tutele crescenti introdotto con la riforma del lavoro detta “jobs act”. Un vero e proprio trasferimento di risorse pubbliche miliardarie a vantaggio del settore privato (con annessa corsa all’accaparramento facendo ricorso perfino, pare, a mezzi truffaldini) che non ha avuto alcun rilevante effetto sulla cosiddetta “buona occupazione”.
Ma il settore privato mette al proprio servizio il settore pubblico in ulteriori due modi: con una progressiva deregolamentazione e con una politica fiscale funzionale all’interesse delle imprese piuttosto che al ripianamento delle disparità sociali che si creano nel mercato.
Uno dei fondamenti dell’ideologia liberale è che la legislazione sia solo un “vincolo”, o, come si suol dire, un “laccio o lacciuolo”. La parola d’ordine degli ultimi anni è stata (ed è tuttora) “offerta”. Leggi e regolamenti sarebbero un impedimento al libero e fruttuoso sprigionamento delle migliori energie imprenditive.
Ecco allora che, nella (vana) speranza che ciò avrebbe costituito un ingrediente fondamentale del rilancio, si è introdotto, a partire dagli anni ’90, il principio secondo il quale aprire un’attività di impresa deve risultare più semplice. Per molte attività soggette a verifica di determinati requisiti è sufficiente cominciare l’attività presentando una “dichiarazione di inizio attività”. Solamente in un momento successivo ed entro un termine stabilito, l’ente pubblico di competenza avvia le attività di verifica e controllo del caso. E’ facile intuire che, in base al principio cosiddetto “cosa fatta capo ha”, è possibile che l’attività di controllo successiva possa risultare più lasca rispetto al controllo in fase preventiva e sfociare in un atteggiamento meno severo nell’esercizio dell’eventuale potere “demolitorio”.
L’istituto della “dichiarazione di inizio attività” risale, come detto, all’inizio degli anni 90, ma, con l’incedere della crisi economica, sempre in base al presupposto che regole e controlli abbiano un effetto stritolante sulle attività, vi sono stati recenti ulteriori sviluppi. Dopo l’entrata in vigore della legge 122/2010, la procedura per l’apertura un’attività di impresa risulta ulteriormente semplificata: per tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti, è sufficiente presentare una segnalazione (la Segnalazione certificata inizio attività), che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale. La Scia non è consentita soltanto in specifici casi previsti dalla legge. L’attività economica può iniziare dalla stessa data di presentazione della Scia all’amministrazione competente, senza attendere i 30 giorni previsti dalla norma precedente. Le amministrazioni avranno poi 60 giorni per esercitare i controlli ed eventualmente chiedere all’impresa, in mancanza dei requisiti necessari, la rimozione degli effetti dannosi. Come per le riforme del lavoro, però, le dosi di liberalizzazione non bastano mai. Ecco allora, che, sempre per la finalità di “liberare” chi desidera intraprendere un’attività da una esposizione a inziative interdittive che l’amministrazione competente può porre in atto, il governo attuale ha, nel 2015, con la riforma Madia, introdotto il principio del silenzio assenso (già vigente per i procedimenti a istanza di parte, o provenienti da privati) tra amministrazioni anche preposte a funzioni in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute ed ha poi limitato il potere interdittivo delle pubbliche amminsitrazioni su attività intraprese dopo la presentazione della Scia, fissando in 18 mesi il termine entro il quale è esercitabile, da parte della PA, il potere inibitorio (che comprende il divieto di prosecuzione dell’attività).
Da tanta semplificazione e liberalizzazione ci si sarebbe aspettati un’intenso impulso allo sviluppo e alla crescita delle attività. Invece, pare che le attese siano rimaste deluse. Per esempio, dal 2011 al 2015 il commercio in sede fissa, la ristorazione e il servizio bar hanno fatto segnare qualcosa come 207mila aperture e 346mila chiusure, per un saldo negativo di circa 140mila imprese. Secondo la Cgia di Mestre, sei anni di crisi economica (fra il 2008 e il 2013) hanno spazzato via 134mila piccole imprese di artigiani e commercianti, cioè le due principali categorie che formano il cosiddetto popolo delle “partite iva”. Pare proprio che, piuttosto che dagli istituti semplificatori con i loro risvolti sulla convenienza per “l’offerta”, la dinamica che qui ci interessa sembra influenzata dall’andamento del ciclo economico, e, in particolare, dall’andamento della “domanda”. La maggior parte dei lavoratori, pubblici e privati, ai quali è stata fatta pagare la crisi, non guadagna abbastanza, però bisogna continuare a dare l’illusione che il problema è costituito dallo Stato, che non incorraggia mai abbastanza l’offerta.
Altro sistema per rovesciare il meccanismo della solidarietà fiscale che dovrebbe essere il perno del ruolo statale, è la politica fiscale funzionale all’interesse delle imprese private.Pensiamo per esempio alla sanità privata: in nome della libertà di scelta si coprono, con risorse pubbliche, le spese ingiustificate e i disavanzi gestionali. Togliendo risorse al settore publico si creano liste d’attesa da tempi biblici. Così, si induce l’utenza alla fruizione delle prestazioni a pagamento. Il risultato è ovvio: se la loro ragion d’essere è il profitto, gli istituti privati fanno ciò che più rende, spesso senza curarsi necessariamente dell’appropriatezza delle cure (come gli interventi su pazienti sani).
Si è accennato alla generosità riservata dal Governo alle imprese con gli incentivi legati al “jobs act” e della connessa “liberalizzazione” del più classico istinto predatorio. Aggiungiamo soltanto che, a riprova della predilezione dell’esecutivo per gli interessi dell’intrapresa privata, la sua azione si è concentrata su provvedimenti a sostegno della redditività delle imprese e degli investimenti privati, abolizione dell’imposta sull’abitazione pricincipale anche per chi non aveva bisogno, privatizzazioni, nessuna messa in discussione delle provvidenze pubbliche a vantaggio di istruzione e sanità private.
Si senteno spesso doglianze, soprattutto da parte dei rappresentanti di associazioni quali quelle degli enti locali, relalive alla contrazione delle risorse indispensabili per assicurare il funzionamento dei servizi essenziali. Ma tale approccio è parziale e insufficiente: il vero problema è l’adesione del Governo all’approccio liberista europeo, che conferisce centralità alla politica di riduzione delle imposte finanziata con riduzioni di spesa pubblica, alla politica di riduzione dei salari e delle protezioni del lavoro, al sostegno dei profitti, alle privatizzazioni. Ciò che servirebbe è invece una presa d’atto del regresso sociale causato dalle politiche finora perseguite e un vero cambio di rotta.
Sergio Farris
4/7/2016 www.italia.attac.org







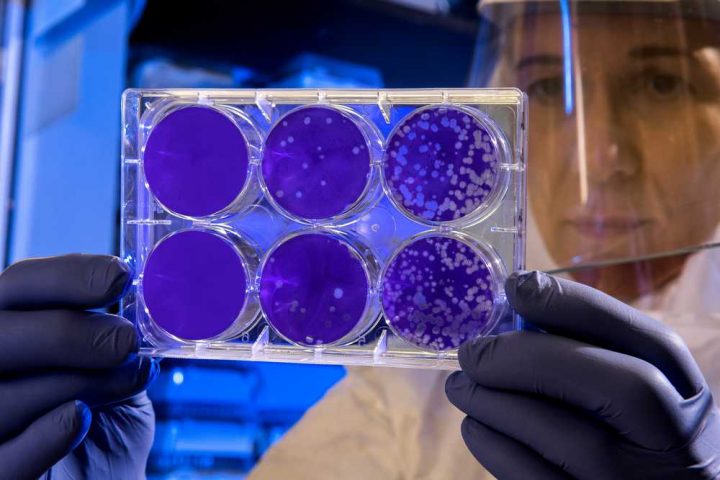


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!