Il peso degli eserciti e delle spese militari sull’aggravarsi della crisi climatica

I cambiamenti climatici alimentano conflitti e insicurezza? La risposta di Nick Buxton, ricercatore del Transnational Institute (Tni), va in una direzione inaspettata: “Eventi come siccità, inondazioni o l’aumento del livello del mare sicuramente portano insicurezza nella vita delle popolazioni che perdono le proprie abitazioni o i mezzi di sussistenza -spiega-. Ma le prove emerse fino ad ora ci dicono che i cambiamenti climatici non causano conflitti: il fattore scatenante sono le modalità con cui i sistemi politici ed economici rispondono al climate change. Non si tratta perciò del meteo ma della politica”.
Uno degli esempi maggiormente citati quando si analizza il rapporto tra guerra e clima è l’avvio della rivoluzione in Siria nel 2011. Diversi ricercatori hanno infatti indicato la grave siccità registrata negli anni precedenti come uno dei fattori scatenanti delle manifestazioni poi sfociate nella guerra civile. “Ma quando si è studiato più attentamente il fenomeno, concentrandosi in particolare sui gruppi di popolazione che dalle zone rurali si erano trasferiti nelle città, è emerso che questi non erano particolarmente coinvolti nella rivolta”, osserva Buxton. A fare la differenza, sottolinea, è stata la risposta del presidente siriano Bashar al-Assad alle proteste oltre al ruolo svolto da potenze regionali (Iran e Arabia Saudita) e globali (Russia e Stati Uniti). “In altre parole, lo scatenarsi o meno di un conflitto dipende dal modo in cui i sistemi politici rispondono alle crisi climatiche: se la popolazione ritiene che questa risposta non sia adeguata ci può essere una resistenza. Però può anche succedere qualcosa di radicalmente diverso: nel bacino del fiume Ping in Thailandia, ad esempio, le popolazioni che devono fronteggiare la scarsità d’acqua sono state in grado di ridurre i conflitti tra loro perché consapevoli di condividere un fiume e di avere un problema in comune”.
Negli ultimi anni si è diffusa una narrazione secondo cui i cambiamenti climatici causeranno scarsità di risorse, alimentando così i conflitti. Di conseguenza, in diversi Paesi si enfatizza l’esigenza di avere forze armate pronte a rispondere. Da dove nasce questa narrativa?
NB Uno dei problemi sta nel fatto che “sicurezza” è un termine ambiguo che si presta a interpretazioni difformi. Quando le persone comuni usano questa parola pensano al lavoro, alla protezione della propria famiglia, alla casa. Ma quando finisce in bocca agli apparati militari significa difesa dei confini nazionali, supporto alle proprie aziende, alle catene di approvvigionamento e garanzia di profitti. I cambiamenti climatici causano insicurezza per le persone che possono perdere le proprie case ma questo non si traduce necessariamente in una minaccia per la sicurezza nazionale. Ed è qui che è avvenuta la strumentalizzazione: l’insicurezza delle persone è stata trasformata in una questione di sicurezza nazionale per giustificare interventi militari e per aumentare così i budget di spesa.
A che cosa si riferiscono gli apparati militari quando parlano di “sicurezza climatica”?
NB Il termine compare nel 2003 in un documento prodotto per il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti da un ex dirigente della multinazionale fossile Shell e analista militare in cui vengono elencate le minacce alla sicurezza nazionale derivanti dal cambiamento climatico, che viene indicato come un moltiplicatore di minacce (ad esempio il terrorismo) e che porterà a un aumento dell’insicurezza a fronte della quale le forze armate e le agenzie di sicurezza nazionale devono essere pronte e dotate di mezzi adeguati. Questa è diventata una narrazione dominante in molti Paesi ricchi.
Gli eserciti hanno un impatto sulla crisi climatica?
NB Sono tra i principali responsabili delle emissioni di gas climalteranti: sebbene sia molto difficile avere dati precisi a causa della scarsa trasparenza del settore si stima che pesi per circa il 5,5% a livello globale. Se pensiamo che l’aviazione rappresenta il 2% è evidente che siamo di fronte a un tema che non possiamo più ignorare. Non dobbiamo poi dimenticare che le spese militari stanno aumentando a dismisura e con l’aumento dei budget cresce anche la quota di CO2 rilasciata in atmosfera. Al momento gli apparati militari sono parte del problema della crisi climatica e per di più stanno andando nella direzione sbagliata.
Recentemente la Nato e l’esercito degli Stati Uniti hanno presentato piani d’azione per la sicurezza climatica o l’impegno a ridurre le proprie emissioni. Come li valuta?
NB Si tratta di documenti piuttosto vaghi e limitati alle azioni più semplici che è possibile intraprendere, ad esempio l’installazione di pannelli solari nelle basi militari. Quello di cui non si parla in questi documenti è il fatto che il 75% delle emissioni del settore militare viene dagli aerei a reazione, dalla propulsione delle grandi navi della marina e dai veicoli di terra. E per questo settore non c’è una soluzione, anche l’utilizzo di carburanti cosiddetti alternativi o “bio-carburanti” presenta numerose criticità. Quello che avrebbe senso, invece, è ridurre le basi militari o il numero di jet. Pensiamo agli ultimi modelli di F35, uno dei principali caccia statunitensi: consumano almeno il 50% di carburante in più rispetto a quelli precedenti e questi velivoli hanno una durata di vita di almeno trent’anni, avremo quindi consumi più elevati di combustibili fossili proprio nello stesso arco di tempo in cui dovremmo agire con maggior forza per ridurre le emissioni. In conclusione, questi obiettivi non sono affatto credibili, perché per esserlo bisognerebbe ridurre le infrastrutture militari e le attrezzature militari. E questo è qualcosa che gli apparati di “sicurezza” attualmente non sono affatto disposti a fare.
I cambiamenti climatici determinano anche l’aumento dei flussi migratori. Quale ruolo hanno gli eserciti e gli apparati militari in questo ambito?
NB Il tema delle migrazioni occupa ampio spazio nei piani per la sicurezza climatica di cui abbiamo parlato: l’idea è che gli effetti del cambiamento climatico causeranno conflitti e di conseguenza spostamenti di massa dall’Africa verso l’Europa, ignorando il fatto che i migranti forzati restano in larga parte all’interno dei propri Paesi o si dirigono verso gli Stati limitrofi e solo in minima parte verso la sponda opposta del Mediterraneo. Tuttavia la risposta che danno non è garantire supporto alle persone sfollate, ma militarizzare le frontiere: le vittime del cambiamento climatico diventano minacce (o “attacchi ibridi”, ndr) alla stabilità dei Paesi ricchi.
Quali sono le risposte che vengono messe in atto?
NB Diversi Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno aumentato la spesa per la polizia di frontiera, per i mezzi di sorveglianza e per sostenere i regimi autoritari dell’Africa del Nord, dalla Libia all’Egitto, cui è stato fornito addestramento militare e di polizia, supporto alle guardie di frontiera, sistemi biometrici e imbarcazioni per il pattugliamento del Mediterraneo. Il rapporto “The global climate wall” che Tni ha pubblicato lo scorso anno evidenzia come i Paesi più ricchi spendano, in media, due volte e mezzo in più per la militarizzazione delle frontiere rispetto agli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico. E nel caso degli Stati Uniti il rapporto è di 11 volte. Tra pochi giorni inizierà la Cop27 a Sharm el-Sheikh in Egitto e di nuovo si apriranno enormi dibattiti su dove trovare i finanziamenti per affrontare la crisi climatica. La nostra risposta è chiara: stiamo spendendo enormi quantità di denaro per mantenere e potenziare gli apparati militari e di sicurezza, mentre dovremmo usare quei soldi per affrontare le cause del cambiamento climatico.
Ilaria Sesana
4/11/2022 https://altreconomia.it

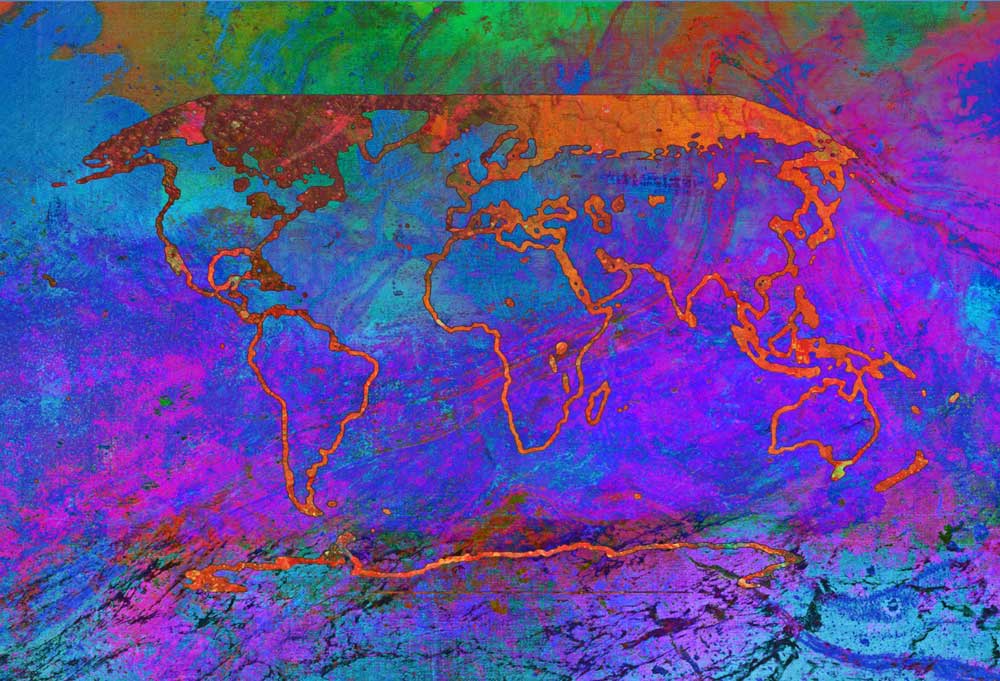








Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!