La “buona scuola” e i cattivi maestri.
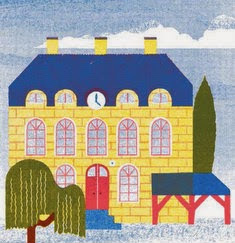
Il progetto di riforma della scuola del governo Renzi è un documento molto diverso rispetto a quelli sullo stesso tema che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Il linguaggio è agile e fluido, furbo e ammiccante, pieno di riferimenti alle nuove tecnologie e ai social media, infarcito di anglicismi fino al parossismo (non senza qualche involontario effetto comico), tessuto intorno al binomio conservazione/cambiamento – vera e propria chiave di volta dell’approccio manicheo applicato dal nuovo leader all’intero sistema politico e sociale – e imbevuto della retorica della partecipazione (naturalmente da esercitare on line). Questo nuovo linguaggio non può essere liquidato con una battuta e va studiato con la massima attenzione, perché rappresenta una forma del discorso pubblico che sta mandando definitivamente in soffitta ciò che rimane del discorso politico della cosiddetta “prima repubblica”, i cui cascami sono arrivati per forza di inerzia fino ai nostri giorni. In quel mondo, il vocabolario veniva utilizzato come liquido di diluizione per disperdere la sostanza, coltivare il compromesso, marcare una distanza tra il ceto politico professionale e i cittadini, rinviare qualsiasi decisione a un tempo indefinito.
Oggi il nuovo linguaggio che con Renzi si insedia ai vertici del potere è, all’opposto, un linguaggio che vuole coinvolgere chi ascolta, dargli fiducia e speranza, mostrare che i tempi per un cambiamento possono essere ravvicinati. È – anche – un linguaggio che occulta la sostanza delle cose che afferma, però questa dissimulazione è fatta di una materia diversa rispetto al passato: non più la mistificazione aperta o la falsa promessa, ma il raffinato illusionismo che incorpora nelle parole un significato opposto a ciò che esse rappresentano nella loro concretezza. È un collante ad alto tasso ideologico (nonostante si fondi sulla pretesa di superare ogni ideologia) che tiene insieme il puzzle delle trasformazioni caldeggiate dall’attuale governo e radicate in processi che partono da lontano. Nel documento intitolato “La buona scuola” questo nuovo linguaggio abbraccia per la prima volta in una visione unitaria tutti i pezzi che, una volta combinati tra loro, muteranno in modo radicale la natura e le funzioni della scuola pubblica. In definitiva, ha il compito molto concreto di aggregare in modo omogeneo le singole componenti di un progetto solido, articolato e denso di implicazioni sociali.
È un progetto che viene organizzato intorno ad alcuni assi principali. Per riconoscerli non bisogna farsi ingannare dallo spazio che viene dedicato a ciascun argomento. Bisogna guardare all’economia complessiva del discorso, alle voci ricorrenti in modo trasversale, alle idee-guida che – a volte – vanno colte in passaggi appena abbozzati. Se leggiamo il documento attraverso queste lenti, apparirà subito chiaro che il nocciolo del discorso non sta nel lunghissimo capitolo dedicato alla stabilizzazione degli insegnanti precari, in gran parte scelta obbligata per superare violazioni alla normativa sulle assunzioni a tempo determinato reiterate negli anni e in procinto di essere sanzionate dalla Corte di giustizia europea. I punti più importanti e più insidiosi, quelli destinati in misura maggiore a produrre trasformazioni in profondità e di lunga durata, stanno nei passaggi sul governo delle istituzioni scolastiche (che – naturalmente – viene denominato governance) e sulla meritocrazia.
Per quanto riguarda il primo punto, troviamo la riproposizione pura e semplice del disegno di legge Aprea, un progetto del governo Berlusconi che tanto era piaciuto anche al Pd, al punto che una sua versione del tutto simile (emendata dalla trasformazione delle scuole in fondazioni di diritto privato e dalla chiamata diretta degli insegnanti nelle singole scuole, entrambe recuperate nel piano Renzi) era stata proposta nella scorsa legislatura dal centrosinistra. L’idea centrale è quella di spostare in modo radicale il potere decisionale sottraendolo definitivamente agli organi collegiali. Il fatto che questi organi siano ormai ridotti a simulacro di partecipazione democratica è sotto gli occhi di tutti. Di fronte a questo stato di crisi il governo sceglie la strada più consona alla propria visione dell’esercizio del potere: sottrae ciò che ne rimane al Consiglio di istituto – trasformato in mero organo di indirizzo – e lo trasferisce interamente al dirigente scolastico. Questa diventa la figura chiave, dotata di un potere praticamente assoluto per quanto riguarda la gestione di tutti gli aspetti della vita scolastica, compresa la valutazione dei docenti ai fini del nuovo meccanismo di progressione economica (ricalcato su quello previsto dal ministro Brunetta per la valutazione dei dipendenti della pubblica amministrazione). Inoltre dovrebbe diventare il decisore anche per quanto riguarda la selezione del corpo docente, secondo quanto si può intuire dalla formulazione volutamente ambigua che nel piano lascia intendere la possibilità di assumere direttamente gli insegnanti.
Questa ridefinizione radicale del processo decisionale mostra con chiarezza che l’obiettivo del piano non è affatto la dismissione del sistema di istruzione da parte dello Stato, come si ripete spesso anche dalle parti di chi si oppone al disegno governativo. Al contrario, il progetto presuppone uno Stato ancora più accentratore che in passato, non più arroccato nelle stanze di viale Trastevere ma diffuso capillarmente nelle istituzioni scolastiche attraverso i dirigenti, che diventano – a completamento di un processo già in atto – funzionari soggetti a un forte controllo, chiamati a far applicare modelli e direttive elaborati altrove. Il fatto che tutto questo venga declinato nel nome dell'”autonomia scolastica” non deve trarre in inganno, tale è il carico di ambiguità che questo concetto porta con sé sin dai tempi della sua elaborazione da parte del ministro Berlinguer. Questa modalità della presenza dello Stato non è una garanzia per il carattere pubblico del sistema di istruzione. L’annullamento degli spazi di partecipazione (quelli reali, non quelli virtuali che vanno tanto di moda e disturbano il manovratore quanto il ronzio di una mosca), l’accentramento decisionale, la moltiplicazione dei processi di controllo sugli insegnanti e sugli studenti attraverso metodi di valutazione standardizzati, sono tasselli di un processo che mina la natura pubblica del sistema anche se ne lascia inalterata la “proprietà”.
Questo aspetto risulta ancora più chiaro se giriamo lo sguardo verso il secondo elemento cruciale del piano: la meritocrazia. Per la verità gli estensori evitano di usare questo termine, forse perché ne avvertono la sgradevolezza. Fanno però largo uso del vocabolo “merito”, che – come al solito (potremmo dire: per sua natura) – non viene declinato in alcun modo. Non è chiaro cosa significhi, né come debba essere valutato, e da chi. È una parola agitata ovunque per le sue supposte virtù taumaturgiche, ma è sempre utilizzata – e il piano scuola non fa eccezione – in modo apodittico. Non per questo è un concetto inerte. Della sua traduzione in pratica si occupa un sistema complesso e sempre più esteso di meccanismi di valutazione standardizzata che fanno capo all’Invalsi. Ancora prima di trovare una discutibile formalizzazione nell’ordinamento scolastico grazie al Sistema nazionale di valutazione varato nelle ultime settimane di vita del governo Monti (ora il piano Renzi si impegna a renderlo operativo), quei meccanismi hanno iniziato a mutare in modo sostanziale l’orientamento pedagogico della scuola, sia attraverso gli strumenti “ufficiali” (i test), sia attraverso comportamenti indotti, come l’addestramento ai test, fenomeno in rapida espansione e dagli effetti devastanti. La pretesa di misurare ciò che non è misurabile, nucleo centrale delle “prove Invalsi”, è da tempo oggetto di critiche ragionate e documentate, e sull’argomento è ormai disponibile un’ampia letteratura. Di questo dibattito il piano scuola non fa alcun cenno, a ulteriore riprova che la parola d’ordine dell’ascolto è usata come puro e semplice artificio retorico.
Le potenzialità negative dei due assi principali del documento “La buona scuola” si misurano anche guardando ciò che nel documento manca. Il piano non si occupa della didattica, del progetto pedagogico della scuola, delle finalità del sistema di istruzione. Nell’affanno di assorbire il lessico alla moda e spesso privo di significati reali, espelle dal vocabolario il termine “cooperazione”, e con esso un inestimabile patrimonio culturale sul quale è stata costruita la parte più fertile e innovativa della scuola pubblica del nostro paese. La spiegazione di tutto questo è semplice: basta guardare le biografie dei due estensori del documento (il capo di gabinetto e il capo della segreteria tecnica del ministro Giannini), che non hanno mai incontrato la scuola nel loro percorso professionale, denso di esperienze nel mondo dell’economia e della finanza, della diplomazia internazionale e delle associazioni imprenditoriali. La matrice tecnocratica del piano scuola è evidente ed esibita, ma anche esasperata, perché forse in nessun altro campo il ceto politico si è spinto fino a reclutare i “tecnici” a prescindere dalla loro competenza sulla materia. La scelta è coerente con l’impianto generale del progetto, da cui traspare la volontà di subordinare la scuola al mondo economico, di introdurre meccanismi propri del mercato (la concorrenza e la pretesa di assegnare un valore oggettivo alle “cose”) in un sistema che – per sua natura – al mercato è completamente estraneo. La “tecnica” cui il piano affida le sorti della scuola del futuro è completamente disincarnata dal suo oggetto, persegue obiettivi astratti come l'”efficienza” e pretende di misurarli con parametri mutuati da realtà sviluppate intorno a finalità completamente differenti.
Nel complesso, la “buona scuola” immaginata dal Presidente del consiglio e dai suoi collaboratori trova un terreno fertile nella società. Sul piano politico, Renzi estremizza e rende dirompente la semplificazione delle idee, sostituendo all’analisi puntuale dei problemi la ripetizione ossessiva di una serie di parole d’ordine di incredibile povertà concettuale che rappresentano innumerevoli varianti dello stesso tema: la contrapposizione tra il vecchio e il nuovo. Questa banalizzazione ha anche l’effetto di rendere meno visibile e perciò più accettabile il progressivo annullamento di ogni distinzione tra politiche contrapposte, fino a considerare del tutto normale che il documento sulla scuola presentato da un governo di centro-sinistra riprenda alla lettera proposte elaborate da un governo di centro-destra.
Sul piano culturale, la meritocrazia ha probabilmente scavato a fondo nella società, umiliata e annichilita dal mancato riconoscimento del “merito” al punto da scambiare come promessa di trasformazione radicale quella che – in realtà – è una moderna e ben mascherata ideologia della diseguaglianza.
Di fronte al documento del Governo, ci sono almeno tre errori da evitare. Il primo è quello di isolare le singole proposte e analizzarle come se fossero parti fra loro indipendenti, perdendo di vista ciò che più conta: la filosofia complessiva del progetto, che è solida, ben radicata in processi culturali sedimentati nel tempo, dotata di una visione complessiva che tende a ristrutturare in modo globale il sistema scolastico.
Il secondo errore è quello di percepire la scuola come un segmento separato rispetto al settore pubblico. L’isolamento delle singole parti del settore (anche per i corporativismi che contraddistinguono ciascuna di esse) ha impedito finora di cogliere la portata dell’azione di disgregazione bruscamente accelerata, con muscoloso accanimento, dall’ex ministro Brunetta, il quale – prendendo di mira i lavoratori – mirava a delegittimare nella sua interezza il concetto stesso di “pubblico”, inteso come complesso di servizi, rapporti sociali, diritti di cittadinanza.
Infine, sarebbe da miopi non vedere le convergenze tra la centralizzazione del potere nelle istituzioni scolastiche e i processi di centralizzazione del potere che emergono con chiarezza dal disegno di riforma costituzionale e dagli interventi legislativi che – al centro come in periferia – stanno ridisegnando l’assetto istituzionale del paese. Si tratta di un insieme di azioni e provvedimenti di natura differente che viaggiano – a ben guardare – nella stessa direzione. La questione della scuola, ancora una volta e come sempre, è intrecciata alla questione della democrazia.
Mauro Boarelli
22/2/2015 http://gliasinirivista.org/

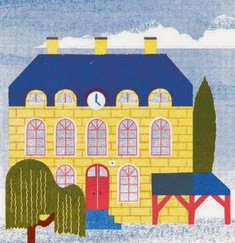


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!