LA COMUNITÀ CINESE OLTRE IL SENTITO DIRE.
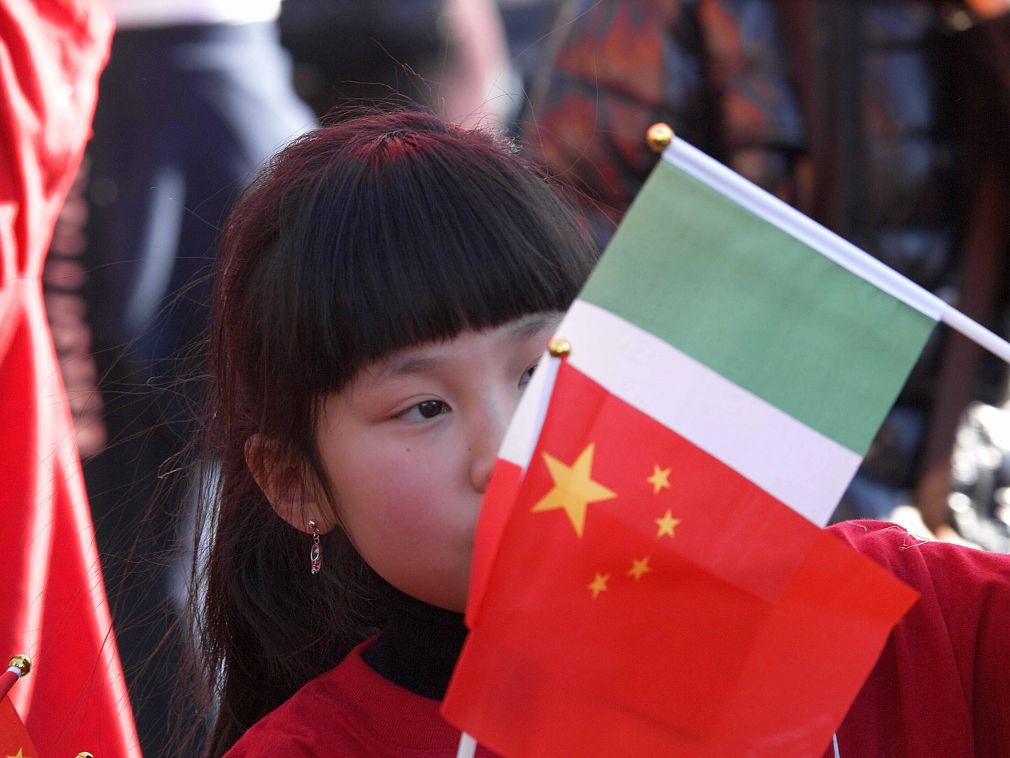
Alla fine di marzo Il Foglio annunciava il passaggio della Pirelli a ChemChina. Per l’occasione i redattori avevano intitolato la notizia in cinese, con l’intenzione di restituire il senso dell’espressione “L’Italia parla cinese”.
Anche senza accanirsi sulla questione organizzava e strutturale del pensiero nella lingua cinese, più concreta in tal senso, tanto che possa risultare privo di logica che un’estensione geografica come l’Italia – in cinese“意大利 yidali” – sia in grado di usare il linguaggio umano, la frase era scorretta su tutti i fronti.
“Lingua cinese” veniva tradotta “中国 zhongguo” che però vuol dire “Cina”. Un esempio di goffaggine giornalistica che stimola qualche riflessione a partire da un’altra inesattezza, che sembra un vero e proprio lapsus: il verbo “说 shuo” che avrebbe significato tuttalpiù “parlare una lingua” se ci fosse stato come oggetto “汉语 hanyu” ovvero “lingua cinese”, davanti alla parola “Cina”, erroneamente impiegata, può acquisire il senso di “parlare male. Volendo perciò tradurre “意大利说中国 Yidali shuo Zhonhguo” si corre il rischio che il nostro interlocutore capisca piuttosto “L’Italia parla male della Cina”.
Prendendo spunto da questa prova di superficialità, ci si chiede, tralasciando i grandi conglomerati industriali che hanno investito su Pirelli, quanto ne sappiamo della collettività immigrata che fa parlare il nostro Paese in cinese.
Incominceremo ritrattando parzialmente quanto detto sopra, considerando l’ipotesi del lapsus recondito dietro l’errore del titolo, ovvero che l’Italia parli male della Cina, per esempio, attraverso il “sentito dire” che in cinese si traduce “听说 tingshuo”: compare sempre il verbo “说 shuo” che fa riferimento all’area semantica del parlare, preceduto da “听 ting”, ascoltare, perché il sentito dire, come in italiano, è qualcosa che si ascolta e poi si dice. Vi dice niente questo incipit?
“Il container dondolava mentre la gru lo spostava sulla nave. Come se stesse galleggiando nell’aria, lo sprider, il meccanismo che aggancia il container alla gru, non riusciva a dominare il movimento. I portelloni mal chiusi si aprirono di scatto e iniziarono a piovere decine di corpi. Sembravano manichini. Ma a terra le teste si spaccavano come fossero crani veri. Ed erano crani. Uscivano dal container uomini e donne. Anche qualche ragazzo. Morti. Congelati, tutti raccolti, l’uno sull’altro. In fila, stipati come aringhe in scatola. Erano i cinesi che non muoiono mai.”
Sembra l’inizio di un hard boiled degli anni quaranta ma la voce narrante non è quella di Chandler ma di Saviano. Nel primo paragrafetto di Gomorra invece di riportare prove, documenti o indagini ufficiali, lo scrittore napoletano si affida alla testimonianza di un gruista, dando sfogo ad un immaginario quasi imbarazzante anche per i primi lettori dell’investigatore Marlowe. Proseguendo nella lettura della paginetta scarsa di questo racconto, si conoscono meglio i cinesi “cucinati nei ristorante, sotterrati negli orti d’intorno alle fabbriche, gettati nella bocca del Vesuvio”, che si passano i documenti, che puzzano di involtini primavera putrefatti, con un cartellino al collo e i soldi risparmiati per farsi seppellire in Cina a bordo di un container.
Le repliche della comunità cinese e di Associna, l’associazione dei cinesi di seconda generazione, non hanno ottenuto alcuna risposta dall’autore, che preferisce rincarare la dose dei luoghi comuni sulla Cina, affidandosi sempre al sentito dire. Un’altra dimostrazione dell’immaginifico giornalismo d’inchiesta di Saviano, infarcito di genericità e di giudizi pretenziosi, è da rintracciare nella trasmissione Quello che (non) ho, nel suo monologo sui laogai cinesi. Presentando su un tavolo degli oggetti fatti in Cina, lo scrittore fa una rivelazione sconcertante da far raggelare il sangue all’amico Fazio: “potrebbero essere tutti stati fatti in un laogai. Se i container ospitavano i cinesi nostrani che lavorano nei bar, nei ristoranti e nei laboratori di pelletteria, in un laogai” ci finisce chiunque è contro l’ideologia comunista, chiunque decida di essere religioso, nei laogai si finisce se sei un imprenditore, se sei un controrivoluzionario di destra, se sei anche una persona che ha deciso di infrangere la regola del figlio unico”.
Anche in questo caso il ritmo narrativo non è sostenuto da alcun tipo di prova. Se Saviano fosse stato in Cina sarebbe potuto entrare in chiese e in templi buddhisti e taoisti, vedere i fedeli inginocchiati con in mano bastoncini di incenso, conoscere imprenditori liberi, persino dei “controrivoluzionari”, per usare la sua terminologia quasi anacronistica nella Cina di oggi. Nei laogai avrebbe visto in grande maggioranza criminali comuni e non tutti quelli che infrangono la legge del figlio unico che sono sottoposti, semma,i al pagamento di una multa, anche perché sul loro imprigionamento non ci sono notizie sicure. Tutto questo, senza che Saviano si muovesse da Napoli, glielo avrebbe potuto dire il barista cinese sotto casa sua, almeno prima di decomporsi in un container e puzzare come un involtino primavera.
Saviano, in realtà, è solo l’esempio più illustre del trattamento riservato all’universo cinese da parte dei media. La riconferma di questa tendenza giornalistica, basata sempre sul sentito dire, la si riscontra nei servizi di informazione sui cinesi d’Italia.
Una ricerca condotta dal Centro di Prato su immigrazione cinese e stampa – che ha preso in considerazione tutti gli articoli di cronaca pratese e fiorentina apparsi dal 1988 al 1994 sulle testate de “La Nazione” e “Il Tirreno” di Prato, “La Repubblica” e “L’Unità” di Firenze – mostra in particolare alcune strategie di disinformazione adottate dalle testate giornalistiche a riguardo: sorprende ad esempio che il numero degli articoli contenenti accuse di mafia, ma non specificatamente interessati a ciò, risulta più alto rispetto a quelli espressamente dedicati all’argomento; un altro dato allarmante è relativo alle fonti utilizzate che in oltre la metà dei casi è assente, mentre, negli altri, ci si limita a riportare enfaticamente, senza alcun tipo di spirito critico, le accuse lanciate dai comitati di protesta dei nativi o a far riferimento a delle generiche “voci”.
Più recentemente programmi come Striscia la notizia e Le iene si sono scontrati con i ristoranti e le attività cinesi, come se volessero appoggiare a tutti i costi il malcontento dei commercianti italiani e alimentare la tesi per cui il successo delle imprese cinesi sia possibile a condizione di violare le leggi del nostro Paese. La iena Pif, in un servizio, era entrato in un ristorante solo per intingere la testa di un gatto di peluche nella zuppa che aveva ordinato e mostrare ai clienti l’increscioso incidente; in un altro servizio, sempre delle Iene, si parlava dello sfruttamento generalizzato dei cinesi ai danni di altri cinesi; gli inviati di Striscia in più occasioni hanno colpito i negozi cinesi che non davano lo scontrino o che vendevano giocattoli non a norma (quelli fatti nei laogai?).
Questi servizi non mettono in luce un problema ma intendono legittimare un immaginario, affinchè il sentito dire acquisti lo statuto di verità, attraverso il ricorso a singoli episodi o a realtà che non vengono approfondite. L’unica fonte che viene data per certa è quella della testimonianza diretta. Ne risulta uno scenario avvolto dal mistero e dal sospetto.
Sembra paradossale che si sappia ancora così poco e che ci si basi soprattutto sul sentito dire, su ciò che riguarda la collettività straniera più antica d’Italia, l’unica presente nel nostro Paese prima della seconda guerra mondiale. Cerchiamo perciò di conoscerla meglio, utilizzando come fonti le ricerche e le indagini condotte da sinologi e non da gruisti e giornalisti in malafede, chiedendoci innanzitutto se abbia senso parlare di “cinesi” in senso lato, dal momento che gli oltre 300.000 membri titolari di un permesso di soggiorno provengono quasi esclusivamente da un’area molto circoscritta della Cina, limitata ad alcune prefetture meridionali della provincia sud-orientale del Zhejiang.
I primi cinesi giunsero, però, nel nostro Paese non direttamente dai propri luoghi di origine ma dalla Francia, bisognosa di importare manodopera che sostituisse gli operai francesi occupati al fronte durante il primo quindicennio del Novecento. Una parte di coloro che non tornarono in patria alla fine della Grande Guerra diede vita alla comunità parigina e ai primi insediamenti a Milano.
Nel capoluogo lombardo le poche decine di cinesi si stabiliscono lungo la via Canonica, per la sua tradizionale connotazione artigianale e commerciale, che diventerà nel tempo il punto di riferimento per i nuovi arrivati.
Se in un primo momento, a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana, i componenti del gruppo lavorarono come ambulanti, vendendo collanine e cravatte, saranno poi i laboratori italiani, che producevano questi articoli, ad aprire la strada ai cinesi, assunti come dipendenti, all’impresa artigianale specializzata in cravatte e manufatti di pelle.
Nel dopoguerra e tra gli anni ’60 e ’70 nuove migrazioni e spostamenti interni ridistribuirono la presenza cinese in Italia, che oltre a Milano si insediò principalmente a Bologna e a Firenze, dove i cinesi producevano articoli di pelletteria (borse di cuoio, tela e paglia) e a Roma, dove dagli anni ’70 aprivano i primi ristoranti etnici.
Negli ultimi trent’anni il volto della collettività sinofona è diventato visibile in occasione della possibilità di regolarizzazione offerta da due sanatorie (1986, 1990), da un decreto legge (1995) e dalla fruizione degli istituti normativi inerenti al diritto di ricongiungimento familiare.
L’incremento degli arrivi dalla Cina si correla a una crescente diversificazione e diffusione delle attività: quelle nuove riguardano i servizi rivolti alla comunità stessa (erboristerie, gioiellerie, servizi immobiliari e finanziarie, agenzie di viaggio) e le imprese import-export; mentre quelle tradizionali o si sono distribuite su tutto il territorio nazionale, come nel caso della ristorazione, o si sono concentrate in alcune zone del Paese (Prato, S. Giuseppe Vesuviano), come nel caso delle confezioni.
La comunità che si è formata a partire dagli anni Ottanta si differenzia molto dal nucleo originario, non solo per il maggior numero di immigrati di questa seconda catena ma anche per quanto riguarda le dinamiche interne.
Mentre, nel primo flusso, si riscontra una notevole capacità di inserimento nel contesto italiano (quasi tutti i componenti di sesso maschile, spesso sposarono donne italiane e allevarono figli esortandoli a sentirsi italiani, in molti casi abbandonarono il cinese e il dialetto dei genitori), nel secondo, dove sono interi gruppi familiari a emigrare, non si riscontra la stessa spinta individuale all’integrazione, ma un’articolata rete di relazioni intorno alla famiglia-impresa.
La forte coesione familiare e comunitaria si coniuga a una propensione all’imprenditoria, tipica della collettività in esame, che ha sempre mostrato notevoli capacità organizzative e disponibilità finanziaria per realizzare attività produttive.
Se in ogni leggenda, come insegnano a scuola, c’è un fondo di verità, probabilmente anche nel caso del sentito dire sui cinesi d’Italia ritroviamo il procedimento mitico della trasfigurazione del reale. Sono almeno due le caratteristiche della migrazione cinese, accennate in precedenza, che hanno fornito materiale all’immaginario collettivo, ovvero la disponibilità economica e la coesione del gruppo.
In altri termini, i luoghi comuni danno, a modo loro, una risposta a certi interrogativi visibili ma non meglio precisati: i cinesi dove trovano i soldi per aprire le attività? Che cosa si nasconde dietro l’appartata e chiusa comunità cinese? Da queste domande si è generato un numero altissimo di racconti alla Saviano, classificabili per generi letterari, dal giallo al fantasy, dalle storie di mafia a quelle che vedono i cinesi come dei moderni alchimisti in possesso della formula dell’immortalità. Naturalmente ci sono anche delle spiegazioni razionali, ne forniremo qualcuna.
E’ necessario precisare che non tutti i flussi migratori sono originati da situazioni di estrema povertà e sottosviluppo, perchè le motivazioni di chi abbandona il proprio Paese non sono determinate solo da fattori di spinta (push factors) ma anche da fattori di attrazione (pull factors). Si pensi che i cinesi d’Italia provengono dalla provincia più ricca della Cina, che in patria molti di loro, già benestanti, lavoravano come artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e insegnanti.
Ma i cinesi di queste zone hanno storicamente coltivato maggiori ambizioni, fino al punto di essere definiti ai tempi della collettivizzazione delle terre come dei “capitalisti irriducibili”.
Questa tendenza è tuttora presente nella mentalità dei cinesi che arrivano in Italia per inseguire il successo professionale, sottoponendosi volontariamente a duri sacrifici in prospettiva del traguardo finale – quello di gestire una propria attività – che si ottiene grazie all’ appoggio dei legami comunitari.
C’è, infatti, una nozione in cinese che spiega questo insieme di relazioni che unisce il singolo al gruppo (familiari, soci, colleghi, amici), permettendo inizialmente l’inserimento dei suoi membri all’interno di un circuito privilegiato, che accoglie i nuovi arrivati facilitandone l’inserimento sociale e lavorativo:
“Guān xì ha vari significati: relazione, vincolo, rapporto, importanza, significato, causa, motivo. Guanxi in cinese significa anche amicizia, ma entrare nella guanxi di un cinese è come entrare a far parte di una famiglia allargata, dentro la quale l’abnegazione alla “causa comune” è totale, così come la condivisione dei beni immateriali e materiali. Chi è dentro la guanxi è come un fratello, una sorella o addirittura può essere un secondo padre, una seconda madre. Entrare in una guanxi è impegnativo, ma rimanevi è ancora più impegnativo. Un solo sbaglio e si rischia di uscirne per sempre. Rientrarci diventa poi impossibile, perché l’errore è la prova della inadeguatezza a ricevere questo onore. In Cina la parola onore ha un significato profondo. E’ un valore che si porta dentro per sempre. Per questo motivo si può essere certi della fedeltà e dell’onestà di un cinese nella sua guanxi.” (1)
Questo sistema di relazioni si basa soprattutto su prestiti. Il lavoratore alimenta la propria guanxi, versandole oltre il 50% del suo salario e, dopo qualche anno, in procinto di diventare il futuro gestore di un’impresa, potrà chiedere alla rete un sostanzioso finanziamento.
Il secondo flusso migratorio presenta perciò una configurazione decisamente più dinamica e complessa rispetto a quella del nucleo originario cinese. In particolare, per gli aspetti comunitari e identitari del gruppo, l’acculturazione non sembra verosimile in termini di “assimilazione”, come per i primi arrivati, ma è auspicabile in termini di “integrazione”, a partire dall’integrazione linguistica. Non è una considerazione ovvia, perché i processi comunitari che si propagano verso l’esterno, riguardanti l’interazione con i nativi, sono perlopiù rapporti di tipo lavorativo, tra fornitori di servizi e clienti. Questi rapporti si inseriscono all’interno delle comuni prospettive di ascesa economica sostenuta dalla guanxi, che però richiede ai suoi membri ritmi di lavoro molto elevati. Ad ogni modo, parafrasando Bauman, la comunità è percepita da chi ne fa parte come un luogo «caldo», che infonde sicurezza, dove la comprensione reciproca è garantita.
Inevitabilmente, la sicurezza garantita dalla forte coesione del gruppo porta alla delimitazione di confini che non sono specificatamente geografici ma sociali e culturali e consistono nell’accettazione di norme e valori comuni, tra cui il mantenimento della lingua materna e una conseguente distanza dal gruppo dei nativi.
I cinesi che decidono di emigrare per perseguire il successo economico, già prima di partire per l’Italia, entrano a far parte di una strutturata rete di relazioni che intercorrono in primo luogo tra lavoratori, gli organizzatori del viaggio e i laobanovvero i datori di lavoro:
“Esiste in Cina un’organizzazione che provvede a rifornire di manodopera i numerosi piccoli imprenditori cinesi residenti in Europa, i quali, in combutta con l’organizzazione criminale, trattengono l’ingente spesa del viaggio dallo stipendio dei lavoratori per versarlo poi all’organizzazione, tenendoli in una sorta di schiavitù fino a esaurimento del debito” (2).
La gestione dell’immigrato clandestino continua in Italia, per almeno due anni, il tempo necessario per il lavoratore di liberarsi dal vincolo economico che lo lega all’organizzazione.
Una tendenza confermata dal “Rapporto” del Ministero dell’Interno sulla criminalità in Italia che ha messo in luce la gestione del traffico di clandestini come la principale attività illecita perseguita dai cinesi, insieme alla contraffazione. Dagli studi condotti risulta che le organizzazioni criminali sfruttano la disperazione dei connazionali o il desiderio di affermazione in un Paese straniero per imporre condizioni svantaggiose a prezzi smisurati. Un dato emerso riguarda le spese di trasporto in Italia, che possono arrivare a costare ventimila euro.
Gli studi nell’ambito delle scienze criminali hanno insistito anche sullo sfruttamento della manodopera malpagata, riscontrando rapporti di lavoro assimilabili a quelli tra schiavo e padrone; ma un’analisi che evidenzia un problema solo in termini di devianza sociale è in realtà molto lontana dalla percezione che hanno di sé i cinesi e dai risultati delle ricerche di alcuni sinologi, come Rastrelli, che rivelano da un’altra angolazione aspetti diversi della stessa realtà:
“Pensiamo invece che nella maggioranza dei casi si formino fra imprenditori e operai accordi, improntati ad una estrema flessibilità ma che sono accordi reciprocamente riconosciuti. Il dipendente sa che emigrando ha contratto un debito che deve restituire lavorando. Molti cinesi da noi interpellati ci hanno confermato che in due o tre anni di lavoro riescono a ripagare i loro debiti per essere poi in grado di avviare una propria attività, scopo ultimo del loro progetto migratorio. L’operaio inoltre non è legato esclusivamente ad un solo laoban; il suo rapporto con lui è elastico e viene quasi sempre rinegoziato più volte l’anno. Il lavoratore dipendente, una volta adempiuto ai patti stipulati, è libero di ricercare altrove condizioni di lavoro più favorevoli. Inoltre, proprio per l’estrema flessibilità del lavoro nelle ditte cinesi, gli operai passano da un’impresa all’altra anche nel giro di pochi giorni, a seconda delle necessità della produzione” (3).
Questa visione è stata riaffermata in seguito all’incendio di una fabbrica tessile a Prato, nel dicembre 2013, che è balzata alle cronache italiane per via delle discutibili condizioni lavorative degli operai. Una pronta risposta alle polemiche sollevate in merito alla questione è stata pubblicata dal settimanale Panorama:“Non chiamateci schiavi, stiamo cercando il riscatto sociale (e voi non ci aiutate)”. Nell’articolo, scritto da una giovane giornalista cinese di seconda generazione, si spiega l’uso improprio del termine “schiavo” per quei cinesi che liberamente accettano le offerte di lavoro dei connazionali, i quali si fanno carico delle spese di vitto e alloggio, oltre alle spese per i visti di soggiorno.
I cinesi sono consapevoli che il lavoro massacrante presso un l non è altro che il passo iniziale verso l’ascesa sociale che si costruisce attraverso la guanxi. Una volta che il dipendente abbandona il lavoro, per mettersi in proprio o per sposarsi, riceverà dallo stesso l una buonuscita in denaro, a cui seguiranno i finanziamenti degli altri componenti della guanxi. E’ il volto solidale degli immigrati cinesi ed è la maniera più tangibile per rafforzare i legami.
In qualunque modo si voglia interpretare questo scenario, in bilico tra libertà di scelta e sfruttamento, una conseguenza di simili ritmi lavorativi è il ritardo acquisizionale dei cinesi. La scarsa conoscenza della lingua italiana interessa soprattutto i primi anni di soggiorno, in cui i nuovi arrivati lavorano esclusivamente per ripagare i debiti di viaggio. Lo studio della lingua non segue, quindi, un percorso lineare, come osserva anche Giacalone Ramat: “accade frequentemente coi cinesi che l’inizio dell’apprendimento non coincida con l’inizio del soggiorno, ma sia dilazionato”(4). Ma anche quando il debito è stato saldato, il lavoro occupa sempre un posto di primo piano nella scala dei valori cinesi e la forte mobilità dei lavoratori, che si spostano di frequente da una città all’altra, o da un Paese all’altro, non fa rientrare l’acquisizione dell’italiano tra i propri obiettivi.
La difficoltà comunicativa rappresenta la causa fondamentale della mancata integrazione delle comunità cinesi presenti in Italia, la cui strutturazione non espone i suoi membri (o li espone il meno possibile) a intrecciare rapporti con il gruppo nativo “esterno”:
“I nuovi arrivati si sono inseriti in comunità già organizzate, all’interno delle quali ognuno ha compiti ben precisi, fra cui quello che potremmo definire delle «public relations». Ci sono «addetti» alle comunicazioni con l’esterno che nel caso dei laboratori si occupano di tutte le questioni finanziarie, burocratiche, di acquisto delle materie prime o di vendita di prodotti finiti; nel caso dei ristoranti o di attività affini, curano soprattutto i rapporti con gli apparati burocratici e con i fornitori italiani. […] All’interno della comunità si crea dunque una situazione per cui vi è un piccolo numero di cinesi che conoscono bene l’italiano e gestiscono la maggior parte dei rapporti con l’esterno, e la maggior parte dei membri della comunità che intrattiene quasi esclusivamente relazioni intracomunitarie e risulta così piuttosto isolato rispetto alla società italiana in cui pur si trova a vivere.” (5)
Sicuramente le dinamiche comunitarie della collettività cinese, con i suoi retroterra culturali che possono apparire molto distanti dalla mentalità nostrana, non sono sempre facili da comprendere, non solo per il gruista del porto di Napoli ma anche per gli stessi studiosi. D’altra parte la scarsa italianizzazione dei cinesi di prima generazione non ha permesso un vero e proprio confronto o, per meglio dire, una difesa dei soggetti coinvolti a ben altre dinamiche giornalistiche che hanno alimentato, per usare un’espressione tanto cara a Saviano, “la macchina del fango” del sentito dire.
Da una decina di anni le seconde generazioni cinesi si stanno mobilitando, attraverso il sito di Associna, a sfatare certi luoghi comuni e a promuovere la conoscenza della Cina e dei cinesi d’Italia. Non sempre, però, i media hanno concesso a questi ragazzi il giusto spazio, preferendo quelle altre “voci” che richiamano il lapsus in prima pagina del Foglio perchè, in maniera sommaria e fantasiosa, parlano male della Cina e dei cinesi.
Note
- G.V. Travaini, Criminalità organizzata e nuova immigrazione in Italia, 2008.
- Ministero degli Interni, 2008
- R. Rastrelli, Immigrazione cinese e criminalità. Analisi e riflessione metodologiche, 2000. (http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/105/105_rast.htm#.VAyJDfl_tTo.
- Giacalone Ramat, L’acquisizione della morfologia di italiano: difficoltà e strategie di sinofonia, 2003
- S. Galli, Le comunità cinesi in Italia, 1994.
Simone Pavesi
28/6/2015 wwwlacittàfutura.it

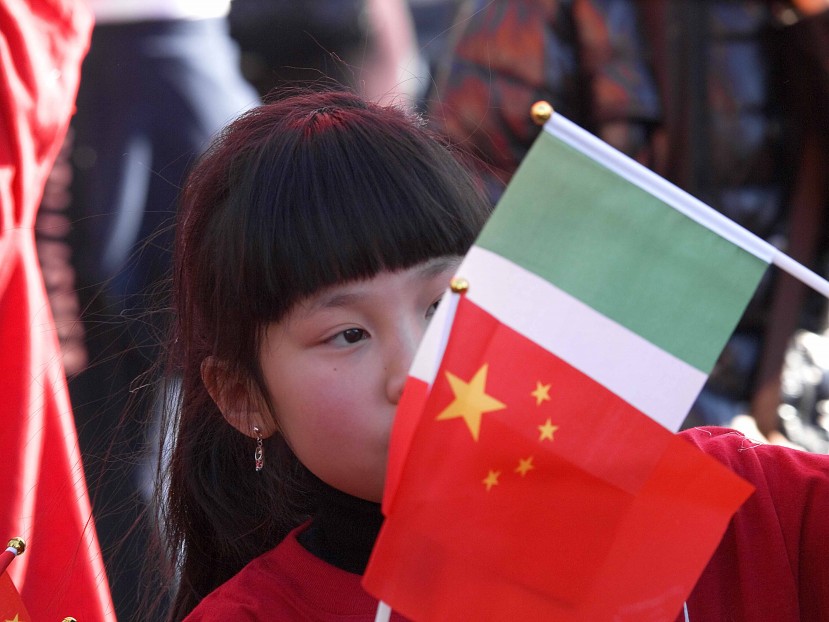


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!