La conversione ecologica firmata Eni
La rivoluzione verde sui mercati è iniziata, e sarà molto più forte di quella tecnologica degli ultimi vent’anni che ha cambiato il mondo. Nei prossimi mesi si prevedono 500 miliardi di dollari di obbligazioni green. Se la rivoluzione tecnologica è stata appannaggio di Usa e Cina, quella verde vede come capostipite l’Europa». Che l’ambiente potesse essere il prossimo ambito di profitto da parte del capitalismo finanziario era chiaro da tempo, e le parole del banchiere Luigi de Vecchi, pronunciate al Forum Compraverde lo scorso 8 ottobre, non fanno che confermarlo. Ecco perché analizzare il greenwashing delle aziende come Eni diventa fondamentale. Ed ecco spiegato il motivo per cui, andando a ritroso, da tempo la multinazionale energetica italiana si dipinge come un’azienda attenta ai territori, sostenibile nelle proprie attività produttive e addirittura leader nella lotta al cambiamento climatico. Ciò nonostante «nell’ultimo anno il cane a sei zampe ha perso quasi il 50 per cento della propria capitalizzazione», come ricorda ancora il banchiere italiano.
Per uscire nell’immediato da questo cul de sac, Eni punta ai soldi del Recovery Fund. Intervistato dal direttore de La Stampa Massimo Giannini in occasione del lancio del nuovo inserto Green&Blue da parte del gruppo editoriale Gedi – a proposito di greenwashing da parte di giornali come Repubblica e La Stampa che di ambiente finora si sono occupati poco e male –, l’amministratore delegato Claudio Descalzi è andato dritto al sodo: «abbiamo presentato un pacchetto di progetti da 6,5 miliardi […] garantirà una riduzione di oltre 6,5 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. E potremmo avere dai 70 ai 100mila posti di lavoro».
Da buon manager Descalzi snocciola sempre numeri. Cosa c’è però al di là delle cifre? Come si ottiene quella riduzione importante di anidride carbonica? Con un piano tutt’altro che ambizioso in cui rientra il salvifico progetto di cattura e stoccaggio di carbonio. Un progetto del cane a sei zampe che è raccontato in un pezzo su Green&Blue, con ai lati una pubblicità di Eni. Se scrivere di ciò che ti pubblicizza non è proprio un esempio di giornalismo super partes, vale la pena far notare che l’articolo viene pubblicato in occasione dell’assegnazione, da parte dell’Autorità britannica per il petrolio e il gas, della licenza per la realizzazione di un deposito di stoccaggio di CO2 in un’area situata nella porzione della Baia di Liverpool, nel Mare d’Irlanda Orientale. Qui Eni, come si legge nel comunicato, «prevede di riutilizzare i giacimenti esausti di idrocarburi – nello specifico i giacimenti di Hamilton, Nord Hamilton e Lennox – e riconvertire le relative infrastrutture per lo stoccaggio permanente della CO2 catturata nell’Inghilterra nordoccidentale e nel Galles settentrionale».
È un passo importante per il cane a sei zampe, perché il progetto è molto simile a quello che si intende realizzare a Ravenna. Nella costa adriatica Eni mira a stoccare nei campi a gas ormai esauriti l’anidride carbonica, catturata dagli insediamenti industriali limitrofi e dalla generazione elettrica da gas. Nelle ipotesi del management potrebbe addirittura essere il più grande sito al mondo per la cattura e lo stoccaggio di carbonio. Il condizionale è d’obbligo perché sebbene sia uno dei progetti cardine per arrivare agli ambiziosi target di riduzione delle emissioni di cui l’azienda si è dotata, ad oggi ci sono solo (tante) interviste, poche righe all’interno di documenti ufficiali, risposte vaghe a specifiche domande poste all’assemblea degli azionisti.
Come ribadito più volte dagli stessi vertici Eni, si è ancora alla fase dello studio di fattibilità mentre per una prima parziale operatività bisognerebbe comunque attendere il 2025. L’azione di pressione del cane a sei zampe è però cominciata da tempo: a giugno il premier Conte ha indicato l’hub di Ravenna come «polo di eccellenza» grazie al quale «avremo l’energia blu e l’idrogeno integrati»; a settembre l’ex ministro Lapo Pistelli, ora manager Eni, ne ha rinnovato le lodi alla Camera – ottenendo soprattutto un emendamento a favore nel decreto Semplificazioni; e negli ultimi mesi i principali quotidiani italiani, dal Corriere della sera a Repubblica a IlSole24ore, hanno ribadito l’importanza di un progetto che, per citare il quotidiano di Confindustria, «consentirà di valorizzare la filiera locale e le competenze specifiche maturate nel corso degli anni, di creare nuove opportunità di lavoro e, soprattutto, di decarbonizzare l’intera attività di Eni, nonché quella di altre realtà industriali, favorendo lo sviluppo di un distretto energetico “blu”, anche grazie alla produzione di idrogeno». Dimenticando però di sottolineare come l’uso di tecnologie Ccs (Carbon Capture and Storage) prevede di continuare a produrre energia da fonti fossili, cioè tra i principali responsabili del cambiamento climatico in atto.
A ribadirlo è Maura Peca, ricercatrice del Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali. «Non è ingiusto far risolvere la crisi climatica a chi l’ha provocata senza mettere in dubbio il sistema produttivo? Eppure è quello che sta facendo lo Stato italiano, che continua a considerare Eni un interlocutore affidabile. Si tratta della stessa azienda che intende incrementare la produzione di gas e petrolio fino al 2025, per poi sostituire nei successivi 25 anni il petrolio col gas. Cioè passando da una fonte fossile a un’altra. Ecco come si spiega l’insistenza del progetto su Ravenna».
Peca ricorda poi lo studio diffuso a luglio, ma passato sotto traccia, da parte del chimico Vincenzo Balzani, coordinatore di Energia per l’Italia. Professore emerito presso l’università di Bologna, Balzani sostiene che «lo stoccaggio di CO2 in caverne sottomarine è potenzialmente rischioso dal punto di vista geologico. Non è chiaro se siano stati valutati possibili effetti sulla sismicità indotta o innescata e sulla subsidenza della costa di Ravenna, fenomeni già in corso in modo significativo». Ad ogni modo, aggiunge Balzani, «le tecnologie Ccs sono ancora in una fase di ricerca e la loro adozione è controversa all’interno della comunità scientifica internazionale. Non è consigliabile basare una parte consistente degli investimenti e della strategia nazionale su impianti pilota per Ccs».
Sul Recovery Fund, insomma, si gioca una partita fondamentale. Specie per l’ambiente. Dove il governo, al di là dei quotidiani proclami sulla sostenibilità, non sembra avere le idee molto chiare. Ne è prova la bozza dei primi 557 progetti raccolti dai vari ministeri, fatta circolare dal Corriere della sera a metà settembre e poi in parte smentita dal governo. «C’è ancora una grande confusione, non possiamo mettere insieme il diavolo e l’acqua santa» conferma Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, al Forum Compraverde. «Non possiamo mettere insieme sullo stesso piano la necessaria decarbonizzazione dell’ex Ilva con progetti che pensano di mettere la CO2 nei fondali marini».
Se la riconversione ecologica non passa dal cane a sei zampe ciò è dovuto al fatto che la transizione energetica disegnata dall’azienda è fuori tempo massimo, troppo lenta e incentrata su massicce campagne di marketing. Così non sorprende che gli attivisti e le attiviste di Extincion Rebellion (XR) che si sono incatenati lo scorso 8 ottobre davanti alla sede romana dell’Eni, nel quartiere Eur, abbiano preferito rivolgersi al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, e prima di lui al ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, invece che al ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Perché hanno compreso che con l’arrivo dei soldi del Recovery Fund la lotta non è più ristretta soltanto all’ambiente inteso come qualcosa da tutelare e da preservare ma, ancora una volta in realtà, riguarda la sfera economica, sociale e culturale. «Il maggior azionista di Eni è Cassa Depositi e Prestiti» ricorda Andrea, attivista di XR. «Cercando di farsi finanziare dall’Europa l’hub di Ravenna, l’azienda e lo Stato mirano a ricevere soldi a debito per un progetto che è insostenibile. In questo modo si deruba un’intera comunità chiedendo poi che questo furto venga pagato dalla stessa».
Se è vero che nello specifico l’hub di Ravenna potrebbe essere finanziato dal Fondo europeo per l’Innovazione, senza cioè intaccare il Recovery Fund, è altrettanto vero che coi 209 miliardi di euro messi a disposizione dopo la crisi Covid non si arriverà ad altri mondi possibili, ma altri modi di spenderli sono comunque possibili. Uno lo suggeriscono i Radicali italiani, interpellando direttamente il ministro Costa affinché destini una parte del Recovery Fund ai Siti di Interesse Nazionale. «Porto Marghera, Casale Monferrato, Gela e il fiume Sacco
sono solo alcuni dei 41 siti di interesse nazionale (Sin), altamente inquinati a elevato rischio sanitario, sparsi su tutto il territorio nazionale – si legge nell’appello. Dal 1998 l’Italia ha stanziato oltre 3 miliardi per bonificare queste aree ma i lavori stentano a completarsi, se non addirittura a partire: sul totale della superficie gli interventi di bonifica risultano conclusi solo per il 15% dei suoli e il 12% delle acque sotterranee». Come a dire: il carbonio può attendere.
Andrea Turco
Giornalista siciliano, scrive di ambiente e temi sociali
15/10/2020 https://jacobinitalia.it







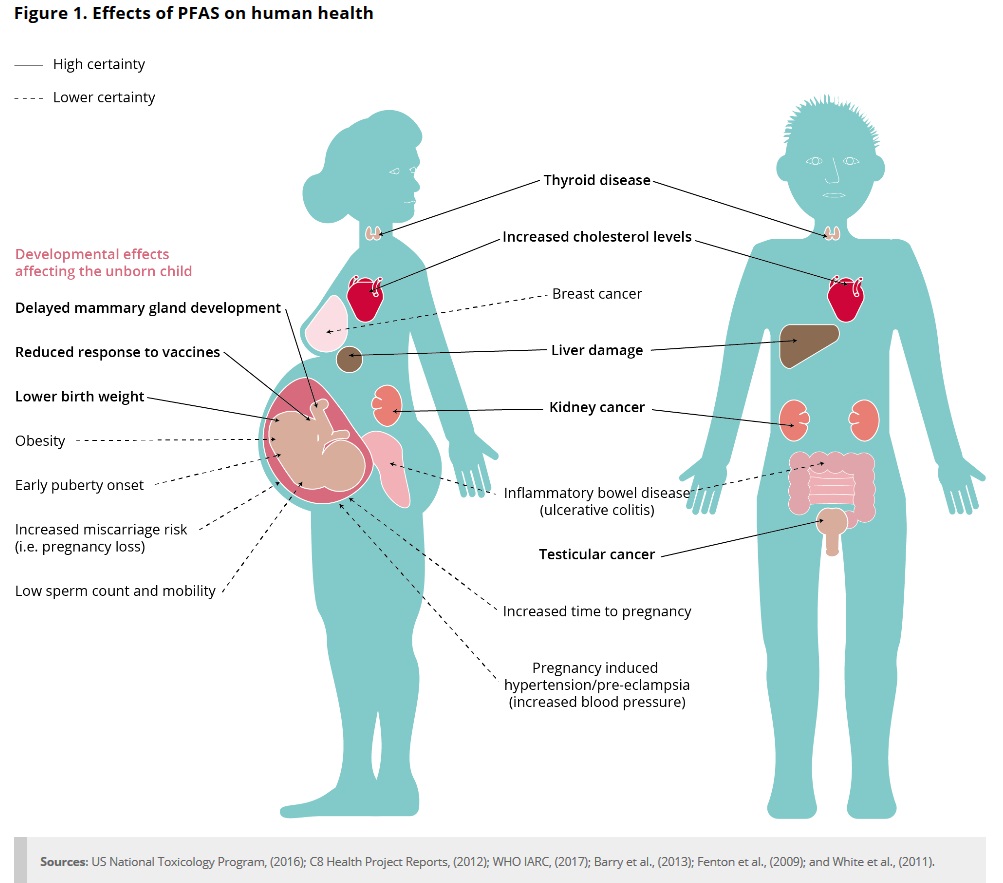


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!