La democrazia nel lusso
Molte delle critiche che vengono mosse ad una delle influencer più famose del mondo sono sulla sua frivolezza e il suo commercializzare immagini della sua vita privata. In realtà, la frivolezza è sempre esistita ma il messaggio costruito dal documentario Unposted sulla vita di Chiara Ferragni dimostra che le regole del gioco del mondo della moda stanno cambiando, e non in meglio.
C’era una volta Miranda Priestley. Nel film Il diavolo veste Prada una premiatissima Maryl Streep, nel libro da cui il film è tratto la editor della rivista di moda più importante del mondo (la versione fiction di Vogue). Spietata dittatrice del gusto, dispotica coi dipendenti, scaltra e glaciale nella vita pubblica, del tutto assente in quella privata. Per molti anni, precedenti e successivi al libro, il mondo della moda visto da fuori, raccontato da romanzi, film e insider è stato questo: una torre di cristallo e avorio che richiedeva sacrifici, abnegazione, digiuni interminabili, full commitment alla causa, ossessioni monomaniacali. Le dipendenti di Miranda Priestley, costrette a scalare taglia dopo taglia e arrampicarsi su tacchi sempre più alti e scomodi, incantevoli dame metropolitane del burnout che diventa trendy, facevano il paio con le storie di droga e anoressia di qualche anno prima di Kate Moss e dello star system newyorkese.
Poco più di dieci anni dopo, il mondo della moda si racconta ancora, ma lo fa attraverso un genere tanto diverso quanto sono cambiati i canali e le vie di trasmissione delle tendenze. Il docu-film sulla vita di Chiara Ferragni non è infatti solo una pellicola autocelebrativa della storia di una studentessa di prestigiosa università milanese diventata influencer e «imprenditrice digitale» (come si definisce) nel giro di pochi anni, ancora giovanissima, ma uno spaccato di come stia cambiando un intero settore industriale e tutto il mondo dell’opinione e della critica che vi gira intorno. I centri di rehab per modelle con disturbi alimentari e tossicodipendenza sono stati sostituiti da Spa, Hotel e Resort di lusso, ripresi dalle fotocamere degli smartphone, taggati nelle storie di instagram. La fame di sacrificare tutto, anche e soprattutto la vita privata, sull’altare della bellezza e dei canoni impossibili è stata sostituita dalla messa in mostra di tutti i particolari più intimi della vita dell’influencer. Le scene di fuga dai paparazzi in occhialoni neri, a cui le fan delle gemelle Olsen erano abituate, sono state sostituite dall’auto promozione del gossip sul proprio conto: come dice apertamente Fedez nel film, di unposted non c’è nulla, perché la coppia più chiacchierata dell’anno ha scelto di riprendere tutto ciò che riguarda il figlio Leone proprio per evitare che fossero fotoreporter e giornalisti a sbirciare nella loro vita affettiva, provando a darne un ritratto diretto tramite i social media senza l’intermediazione dei giornali scandalistici.
I digiuni debilitanti delle modelle, gli abusi sessuali, il dibattito sulla mercificazione del corpo femminile, sono stati sostituiti dalle foto al cibo che nessuno sa se venga o meno consumato, senza che le une abbiano eliminato il problema dei primi, ma nell’immaginario collettivo hanno conquistato un posto in prima fila, proprio come le influencer alle sfilate, sedute nella front row per la prima volta solo qualche anno fa, quando quei posti erano stati fino ad allora riservati solo per le grandi firme delle riviste di moda e lifestyle o per attrici e testimonial prestigiose. Sono queste infatti le parole chiave per comprendere la rivoluzione in atto nel mondo della moda (e dei consumi): disintermediazione e facilità. Negli anni Novanta e Zero entrare nel mondo della moda sembrava a tutti difficilissimo e chi ci riusciva cercava in tutti i modi di comunicare lo sforzo e la privazione necessari. Oggi diventare influencer sembra facile come scegliere il filtro dell’ultimo scatto.
Nello studio condotto sul «caso Ferragni» dalla Harvard Business Review (2015) è inserita una dichiarazione della influencer che sostiene di avere uno stile «effortlessy chic» che le richiede «meno di un’ora» per la scelta. La parabola, per come viene raccontata direttamente a Ferragni prima dalle sue interviste inserite nello studio poi in Unposted, è l’antitesi del cursus honorum fatto di rigore, vessazione e fallimento che fino a pochi anni fa rendeva, per chi lo sognava, il mondo della moda invidiabile ma irraggiungibile. La cifra di Unposted è l’idea dell’immediatezza: dal click sui sondaggi delle stories per votare l’outfit migliore, alla considerazione dell’editor di Vanity Fair intervistato nel documentario che suggerisce come «i social siano fondamentali per la democrazia».
La banalità della genialità
La vita delle influencer come Chiara Ferragni appare infatti estremamente a portata di mano. Semplice perché chiunque usi i social può avere la sensazione di poter fare qualcosa di simile, accessibile perché chiunque può fruirne a piacimento, gratuitamente, senza nemmeno pagare la copia di Vogue, che costa tanto quanto la cena alla quale Carrie Bradshaw in Sex and the City diceva di rinunciare pur di leggerla.
Per quanto nel film la Ferragni si sforzi di comunicare quanto talento e abilità servano per resistere alle critiche e alle malignità degli haters, quanto bisogni credere fortemente nei propri sogni per farli diventare realtà, il messaggio che arriva dal video, così come da ogni post, è che basta intuire le tendenze del momento per anticiparle e sfruttarle. La banalità della genialità consiste nel «sentirsi speciali», avere una famiglia amorevole alle spalle. Amorevole sì, ma anche con qualche risparmio da parte. Nel docu-film, infatti, quando si menziona quello che potremmo definire «l’influencer starter pack», si considera sicuramente il fidanzato fotografo con una qualche capacità di fare business, ma si dà totalmente per scontato che le borse di Chanel e Louis Vittuon dei primi scatti, che costano come un mese di lavoro di un infermiere o di un’operaia, fossero nella disponibilità di qualunque appassionato di moda. La carriera da influencer della Ferragni inizia su Flickr, ma prima ancora su duepuntozero.com, social network sui quali lei dice di «aver voluto condividere le proprie giornate», che però non erano certo giornate comuni. A Milano e provincia su duepuntozero.com c’erano moltissimi ragazzi e ragazze, molti dei quali curiosavano nel mondo delle serate all’Hollywood, delle felpe Richmond e degli aperitivi al Limelight organizzati dagli studenti bocconiani, ma solo un’élite poteva accedervi costantemente nella vita reale.
Correva l’anno 2009 e nella Milano che contava in pochi ignoravano l’icona della Barbie nuda nella ciotola di insalata, il marchio di The Blonde Salad, primo blog della Ferragni. Per intuire le tendenze non c’è modo migliore di essere parte del cerchio magico di chi le fa. Con lo stesso meccanismo attraverso il quale, in ogni teenage movie ambientato nelle high school statunitensi, se le ragazze più popolari della scuola portano una certa acconciatura di capelli, molte altre cercheranno di imitarle, così le foto della Ferragni ispiravano il suo pubblico: duepuntozero.com aveva in home page una sezione dedicata agli utenti più cliccati e Diavoletta87, il nickname di allora, era fissa nella lista. Duepuntozero.com era un liceo allargato, nel quale, a differenza del liceo della vita reale da lei frequentato, Ferragni aveva un ruolo da protagonista e proprio come nei teen drama di successo, faceva la parte della queen bee. Facebook era solo agli esordi quando nel 2009, anno di fondazione di The Blonde Salad, nel settembre milanese scoppia la prima Vogue Fashion Night Out: una festa notturna tra le vetrine dei principali brand di moda e le strade dello shopping, che si celebrava contemporaneamente in diverse città mondiali, per far fronte al calo delle vendite causato dalla crisi economica, ma soprattutto, si leggeva nell’intento degli organizzatori, per far partecipare i cittadini all’esperienza del mondo del fashion, accorciando le distanze tra consumatori ed esperti del settore. Un’idea dunque, quella del cercare forme di disintermediazione (se così si può dire), che la Ferragni ha saputo sfruttare a pieno ma che non era all’epoca del tutto estranea agli esperti di fashion business.
Imprenditori di sé stessi
Unposted è un inno al «se vuoi puoi». Le immagini di Chiara Ferragni commossa al ricordo di quanto i suoi genitori la facessero sentire speciale da bambina, sono costruite ad arte per dare la sensazione che chiunque abbia la self confindence (letteralmente) necessaria, possa avverare i propri sogni nel cassetto. Questo mantra, unito all’idea che la Ferragni non è un’indossatrice qualunque ma una donna forte, indipendente, che si muove a proprio agio nel mondo del business, è alla base di tutto il documentario. Come ha sostenuto la regista durante la presentazione della pellicola al Festival di Venezia, ciò che interessava era mostrare il lato da imprenditrice della giovane influencer. In questo senso, l’idea, popolarissima, dell’essere «imprenditori di sé stessi», acquisisce persino un senso letterale: nel video si dice che «Chiara è diventata il suo mezzo», ha fatto della propria vita un’impresa milionaria. Ciò che non emerge mai è l’accento sul contesto nel quale tutto questo è stato possibile. Non è un caso, infatti, che il talento sia spesso geograficamente e/o socialmente circoscrivibile, ed è facile intuire che non ci sarebbe mai stata una Chiara Ferragni della provincia di Palermo o di Catanzaro, né probabilmente una figlia di maestra di scuola elementare. Milano, l’università d’élite, una solida famiglia alle spalle, sono elementi citati solo in funzione della famosa self confidence come l’ambiente dal quale Chiara ha ricevuto risposte positive e incoraggiamento, mai come prerequisiti necessari per chiunque voglia costruirsi una carriera all’interno dell’industria della moda. Con questo non si intende che tutti i figli di famiglie molto benestanti o iscritti a prestigiose università private automaticamente costruiscano imprese multimilionarie in pochi anni, né sono inseriti da Forbes (come successo alla Ferragni nel 2015) nella lista delle personalità più influenti dell’anno, ma che senza questi ingredienti la stessa parabola è sostanzialmente irreplicabile. D’altro canto, persino in una pellicola del tutto autocelebrativa come Unposted emerge come uno degli ingredienti del successo di The Blonde Salad è stato proprio quello della costruzione di un team di professionisti di altissimo livello, esperti che un semplice appassionato di moda non inserito nelle reti sociali adeguate, non sarebbe stato in grado di identificare e raggiungere.
Ciò che nel documentario viene invece opportunamente sottolineato, come già emergeva dallo studio di Hbr, è la scelta della Ferragni fin dagli esordi di rifiutare ogni lavoro che la coinvolgesse nel mondo più generalmente detto delle celebrities e dell’intrattenimento di spettacolo e televisione per dedicarsi solo alla ricerca di contratti inerenti il mondo della moda. È da questa scelta che emerge forse il vero dato di originalità dell’impresa Tbs: l’idea di trasformare la figura dell’influencer in una figura professionale ascrivibile al fashion e non al mondo dello show business. È per questo che il fenomeno Ferragni va discusso, metaforicamente in questo caso, in rapporto alla rappresentazione dell’industria della moda più di quanto non lo si possa fare in rapporto ad altri casi di successo di youtubers o travel blogger ecc. Lo scarto è infatti tra il percepire ricompensa per la pubblicità indirizzata ai followers, con una dinamica di influenza «verso il basso», e l’idea di influenzare proprio le case produttrici, la critica, il mondo degli esperti del settore, le sue «regole del gioco». Nel documentario tutti gli esponenti intervistati, stilisti, professionisti dei brand di lusso, note firme delle riviste più rilevanti del settore, sottolineano come questo obiettivo sia stato pienamente raggiunto e come esista un «prima» e un «dopo» instagram-Ferragni nel mondo che hanno conosciuto. A questo proposito la stessa Ferragni dichiarò agli intervistatori di Harvard: «In 2011, the main followers of my blog were young girls who were inspired by what I was doing. In 2014, fashion insiders, who previously looked down on bloggers, came to read the blog».,
La fine degli arbiter elegantie
Nel documentario e non solo, Chiara Ferragni si definisce non influencer ma «imprenditrice digitale» e insiste moltissimo su come parte del suo successo sia dovuto alla necessità dei marchi del lusso e di alta moda, proprio negli anni del lancio di Tbs, di convertire almeno parte del proprio marketing su piattaforme digitali e in generale con una più accorta presenza sul web. Tuttavia, l’idea che emerge da Unposted non è mai quella di una Ferragni che si inserisce in un trend dettato dai grandi nomi della moda ma, viceversa, quello del settore che insegue e si adegua alla comunicazione e allo stile introdotto online dalle influencer. Si insiste moltissimo sull’idea che la Ferragni, dipinta come outsider, si sia fatta strada in un mondo che all’inizio era ostile al suo sforzo, salvo poi nel giro di pochi anni rincorrerla. Ne sono conferma i commenti di tutti gli esperti che compaiono nel documentario, a suggello del suo ingresso nel mondo della moda dalla porta principale. Le Miranda Priestley del 2019 sembrano aver abdicato in parte al loro ruolo, abbracciando le nuove forme di diffusione delle tendenze e l’abbattimento della gerarchia degli arbiter elegantiae. Ovviamente, essendo il profilo stesso della Ferragni sui social un’impresa, e a dispetto di ogni pretesa di essere «effortless», l’unica cosa unposted rimane chi decide per chi, cioè quali siano i nuovi canali di trasmissione delle influenze che hanno (almeno in parte) rimpiazzato i vecchi. Se è vero, come si sosteneva ne Il diavolo veste Prada, che i maglioni selezionati nella redazione del più importante magazine di moda, per il solo fatto di essere di un certo blu avrebbero condizionato tutti i blu usati nei grandi magazzini dove si sarebbe rifornita la gente comune, lo spopolare degli influencer ha sicuramente introdotto un elemento in più nella catena del condizionamento dei consumi di massa. Questo è il messaggio che Unposted vorrebbe trasmettere come se consistesse in una rivoluzione democratica del settore, questo è il punto da tenere a mente per chi sia interessato a capire quale sia il reale potere delle imprese digitali emergenti, cercando tuttavia di non cedere alla rappresentazione di un mondo senza gerarchia ma scoprendone le nuove infrastrutture materiali e sociali.
Insomma, il Fenomeno Ferragni va analizzato e capito, non solo perché offre un modello di business, ma perché ha annichilito (o sta provando a farlo) altre rappresentazioni tradizionali e precedenti dello stesso settore. Di più, molto più pericolosa della tendenza all’emulazione di ciò che indossa (il cattivo gusto può anche piacere), non si può sottovalutare l’impatto che la narrazione della semplicità e dell’immediatezza avrà sui milioni di spettatori del documentario, convinti forse che sia sufficiente essere «genuini come Chiara» per diventare icone mondiali. Al contrario, come spesso accade quando si cerca la disintermediazione, l’effetto che si ottiene non è quello di rendere un certo mondo più accessibile agli outsider ma semplicemente di costruire vie di accesso ancora più dirette per chi ha più denaro e connessioni di partenza, non certo più talento.
Il mondo di Chiara Ferragni, quello mostrato in nposted, è un universo semplice, che si divide in followers e haters, nel quale sono scomparsi i sacrifici, le condizioni di partenza, l’etica del lavoro, la dialettica tra critiche e evoluzione artistica, così come tutte le nuances possibili tra chi odia e chi adora. In questo senso, il fenomeno Ferragni andrebbe smascherato per ciò che è, cioè una finzione multimilionaria, e non stigmatizzato per le mise stravaganti, né per le continue riprese fatte e postate di un neonato, e neanche solo rispetto alla pura e semplice messa in piazza della ricchezza a livelli immorali che esibisce. C’è qualcosa di più in ballo del sentimento di ingiustizia che si prova a vedere i ricchi che si vantano della loro ricchezza. La rappresentazione che si dà del mondo della moda è qualcosa che tocca la quotidianità e condiziona milioni di persone nel mondo, influisce sui consumi ma anche sull’immaginario collettivo. È per questo che bisogna sapere che la narrazione di Unposted riduce lo spazio per la costruzione di un mondo della moda che si riconnetta alla sua vena artistica e che, muovendo oltre il fast fashion (che costa così tanto in termini ambientali e di sacrifici dei lavoratori), possa avanzare verso un’industria del bello accessibile a tutti, non solo virtualmente.
Rosa Fioravante
Ricercatrice e teaching assistant alla Luiss Guido Carli, autrice e curatrice di Bernie Sanders. Quando è troppo è troppo! (Castelvecchi 2016, seconda edizione 2018). Collabora con Fondazione Feltrinelli e Acli Lombardia
12/1/2020 jacobinitalia.it

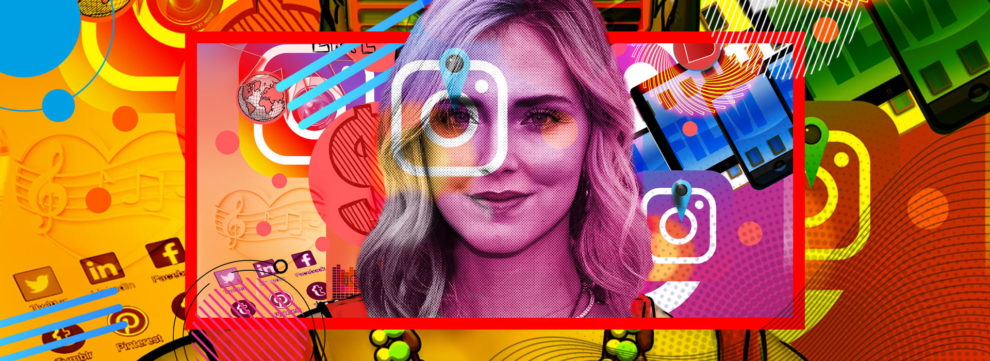









Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!