La grande fuga dal lavoro
Negli Stati Uniti e nel mondo, milioni di persone hanno lasciato l’impiego. Ne parliamo con la sociologa Francesca Coin, autrice di un libro sul tema (areaonline.ch)
The Great Resignation non è il nome dell’ultima produzione hollywoodiana. “Le grandi dimissioni” è il nome coniato dai sociologi per definire l’esodo in massa dal posto di lavoro negli Stati Uniti nell’ultimo biennio, a pandemia appena conclusa. 48 milioni di persone hanno lasciato il posto di lavoro nel 2021, quasi 51 l’anno dopo. Un fenomeno sociale non solo americano, ma riscontrabile in altre parti del mondo.
In Italia, gli abbandoni volontari dall’impiego nel 2021 sono stati quasi due milioni, cifra superata l’anno dopo seppur di poco. Fuga in massa dal lavoro in un periodo di recessione economica. Non è proprio il comportamento umano che ci si aspetti, secondo i parametri abituali. Di solito si pensa che le persone, in un periodo di crisi, il posto se lo tengano stretto.
Perché milioni di persone hanno invece fatto esattamente il contrario? Se lo è chiesto Francesca Coin, sociologa approdata alla Supsi dopo aver accumulato esperienze professionali in diversi atenei fra Italia, Inghilterra e Stati Uniti. La sua risposta al quesito sociale la troverete nel libro di prossima pubblicazione, “Le Grandi Dimissioni”, Edizioni Einaudi.
Lavoro, da sogno a incubo
La risposta avrebbe voluto darla alla fine del saggio, confessa l’autrice nell’introduzione, ma ha scelto di anticiparla parzialmente nelle prime righe del volume. Il rifiuto del lavoro «è un sintomo di una rottura epocale, della fine dell’epoca in cui regnava la speranza che il lavoro consentisse di realizzare i sogni di emancipazione, mobilità sociale e riconoscimento» spiega Coin. Come mai il lavoro da portatore di sogni sia diventato un incubo quotidiano per milioni di persone in tutto il globo, ce lo spiega la sociologa quando la incontriamo nel suo ufficio della Supsi di Manno.
La fuga in massa dal lavoro decreta «il fallimento di un modello di sistema produttivo. Quello incentrato sulla produzione snella del just in time, la riduzione dell’organico fino all’osso, l’estensione degli orari di lavoro, la precarietà economica e contrattuale». Condizioni di lavoro invivibili che producono sfinimento, burnout, malattia, depressione e nella gran parte dei casi senza neanche la compensazione di paghe decenti.
“Non si tratta di abolire il lavoro per cambiare il mondo, si tratta di cercare un modo per sottrarsi a un sistema che ti divora” si legge nel libro. Si potrebbe dunque definire l’esodo in massa dal lavoro un atto di ribellione al sistema, chiediamo alla sociologa. «La fuga dal lavoro è storicamente stata una forma di autodifesa. Nella ricerca, oltre a cercare dei dati che potessero aiutare nell’interpretazione del fenomeno, ho intervistato le persone per capirne le motivazioni personali. Dalle interviste è emerso che anche le frange più deboli nella contrattazione d’impiego quali sono i migranti, preferiscono fare i magazzinieri piuttosto di lavorare nella ristorazione. Da magazzinieri arrivano stremati a fine giornata, ma perlomeno hanno un contratto vero con orari predefiniti. Discorso identico nella grande distribuzione organizzata (Gdo), dove ti assumono con un contratto a venti ore settimanali che poi diventano abitualmente cinquanta, impedendoti così di poter organizzare la tua vita a livello familiare e sociale o di trovarti un secondo reddito».
L’epoca del burnout
La disaffezione al lavoro, come la definisce Coin, non riguarda solo certi tipi di mestieri o di ruoli, ma è trasversale. «Anche a livello di quadri intermedi, sono molte le persone che lasciano il posto. Qualcuno l’ha definita l’epoca del burnout. Ascoltando gli psicologi, si capisce quanto loro si siano resi conto da molto tempo che il modello produttivo è insostenibile. Che le persone lascino il posto di lavoro non sorprende lo psicologo, mentre l’economista sì». Le grandi dimissioni sono un fenomeno intergenerazionale? «Negli Stati Uniti, uno studio di BlackRock (la più grande società d’investimento al mondo con 10.000 miliardi di dollari d’attivi in gestione, ndr) ha rivelato che ad aver abbandonato maggiormente il posto di lavoro sono stati gli over cinquanta».
Un dato controcorrente alla narrazione secondo cui siano le giovani generazioni a “non voler lavorare”, quando invece il fenomeno delle dimissioni risulta trasversale. «L’anno scorso è uscito in Italia il quinto rapporto Censis sul welfare aziendale, nel quale si sottolineava che la maggioranza delle persone era insoddisfatta del proprio lavoro, ma non era intenzionata a lasciarlo. Il sesto rapporto di recente pubblicazione cambia lo scenario, diventando evidente che per tanti il lavoro è solo uno strumento per avere un salario. C’è una disaffezione molto forte nei confronti del lavoro in quanto tale. La cultura del lavoro sta cambiando rapidamente rispetto a 40 anni fa, quando il lavoro rappresentava l’elemento più importante della vita. Ad esempio, l’essere sempre impegnati era considerato uno status symbol. Oggi non è più così. La verità è che il lavoro sta vivendo una crisi esistenziale. Le persone non solo hanno bisogno del tempo per vivere. Lo vogliono. Non sono più disposte a passare l’intera vita succubi del lavoro» spiega Coin, alla quale domandiamo se la pandemia abbia contribuito a modificare la percezione dell’importanza del lavoro.
«Nel libro “La fine del burnout” l’autore Jonathan Malesic sostiene che la fattibilità di sospendere la produzione per un periodo, abbia indotto le persone a riflettere sull’utilità della corsa costante al lavoro. Per molti la risposta è stata che fosse inutile. Nonostante ci sia stata una forte pressione per riaprire rapidamente, credo che la consapevolezza sia ancora ben presente nella mente delle persone».
Il fallimento di un modello
Al di là dell’effetto pandemia, secondo la sociologa, sono le condizioni materiali del modello dominante di lavoro ad essere determinanti nella presa di coscienza collettiva. L’attuale governo italiano sta modificando il reddito di cittadinanza nella convinzione che quest’ultimo induca le persone a non lavorare. Coin la pensa diversamente, ricordando che l’erogazione media del reddito di cittadinanza è di 550 euro mensili. «In Italia si dice che il reddito di cittadinanza sia un disincentivo al lavoro. Eppure, il primo, vero disincentivo al lavoro è un lavoro mal pagato. Prendiamo le commesse. Dal centro Italia verso sud, la deflazione salariale porta alla normalità offerte di lavoro da 500 a 700 euro al mese. Se poi si aggiunge una pianificazione che si modifica di settimana in settimana, di turni spezzati che iniziano alle 8 e si concludono alle otto di sera col tempo di un panino a pranzo, le persone si fanno due conti chiedendosi se ne valga la pena».
La fuga dal lavoro diventa dunque la comprensibile risposta. Una risposta individuale, non organizzata collettivamente, facciamo osservare alla studiosa. «Sì. Per certi versi è un fallimento anche del modello sindacale, della capacità di questi corpi intermediari nel rispondere collettivamente agli attacchi alle condizioni retributive e d’impiego. Va però sottolineato che negli Stati Uniti le grandi dimissioni hanno dato il via a un’ondata di scioperi impensabile per importanza da decenni nel Paese. Il vero fallimento credo sia imprenditoriale, perché non riescono più a controllare, vedi trattenere, i lavoratori».
Infatti, come spiega nel libro, il fallimento del modello produttivo non pesa solo sui dipendenti, ma si riflette anche sulle aziende. «Il modello è in crisi perché le persone lasciano il posto di lavoro e per le aziende sostituirle diventa sempre più difficile e costoso». La società al crocevia Un modello imprenditoriale oggi al bivio. O costringere le persone ad accettare le condizioni di lavoro o cambiare radicalmente l’impostazione imprenditoriale. Esiste anche una terza via, il movimento sindacale. «Siamo nella situazione di fine Ottocento. O s’impone lo sfruttamento con più durezza o si cambia radicalmente. Salvo una forte rinascita dei movimenti operai di cui l’esempio francese, inglese e americano rappresentano oggi i segnali più interessanti, ora come ora, la palla è ancora nel campo padronale. Il problema è che se invece di ascoltare le ragioni delle grandi dimissioni, si punta a misure coercitive contro di esse, si torna a una situazione di fine Ottocento. Un secolo fa, la Ford aveva un tasso di turnover del 370% in un anno. La risposta imprenditoriale fu l’introduzione di cinque giorni di lavoro a otto ore giornaliere a paghe raddoppiate. Il tasso di turnover crollò nel giro di due anni». Sul finire del libro, la sociologa segnala l’opportunità data dal porsi le giuste domande quando si affronta il tema delle Grandi Dimissioni. «Il punto non è come costringere gli occupabili a lavorare. È come consentire a tutti di autodeterminare la propria esistenza e di renderla appagante».
Francesco Bonsaver
9/4/2023 https://www.areaonline.ch


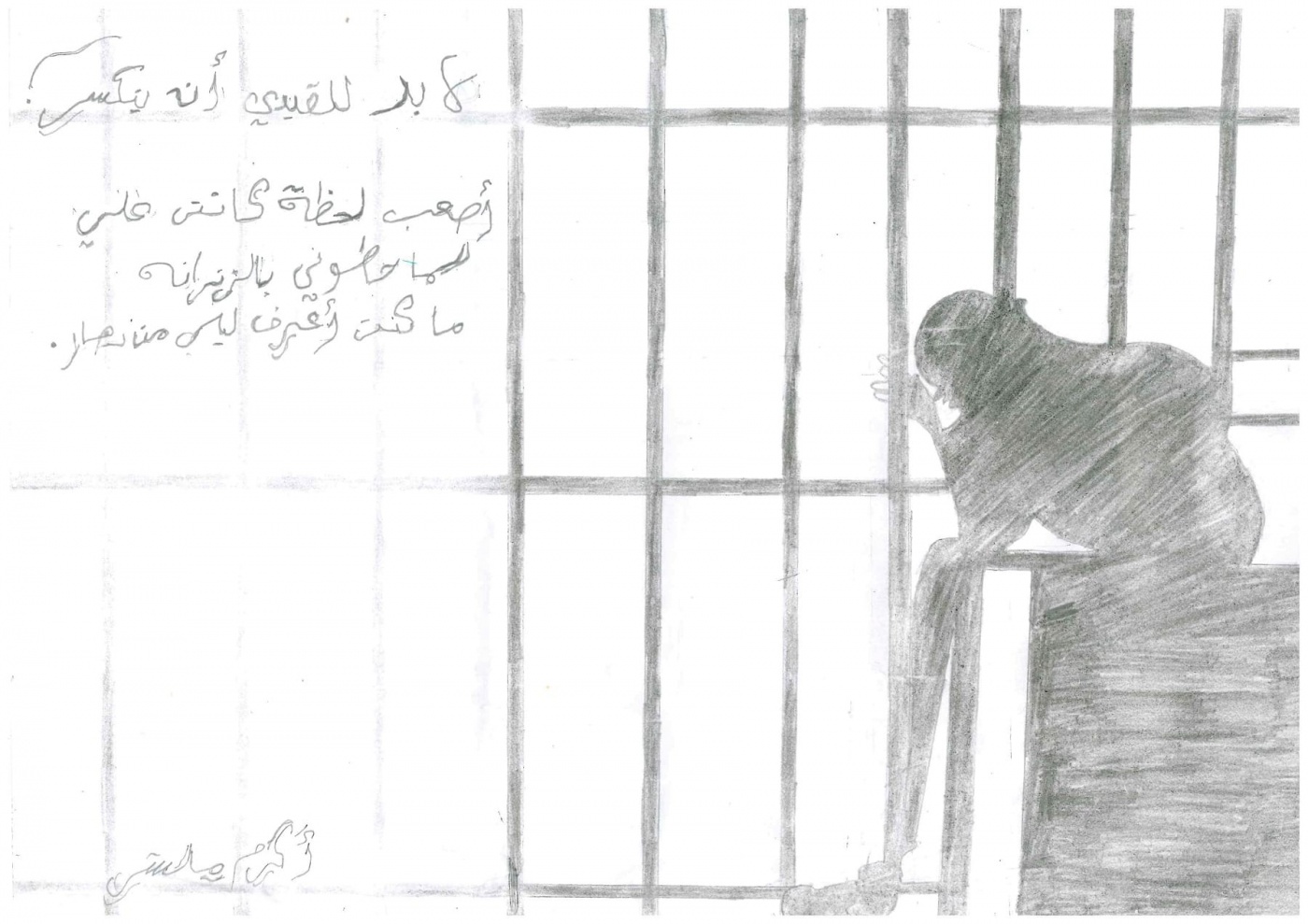







Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!