La maternità sempre più posticipata: una ‘scelta’ assai condizionata

Nella maggior parte dei paesi OCSE l’età delle donne alla nascita del primo figlio è in crescita da anni; l’Italia si pone al secondo posto in questa classifica (dopo la Corea), risultando comunque ‘leader’ tra i paesi Europei (Fig. 1). Nel 2016 l’età media delle primipare italiane è infatti di 31 anni. Al di là del valore medio è bene riflettere su altri aspetti relativi alla distribuzione per età delle primipare. Si rileva, ad esempio, che la percentuale delle donne che partoriscono per la prima volta sopra i quarant’anni è pari all’8.6% (ISTAT 2017, La salute riproduttiva della donna).
Figura 1. Età media alla nascita del primo figlio
Fonte: OECD Family Database
Dall’osservazione dell’andamento nel tempo della distribuzione delle donne per età al parto (Figura 2) si conferma come in Italia l’età alla nascita del figlio sia cresciuta in modo rilevante dal 1970 ad oggi e come, attualmente, le nascite siano distribuite in modo simmetrico intorno alla fascia d’età dei 30-34 anni. Questo significa che più della metà di esse viene programmata dopo i 30 anni d’età, quando cioè la probabilità di concepire un figlio comincia biologicamente a diminuire. Questa è una realtà che non tutti conoscono: come risulta dallo “Studio nazionale fertilità” (condotto dall’Istituto Superiore di Sanità negli anni 2016-2018), solo il 5% del campione studiato è consapevole della fase di mutamento biologico, mentre ben il 27% suppone che questa si verifichi intorno ai 40-44 anni. Occorre dunque capire in che misura la tendenza al rinvio della maternità rappresenti una ‘libera’ scelta o sia più o meno condizionata dai fattori esterni.
Figura 2. Profili di età al parto
Fonte: OECD Family Database
Secondo lo studio poc’anzi citato contano fattori socioeconomici quali il generalizzato prolungamento del percorso formativo, le ridotte probabilità di sbocco lavorativo dei giovani, le modalità contrattuali (spesso precarie) dell’attività lavorativa, nonché la carenza di politiche di sostegno alle famiglie con figli (tutte queste motivazioni, nel loro insieme, rappresentano il 41% di quelle richiamate dai rispondenti). Non vanno inoltre trascurate le perdite di reddito delle lavoratrici derivanti dalla nascita di un figlio.
A quest’ultimo proposito uno studio recente di Picchio et al. (2018) indaga i differenziali salariali tra lavoratrici madri e senza figli, a seconda del momento in cui si è realizzata la maternità. Ne emerge che le prime, in Italia, tendono a perdere un’importante parte dei loro redditi da lavoro con la nascita del figlio e il divario rispetto alle donne senza figli si chiude solo circa 12-15 anni dopo. La perdita viene minimizzata se la nascita ha luogo intorno ai 7-9 anni dalla fine degli studi. L’esperienza lavorativa quindi conta molto. Aspettare 8 anni, tuttavia, potrebbe essere un’opzione per le donne con limitata istruzione, mentre per quelle più istruite l’orizzonte temporale è ovviamente più ristretto, soprattutto per le donne che vogliono avere più di un figlio.
Un segnale delle crescenti difficoltà a procreare emerge dalle statistiche sulle coppie che si rivolgono in Italia ai centri di procreazione medicalmente assistita: il loro numero è cresciuto da circa 46.000 nel 2005 a quasi 72.000 nel 2015 (i dati non includono chi si rivolge all’estero a centri specializzati). Purtroppo, la disponibilità e, soprattutto, l’efficacia di questa procedura rimangono, tuttavia, limitate. Come segnala l’ISTAT, solo nel 22,7% dei casi le coppie riescono ad avere un figlio.
Occorre, poi, tenere conto delle complicazioni durante la gravidanza. Nel 2015, gli aborti spontanei risultano 137,02 per ogni 1.000 nati vivi, con un incremento rispetto al 1982 del 54%. Per di più, una donna su quattro, tra coloro che hanno avuto un figlio negli ultimi cinque anni, ha avuto almeno un disturbo grave durante il corso della gravidanza; circa il 10% di esse ha rischiato un aborto e un altro 10% un parto pretermine.
Oltre al posticipo della maternità, le difficoltà a procreare e/o a portare a termine la gravidanza provocano un aumento della percentuale delle donne che rimangono senza figli. Mentre per la generazione degli anni ‘50 le donne senza figli al termine del ciclo riproduttivo erano in Italia il 10%, il dato, secondo l’ISTAT, salirà al 20% per le donne nate negli anni ‘70. Si comincia a parlare della trappola demografica in cui si trova il paese (Mencarini e Vignoli, Genitori cercasi. L’Italia nella trappola demografica, 2018).
Nella misura in cui le donne desiderano realizzarsi sia in ambito professionale – mettendo a frutto il capitale umano accumulato in (molti) anni di studio – sia nella dimensione della maternità, sarebbe un vero e proprio spreco di risorse non mettere a frutto entrambi i potenziali, quello produttivo e quello riproduttivo. Tra l’altro, il costo (anche economico) di tale ‘spreco’ non è solo soggettivo, ma ricadrebbe sull’intera collettività (Del Boca et al., Valorizzare le donne conviene, 2012). È dunque necessario indagare sulle strategie di intervento pubblico più opportune, ideando nuovi strumenti e/o potenziando quelli finora scarsamente utilizzati. Si potrebbe, ad esempio, fare leva su incentivi fiscali, decrescenti con l’età, volti a mantenere l’occupazione e la posizione reddituale delle madri, così da alleggerire almeno in parte la motherhood penalty, più forte proprio all’inizio della carriera lavorativa. Questa misura dovrebbe essere in particolare rivolta alle donne che hanno finito gli studi da più di 7 anni (quelle cioè che difficilmente riprenderanno gli studi).
Andrebbero, inoltre, potenziate le azioni mirate a bilanciare i ruoli all’interno della famiglia, come l’introduzione di un congedo di paternità obbligatorio per gli uomini non limitato a 4 giorni previsti dalla legge attuale. I costi associati alla gestione della maternità – non intesa come strettamente limitata ai cinque mesi ripartiti nel pre e post partum – sono piuttosto elevati in quanto richiedono tempo, la risorsa più preziosa per tutti, sia in ambito familiare che in quello aziendale. In quest’ultimo, le assenze dei padri risultano assai inferiori a quelle delle madri, che sono quindi esposte ad un maggior rischio di obsolescenza delle capacità produttive, il che complica la re-integrazione nel mondo del lavoro. In Italia, infatti, ben il 20% delle lavoratrici che affrontano una gravidanza si ritira dal mercato del lavoro entro i due anni successivi al parto. La ripartizione del tempo tra uomini e donne nella cura dei figli diventa, pertanto, uno dei problemi cruciali.
Alcuni studi recenti mettono in evidenza che il tempo trascorso con la madre sia una componente importante nello sviluppo del bambino, favorendo la formazione delle capacità cognitive e non-cognitive (Del Bono et al., “Early Maternal Time Investment and Early Child Outcomes”, The Economic Journal, 2016). Lo stesso effetto potrebbe, tuttavia, realizzarsi qualora la presenza della madre fosse più equamente alternata con quella del padre. Anzi, l’alternanza potrebbe migliorare sia l’allocazione del tempo fra genitori che lo sviluppo dei talenti nella cura dei bambini (Di Gioacchino, “Parental Care, Children’s Cognitive Abilities and Economic Growth: The Role of Fathers”,Theoretical Economics Letters, 2012). D’altra parte, rimane l’opzione di esternalizzare la cura dei figli, il che potrebbe avere effetti positivi o negativi a seconda del contesto socioeconomico. Prima di tutto, però, si dovrebbero affrontare le norme sociali esistenti, che spesso rendono difficile la realizzazione delle politiche a sostegno dell’uguaglianza di genere. Al riguardo, sarebbe opportuno un maggiore e più chiaro supporto informativo, sia per le donne che per gli uomini di tutte le età, volto a rendere più consapevole ogni cittadino/a.
In Italia si rilevano peraltro differenze che confutano la relazione, spesso avanzata, secondo la quale ad un maggior tasso di occupazione delle donne corrisponderebbe un minor tasso di fecondità: ipotesi già smentita da tempo in alcuni contesti come quello dei paesi nordici e anglosassoni (Bettio, F. and Villa, P., “A Mediterranean Perspective on the Break-Down of the Relationship between Participation and Fertility”, Cambridge Journal of Economics, 1998). Le regioni del Nord oggi vantano in media un’alta quota di lavoratrici ben integrate nel mercato del lavoro (i tassi di occupazione femminile sono superiori al 60% in Trentino, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana) e una maggiore frequenza di maternità, mentre quelle del Sud sono caratterizzate da livelli di fecondità medio bassi pur contando tassi di occupazione femminile altrettanto bassi (soltanto una donna su tre in età lavorativa effettivamente lavora). Va notato che all’interno dello stesso Mezzogiorno si osservano altre differenze: in Sardegna e Basilicata, ad esempio, le donne tendono a posticipare la nascita dei figli, mentre in Sicilia e Campania si riscontra l’età più bassa delle giovani madri (Fig.3).
Figura 3. Differenze regionali nei tassi di fecondità e età delle madri al parto
Fonte: nostra elaborazione sui dati ISTAT 2016
La realtà sta cambiando notevolmente in Italia rispetto alla situazione di circa mezzo secolo fa, quando ancora prevaleva il modello della donna madre e casalinga. Non è quindi pensabile che l’attuale crisi demografica possa risolversi ricacciando le donne nelle mura domestiche o magari riducendo la loro propensione allo studio (ormai le ragazze rappresentano il 60% dei laureati). Occorre, piuttosto, potenziare le politiche di conciliazione tra lavoro di cura per i figli e lavoro per la produzione di beni e servizi; in tal modo la scelta dei tempi di maternità potrà veramente dirsi tale: libera, cioè, e non condizionata da vincoli dettati dal mercato del lavoro, che potrebbero condurre ad una perdita sia del PIL potenziale, che dell’altrettanto rilevante consenso sociale.
Alina Verashchagina
19/11/2018 www.eticaeconomia.it

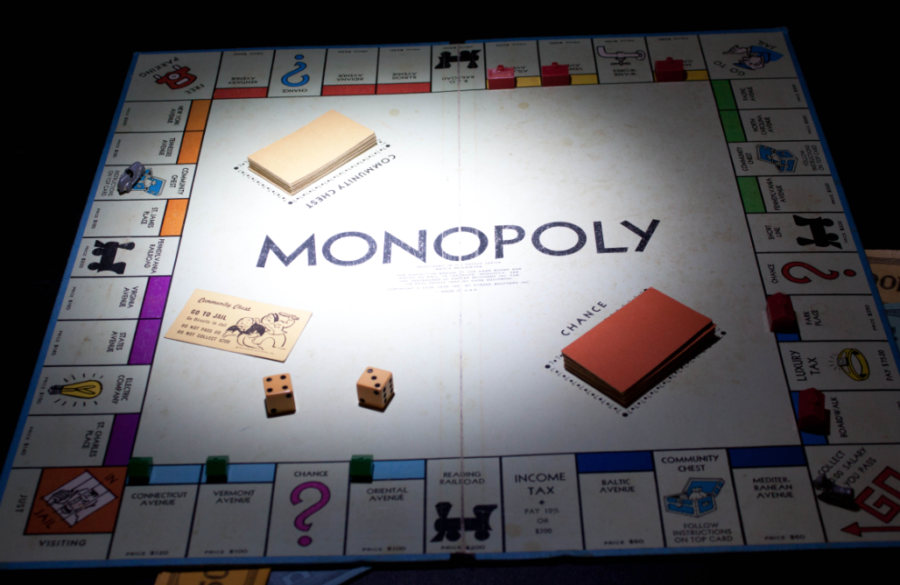











Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!