La repubblica di Confindustria

Quante volte abbiamo sentito l’espressione «Parti Sociali»? La frase «il governo convoca le parti sociali» rimanda immediatamente alla concertazione, a un tavolo in cui i portavoce di interessi di parte – in teoria contrapposti – discutono, con la mediazione di una parte terza, in teoria rappresentante di un interesse collettivo.
In teoria. Perché questo impianto teorico da molto tempo sembra essere venuto meno, in modo paradossale: la parte che dovrebbe rappresentare milioni di lavoratori e lavoratrici – i sindacati – viene sempre più rappresentata come portavoce di interessi particolari se non corporativi, lo abbiamo visto con chiarezza nel recente sciopero generale; la sua antagonista, Confindustria, portavoce di qualche migliaio di imprenditori, viene invece rappresentata come portatrice di un interesse generale, perché «se le imprese stanno bene, fa bene a tutto il paese».
Questo paradosso è stato lampante nella pandemia: prima si è tradotto nel primato dell’economia sulla salute, fino al caso criminogeno delle fabbriche della Val Seriana, poi si è arrivati all’affidamento a quegli stessi imprenditori della tutela della salute pubblica attraverso la gestione del green pass per accedere al lavoro, e questo a prescindere dall’opinione che si possa avere sulla validità o meno dello strumento.
È un serio problema di egemonia culturale, più o meno imposta, grazie alla quale è stata resa accettabile la «teoria della goccia», quell’idea di sviluppo economico per cui favorire i ceti più abbienti avrà una ricaduta positiva su chi sta sotto nella piramide sociale. Che si traduce in decine di miliardi erogati ogni anno alle imprese, con ricadute di investimenti e occupazioni limitatissime, e ricadute salariali e sulla stabilità del lavoro pressoché nulle.
Per rendere accettabile tutto ciò, serve appunto la rappresentazione di Confindustria come portatrice di un bene pubblico. Quando è iniziato questo scivolamento? Come ci siamo arrivati? In che modo si sono create le condizioni per vedere esponenti stessi dell’associazione degli imprenditori in ruoli chiave di Governo?
La base per trovare delle risposte è l’ottimo saggio del giovane storico Elio Catania, che si è occupato di strategia della tensione con l’Associazione Lapsus e in collaborazione con Aldo Giannuli ha pubblicato con Mimesis Edizioni, Confindustria nella Repubblica (1946-1975). Il libro racconta come nel dopoguerra, nel complesso periodo della ricostruzione, si siano evoluti i rapporti tra l’associazione degli industriali e la politica, e quale ruolo gli industriali italiani abbiano giocato non solo nella cosiddetta strategia della tensione, ma – come scrive Aldo Giannuli nella prefazione – «per ostacolare l’accesso delle masse nel sistema di potere del paese», fino a farsi spesso e volentieri essi stessi potere, e come dicevamo rappresentanti del bene collettivo.
Il primo aspetto interessante del libro sta nel metodo stesso di ricerca storica: il necessario ricorso alle fonti giudiziarie per conoscere la storia della principale associazione imprenditoriale italiana, causa carenza di documentazione nei tradizionali archivi storiografici, è già sostanza. Come dire, mette contenuto a uno slogan che un tempo era piuttosto frequente nelle commemorazioni delle stragi di Stato: «le bombe nelle piazze – le bombe sui vagoni – le mettono i fascisti – le pagano i padroni». Accanto a questo, Elio Catania racconta come sono cambiati i rapporti con il mondo politico, da parte di un’associazione che non si è mai fatta troppi problemi nel cercare alleanze a destra come a sinistra pur di tutelare i propri interessi, per influenzare non soltanto la politica economica ma anche la politica estera, ma soprattutto pur di scongiurare la paura del conflitto sociale che porterà gli industriali «a rasentare lo sbocco eversivo».
Perché è utile conoscere quel periodo storico per comprendere le dinamiche della Confindustria di oggi, lo abbiamo chiesto direttamente a Elio Catania.
La storia di Confindustria nel primo trentennio repubblicano si inserisce in quella più generale – e mai scritta in modo completo – delle classi dirigenti e del sistema di potere del paese dopo il fascismo. Si intreccia con il modello di modernizzazione e sviluppo adottato dalla Ricostruzione e che, pur nelle trasformazioni subite con il «miracolo economico», i conflitti sociali degli anni Sessanta e Settanta e la crisi scoppiata nel ’73, ha mantenuto saldi alcuni suoi pilastri: compressione salariale e dei diritti sociali; interventi straordinari (il cui simbolo è la Cassa del Mezzogiorno) sostitutivi di un welfare integrale, affidati a singoli enti pubblici e para-statali; politica dei redditi invece che redistribuzione, sostenendo la formazione di un mercato del venditore invece che del compratore. Come lo ha definito Fabrizio Barca: «un compromesso senza riforme». Anche se compromesso fu fino a un certo punto: Confindustria in particolare difese con tutti i mezzi possibili un modello che dal suo punto di vista tutelava i propri interessi – e quelli generali della nazione. Confindustria lo fece attraverso azioni di lobbismo e finanziamenti politici, ma anche sviluppando relazioni pericolose con l’estrema destra e la frangia più oltranzista dell’anticomunismo italiano e atlantico; proprio a questo si associò in particolare dalla metà degli anni Sessanta, quando la Nato adottò la dottrina detta della guerra rivoluzionaria, cui in maniera opportunista o ideologica parteciparono civili, militari, uomini dello stato. Confindustria, pur nella sua diversità interna (che portò spesso a veri e propri scontri tra le sue componenti e le grandi dinastie industriali), mise a disposizione risorse e apparati, per sostenere quel blocco che poi avrebbe manifestato appieno i suoi propositi nel quinquennio nero della strategia della tensione (1969-74). Il modus operandi di Confindustria in alcune fasi portò a dei successi (nel dopoguerra e nella battaglia contro il centrosinistra), a volte a delle sconfitte (la lotta feroce contro le Partecipazioni statali o la nazionalizzazione dell’energia elettrica); altre volte a dei compromessi: è il caso appunto dello scontro sociale che si conclude a metà anni Settanta, quando sotto la presidenza di Gianni Agnelli (e la vice-presidenza di Eugenio Cefis, all’epoca presidente di Montedison) avvenne non solo la pacificazione con il capitale pubblico ma anche con il movimento sindacale confederale, rappresentato dall’accordo sul punto unico di contingenza della «scala mobile», che avrebbe dato il via alla stagione detta «neocorporativa» del sindacato aprendo di fatto la strada alla accumulazione flessibile (fatta di diffusa precarietà lavorativa, disoccupazione industriale e delocalizzazioni) degli anni Ottanta.
Si può leggere la strategia di oggi come una sorta di continuità con altri mezzi del modo di operare del padronato? L’inesorabile presa di fette sempre più ampie di potere di influenza sulla politica, i costanti finanziamenti pubblici sotto forma di sgravi, sconti, incentivi, un mercato del lavoro la cui precarizzazione procede spedita a passi rapidissimi sembra non bastare. Confindustria sembra volere tutto e di più, sempre nel nome, ci mancherebbe altro, dell’«interesse pubblico» e del «bene comune».
È molto interessante leggere in questa chiave il dibattito attorno alla legge sulle delocalizzazioni. Nata come legge «contro» la possibilità per imprese che abbiano usufruito di fondi pubblici di trasferirsi all’estero, di fatto è arrivata come legge che chiarisce le procedure attraverso cui le suddette imprese possono farlo. L’attacco dell’attuale presidente degli industriali Carlo Bonomi, recepito in toto dalla politica, si è tradotto in tre concetti: non si deve ostacolare il libero mercato, non si devono scoraggiare le imprese straniere a investire in Italia, bisogna respingere una cultura «punitiva verso le imprese»; concetto quest’ultimo, già usato per contestare l’ipotesi di aumentare gli Ispettori del Lavoro, per controllare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
Con un ulteriore apparente paradosso: la posizione del capo degli industriali italiani sembra più orientata a difendere l’azione di fondi esteri che portano via il lavoro dall’Italia, indebolendone il tessuto industriale. Insomma, una Confindustria più garante dei fondi di investimento che non di chi fa impresa. Un paradosso che si spiega con un altro: l’attuale capo degli industriali italiani non è un industriale. O almeno non sembra. L’ex giornalista del Sole24 Ore Fabio Pavesi, raccontava così l’ascesa di Bonomi a presidente di Confindustria, in un articolo che vale la pena citare:
Bonomi più che un imprenditore appare un raffinato esponente del private equity. Più finanziere che industriale. La sua azienda, la Synopo srl, è sua solo in minima parte. Per arrivare a Synopo occorre risalire una lunga catena societaria, fatta per lo più di scatole vuote fino ad arrivare alla sua creatura originaria. Si chiama Ocean srl capitale sociale 93mila euro, di cui Bonomi direttamente possiede il 33%. Con un versamento di capitale sociale di soli 31mila euro. Poco più del valore di un box in una qualunque città italiana. Da Ocean di cui Bonomi possiede un terzo si scende a Marsupium srl, di cui Ocean possiede il 40%. E finalmente da Marsupium si giunge a Synopo posseduta solo con il 34%. Il resto è in mano a Caravaggio tre srl, un fondo. Così alla fine il presidente di Assolombarda fa l’imprenditore con solo il 4,5% di Synopo. Poca cosa che gli consente di mettere pochissimo capitale di rischio proprio. […] il vero business industriale però non è neanche in Synopo. Occorre scendere a valle nella Sidam, azienda controllata al 90% da Synopo che opera nel biomedicale. Di stanza nel cuore del distretto del biomedicale a Mirandola, Sidam non spicca certo per dimensioni. Il bilancio 2018 di Sidam Srl conta ricavi per solo 13,8 milioni di euro con un utile netto di 2 milioni. Profittevole certo ma piccola piccola con i suoi 70 dipendenti. Sidam nel 2017 si è comprata il 75% di Btc, sempre biomedicale, ma anche qui il fatturato è da piccola impresa. A conti fatti in questo ginepraio di scatole una sull’altra, Bonomi fa l’imprenditore avendo in portafoglio poco meno del 4% di una società, la Sidam, che fattura poco più di 10 milioni di euro. Certo Bonomi gode di stima e consenso. È ritenuto uomo capace e risoluto e in Assolombarda, dicono tutti, ha ben operato.
Insomma sembra tramontata l’epoca dei grandi imprenditori che, pur con tutte le ambiguità e derive, mettevano al centro «il truciolo», come si dice tra gli industriali del bresciano, il prodotto. Bonomi rappresenta perfettamente il nuovo corso di una parte del mondo imprenditoriale che dall’industria sposta i propri affari verso la finanza.
Una parte, perché anche nel mondo confindustriale non sono mancate le prese di posizione più o meno pubbliche, più o meno sfumate, sulla strategia di Bonomi. È successo ad esempio in occasione di alcuni rinnovi contrattuali di settore, nell’ottobre 2020 quando alimentaristi, vetro, gommaplastica, Federlegno hanno pubblicamente sconfessato la linea di Bonomi – «no ad aumenti salariali» – firmando nuovi contratti con i sindacati «nonostante la manifesta volontà di qualcuno di far saltare il tavolo per motivi estranei al settore e alle sue dinamiche», disse all’Ansa Gianfranco Bellin, capo delegazione di Federlegno, dopo un’ondata di lettere di richiamo e denunce ai probiviri dell’associazione contro gli imprenditori «dissidenti». O proprio sul tema della sicurezza sul lavoro, dove l’ex presidente di Confindustria Emilia Romagna Alberto Vacchi ha chiesto più controlli e più severità, contraddicendo pubblicamente la linea di Bonomi. In una recente intervista a Radio Popolare, Elio Catania spiega così questo ulteriore passaggio:
Il ruolo del presidente di Confindustria è cambiato: non tutela più le imprese italiane nel complesso, ma si pone come mediatore tra i nuovi padroni della finanza internazionale, che di fatto gestiscono, e spesso possiedono le produzioni materiali, l’impresa e il tessuto produttivo locale. Bonomi e Confindustria sanno che oggi è un momento politico favorevole e c’è un governo che non andrà contro le loro rivendicazioni perché di base ne condivide la cultura politica ed economica. Ma Confindustria storicamente percepisce di avere una sorta di conto in sospeso con lo stato centrale, gli industriali italiani soffrono da sempre di una sorta di sindrome da accerchiamento da parte del potere politico, anche nei momenti in cui il capitale privato è stato tutelato e favorito, anche in previsione di momenti politici meno favorevoli.
Insomma un interesse particolare, ormai parzialmente rappresentativo anche dello stesso mondo industriale, che riesce però a vendersi come collante della collettività, attraverso la propaganda, e lo sdoganamento quasi unanime da parte del mondo politico. Riuscire a rovesciare questa visione, anche sul piano culturale e comunicativo, è un punto di partenza ineludibile, per contrastare i suoi obbiettivi.
Massimo Alberti giornalista e conduttore radiofonico prima a Radio Onda d’Urto, ora a Radio Popolare. Si occupa principalmente di economia e lavoro.
24/12/2021 https://jacobinitalia.it


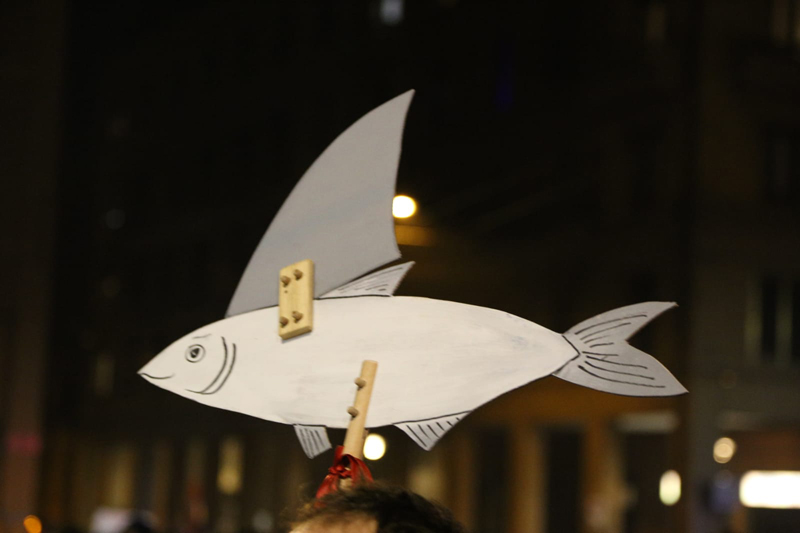




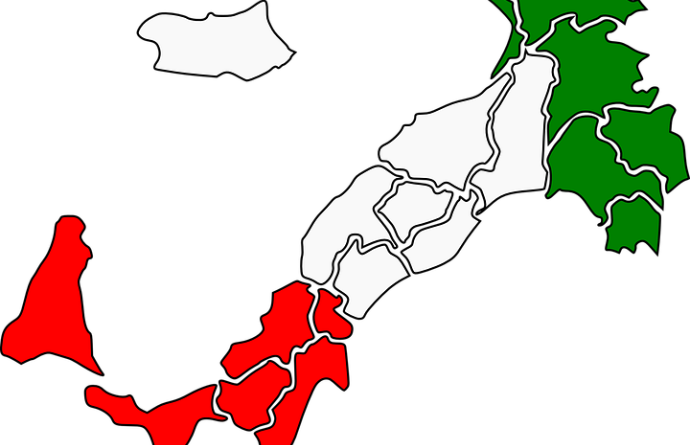


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!