La tratta atlantica: lo schiavismo in età moderna

Le isole dello zucchero
Con il problema della scarsità della manodopera i conquistatori dell’America si trovarono a fare i conti molto presto. Nei primi anni le braccia da lavoro non mancavano. Gli indiani facevano parte del bottino e Cristoforo Colombo aveva provato a venderne qualche centinaio in Spagna. Senza successo. Del resto, con la conquista del Messico e del Perù e l’avvio della rapina delle risorse del continente, le stive delle navi venivano caricate di merci più preziose. Gli indiani potevano essere utilizzati sul posto, anche se faticavano ad adattarsi allo sfruttamento spietato imposto dagli spagnoli. Di fatto divennero schiavi, anche se si negava che lo fossero. Poi cominciò il crollo demografico provocato dalle violenze dei conquistadores e dalle malattie introdotte dagli europei e il sistema del lavoro forzato si inceppò. Il problema poteva essere risolto importando schiavi africani. Si trattava di ampliare un esperimento che era in corso dalla metà del Quattrocento, con ottimi risultati.
Tutto era cominciato nelle isole al largo delle coste marocchine, prime colonie dell’Europa moderna, avamposti dell’espansione che avrebbe coperto il pianeta di imperi sconfinati. Nella disabitata Madera, occupata nel 1419, i coloni portoghesi avevano introdotto con successo la coltivazione della canna da zucchero, un prodotto prezioso, venduto in Europa a caro prezzo. L’esperienza era stata imitata dagli spagnoli quando, nel corso del secolo, avevano conquistato le Canarie, liquidando con la violenza la resistenza della popolazione indigena. Ma la produzione dello zucchero – tra preparazione dei terreni, coltivazione, taglio, trasporto e macinazione della canna – richiedeva grandi quantità di manodopera e l’Europa, che ancora non si era ripresa dalla grave crisi demografica in cui era stata precipitata dalle epidemie e dalle carestie, non poteva garantirle. I coloni avevano provveduto importando uomini dall’Africa.
Non si era trattato di reinventare una figura giuridica e sociale dimenticata. La schiavitù, sopravvissuta alla fine del mondo antico, non era mai scomparsa. Negli anni quaranta del Quattrocento, quando i portoghesi avevano cominciato a razziare uomini sulle coste africane, poi a comprarli, gli schiavi erano una delle voci del traffico commerciale (anche italiano). Slavi e musulmani in Europa, cristiani e africani nel mondo islamico, erano una merce come un’altra, trattata su mercati specializzati. Tuttavia non avevano più un ruolo centrale nell’organizzazione produttiva. Sostituita dalla servitù della gleba, divenuta marginale nella vita economica, la schiavitù era un fenomeno non trascurabile, ma circoscritto ad ambiti secondari, come il lavoro domestico. Con un’eccezione importante, costituita dagli insediamenti coloniali italiani nel Levante: in quelle piantagioni, in quegli stabilimenti e in quelle miniere era utilizzata ampiamente. La canna da zucchero a Madera e nelle Canarie aveva stimolato la ripresa di quella esperienza.
Il fatto nuovo era costituito dal quadro in cui si inseriva il vecchio modello dello schiavismo: non si trattava dell’ultimo guizzo dell’economia coloniale medioevale, priva di prospettive di espansione, ma del primo passo della nuova economia coloniale atlantica, un settore destinato a sviluppi impressionanti e a un ruolo decisivo nella crescita della società emersa dalla crisi del Trecento. Fu questo contesto a creare le condizioni perché la schiavitù uscisse dalla sua marginalità, per tornare nel cuore dei meccanismi produttivi. L’economia della schiavitù – e l’efficiente organizzazione che doveva permetterne il funzionamento – si rivelò dunque quello che era: non un aspetto della feroce avidità di un pugno di avventurieri, ma il vero volto dell’economia delle piantagioni.
Un triangolo sull’Atlantico
All’inizio del Cinquecento gli schiavi neri erano già nelle isole americane, soprattutto a Hispaniola (Haiti), dove la popolazione indigena stava scomparendo. Si trattava di piccoli quantitativi, spediti non direttamente dall’Africa ma dalla Spagna. Poi gli arrivi divennero consistenti. Nel 1518 sbarcò nelle Indie Occidentali il primo carico della tratta organizzata. Era scattato l’asiento de negros, la licenza esclusiva di trasporto e vendita, con cui la corona regolamentava il traffico degli schiavi diretto alle colonie, attribuendone il monopolio – in cambio di una tassa su ogni africano sbarcato – e mettendo fuori legge chi praticava quel commercio senza autorizzazione.
Di fatto la tratta finì subito nelle mani dei portoghesi, che avevano avviato un regolare traffico di uomini dall’Africa dal 1448 e che nei decenni successivi avevano consolidato il loro controllo sul litorale atlantico del continente, lungo il quale le loro navi stavano scendendo, alla ricerca della rotta per l’Asia. Una delle prime basi della tratta era stata l’isola di Arguin, a nord del Senegal: sarebbe diventata un centro di raccolta capace di garantire carichi di mille schiavi all’anno. Nel 1481 i portoghesi avevano messo piede sul continente, ottenendo da un re della Costa d’Oro (Ghana) l’autorizzazione a costruire un forte su una penisola che avevano chiamato Elmina.
Il contingente di importazione nelle colonie spagnole, fissato dall’asiento, venne progressivamente elevato. La coltivazione della canna da zucchero si stava estendendo nelle Antille e gli effetti della crisi demografica americana rendevano necessario accelerare la sostituzione della manodopera indigena. Intorno alla metà del Cinquecento gli schiavi sbarcavano nell’America spagnola al ritmo di duemila all’anno. Poi toccò alle regioni colonizzate del Brasile, dove pure era arrivata la canna da zucchero, seguita dalle coltivazioni di caffè e cacao, e dove sarebbe stata avviata un’intensa attività mineraria. E qui il rifornimento era un affare tutto dei portoghesi, che stavano completando la catena degli scali sulla costa africana e dunque controllavano le rotte per le loro colonie brasiliane. Prima della fine del Cinquecento almeno duecentomila schiavi avevano raggiunto l’America.
Il monopolio di Lisbona sulla tratta e sul commercio africano non era però destinato a durare a lungo. Venne scosso già nel Cinquecento dalle imprese dei negrieri clandestini, dei pirati e dei contrabbandieri, poi fu definitivamente spezzato. Gli schiavi nelle piantagioni mettevano al mondo pochi figli. Dunque bisognava procedere a rifornimenti regolari, per rinnovare la popolazione nera. E intanto le coltivazioni continuavano a estendersi e la domanda di schiavi cresceva. La tratta era ormai un affare colossale e il Portogallo, con le sue deboli strutture economiche, politiche e militari, non era in grado di gestirlo.
Il colpo decisivo venne quando, nel Seicento, Inghilterra, Olanda e Francia insediarono proprie colonie nelle isole americane. Erano nazioni in ascesa, che disponevano di solide strutture economiche e commerciali e di flotte potenti. Non avevano bisogno di intermediari. E furono i navigatori inglesi a impostare il traffico negriero secondo un modello triangolare, che garantiva i massimi profitti: esportazione in Africa di acquavite, tabacco, armi da fuoco e merci varie (utensili, lame, barre di ferro e di ottone, pezze di tessuto, vetri colorati, specchi), carico di schiavi per le colonie, scambio in America con i prodotti pregiati delle piantagioni, destinati all’Europa. Insomma le navi viaggiavano sempre a stive piene: ogni lato del triangolo disegnato tra i tre continenti dava profitti elevati. Il commercio triangolare divenne la regola. Più tardi, con la specializzazione dei traffici, si sarebbe smembrato in rami autonomi: vascelli negrieri dall’Europa all’Africa e all’America, flotte mercantili per l’esportazione nelle colonie delle merci europee e l’importazione dei prodotti coloniali.
Pezze d’India
Nella prima metà del Seicento furono sbarcati in America più di cinquecentomila schiavi. Alle rotte verso le Antille, l’America spagnola e il Brasile si aggiunse una direttrice settentrionale, verso le colonie nordamericane. Qui erano la coltivazione del tabacco e, più tardi, quelle del riso e del cotone, a richiedere grandi quantitativi di manodopera. L’organizzazione schiavista del lavoro si estese gradatamente nella parte meridionale dei territori colonizzati dagli inglesi. Nella seconda metà del Seicento gli schiavi erano presenti in tutte le colonie del nuovo mondo.
Mentre cresceva l’interesse inglese per la tratta, stimolato anche dai nuovi insediamenti nelle Antille e soprattutto dalla colonizzazione di Barbados, su cui venne presto introdotta la coltivazione della canna, aumentò la pressione degli olandesi, che strapparono ai portoghesi alcune importanti basi africane. Verso la fine del secolo furono però gli inglesi a imporsi nei traffici atlantici e il loro primato non fu più intaccato, nemmeno quando aumentò la presenza dei francesi, anche loro spinti dalle piantagioni americane: erano entrati nelle Antille nella prima metà del secolo e più recentemente avevano consolidato l’insediamento di Saint-Domingue, nella parte occidentale di Hispaniola. Attestati alle foci del Senegal, i francesi presero il controllo di quel tratto della costa africana, occupando anche le isole di Gorée e di Arguin i due più importanti centri di appoggio dei negrieri sul litorale nordoccidentale. E poi c’erano i contrabbandieri, che continuavano a trafficare con l’Africa al di fuori di ogni controllo.
La tratta si riforniva lungo le coste, dal Senegal al golfo di Guinea e all’Angola. Al centro del sistema c’erano il Niger e il tratto del litorale che prese il nome di «Costa degli Schiavi». Qualche contingente di neri arrivava anche dalla costa orientale del continente, dove convergevano i flussi della tratta araba, diretta verso il medio oriente, un traffico che investiva tutta l’immensa area compresa tra il Mediterraneo e l’Oceano Indiano e che spostava il suo raggio d’azione in un sud sempre più profondo.
Le navi si appoggiavano agli scali, dove risiedevano gli agenti delle compagnie europee. Le razzie della prima fase, pericolose e poco produttive, avevano lasciato il posto a sistemi più efficienti. I negrieri non si avventuravano al di là delle isole e della fascia costiera. La caccia all’uomo veniva delegata ai mediatori indigeni. Con i regni che controllavano le regioni affacciate sull’Atlantico erano stati stabiliti regolari rapporti di scambio: mercanzie varie contro uomini, oro e avorio. Altrove gli europei facevano leva sulle tradizionali ostilità tribali, si intromettevano nei conflitti tra i villaggi, magari li provocavano o li riaccendevano, offrivano fucili e chiedevano in cambio il bottino di prigionieri.
Con l’estendersi della tratta le comunità della costa vennero a trovarsi in uno stato di guerra permanente con quelle dell’interno e il risultato fu uno sconvolgimento civile e sociale. La tratta divenne la principale risorsa di regni, tribù e villaggi. La corruzione, il disordine e il terrore dilagarono. Stati e istituzioni, organizzazioni sociali, sistemi economici e culture complesse scivolarono verso il caos. Degradarono le città della costa, che spesso erano state fiorenti e più popolose di molte capitali europee. Vennero abbandonate e dimenticate tecniche e pratiche agricole. Nell’area vastissima e fertile compresa tra il Sahara, il golfo di Guinea e la foresta equatoriale, una delle più densamente abitate del mondo alla fine del Quattrocento, la popolazione cominciò a diminuire.
Ai centri di raccolta gli schiavi venivano portati come capi di bestiame. Scendevano verso il mare con lunghe marce, o seguendo il corso dei fiumi, stipati a bordo di piroghe. Gli uomini aggiogati a travi, le donne legate con cinghie, con i bambini appesi al collo. Ogni tentativo di fuga e ogni rallentamento della marcia venivano puniti duramente, anche con la morte. Chi non ce la faceva veniva abbandonato.
Sulla costa, ammassati in recinti, gli schiavi venivano offerti ai mercanti. Le contrattazioni erano laboriose. Bisognava di volta in volta trovare un accordo sul rapporto di scambio tra il valore dei capi offerti e quello delle merci portate dall’Europa. Spesso l’unità di misura era la «pezza» di stoffa: tanti fucili, tanti metri di tela, tanti galloni di acquavite, tante collane di vetro equivalevano a una «pezza», tante «pezze» a uno schiavo. E gli schiavi, nel gergo dei negrieri come nel linguaggio dell’asiento, erano niente altro che piezas de India, «pezze d’India», cioè le pezze di cotone indiano con cui venivano barattati.
Raggiunto l’accordo, il medico di bordo della nave procedeva a un esame, scartando vecchi, malati e invalidi. Gli schiavi selezionati venivano marchiati con il contrassegno della compagnia. Poi l’attesa dell’imbarco. Drammatica, anche se i negrieri cercavano di abbreviarla: gli utili dipendevano in gran parte dalla rapidità con la quale riuscivano a completare il carico e a fare vela per l’America, perché le precarie condizioni in cui gli schiavi venivano tenuti provocavano una mortalità elevata.
Saliti a bordo, incatenati a coppie, gli uomini venivano fatti scendere nelle stive. Là sotto, ammassati in un unico locale, o distribuiti su soppalchi, se la nave era grande, dovevano conquistare il loro pezzo di tavolato. Non potevano sdraiarsi, né alzarsi. Dovevano restare seduti, immobili, schiacciati da soffitti alti poche decine di centimetri. Le donne e i bambini, sistemati in reparti separati, disponevano di spazi ancora più angusti, ma generalmente venivano rinchiusi soltanto di notte. L’igiene era inesistente, l’aria irrespirabile. Si diceva che il lezzo delle navi negriere si avvertisse a cinque miglia di distanza. Di giorno, quando le condizioni del mare lo permettevano, gli schiavi venivano fatti uscire sul ponte e costretti a sgranchirsi danzando, mentre si pulivano sommariamente i locali chiusi.
Nel buio di quelle stive orrende il sentimento più diffuso era la voglia di farla finita. Il viaggio era interminabile, il destino ignoto, i giorni segnati da disperazione, terrore, catene, sporcizia, malattie, alimentazione forzata e frustate. L’unica speranza era una morte rapida, magari il suicidio. E la morte accompagnava tutta la traversata. L’asiento concesso nel 1592, prevedeva il 25 per cento di perdite. Una quota ritenuta accettabile anche un secolo dopo. Branchi di squali seguivano la scia delle navi, in attesa dei cadaveri gettati fuori bordo.
Quando la nave giungeva a destinazione gli schiavi in condizioni precarie venivano inviati in campi speciali, per recuperare le forze e riacquistare il loro valore commerciale. Gli altri venivano messi subito in vendita. Spesso i mercanti compravano all’ingrosso, per rivendere al dettaglio nelle città dell’interno.
Poi le piantagioni e una nuova selezione: il 20-30 per cento degli schiavi non sopravviveva oltre i primi tre-quattro anni. Il lavoro cominciava all’alba, veniva sospeso brevemente un paio di volte per mangiare e proseguiva fino al buio. La notte in capanne, con il pavimento in terra battuta. Per letto un giaciglio di paglia. L’aria solo dalla porta. Promiscuità e sporcizia. Le condizioni non erano ovunque le stesse, ma in generale si trattava di una vita fatta di fatica, denutrizione, soprusi, abusi sessuali, umiliazioni, punizioni severe e torture, fino alle amputazioni e alla morte. E ferri ai piedi e alle mani, blocchi di legno da trascinare, per impedire i tentativi di fuga, museruole di lamiera per evitare che venissero mangiati i prodotti dei campi. Lo schiavo era soltanto un’unità di lavoro. Tutti i mezzi erano leciti per piegarlo, se osava alzare la testa.
Il movimento antischiavista
Nel Seicento i negrieri avevano portato in America più di un milione e mezzo di schiavi. Trecentocinquantamila erano morti durante il viaggio. Nel Settecento, soprattutto dalla metà del secolo, la tratta toccò cifre impressionanti. In Europa il consumo di zucchero si stava diffondendo anche tra le classi popolari: la domanda sollecitava l’aumento della produzione e quindi del volume della tratta. Uno stimolo ulteriore veniva dalla richiesta crescente delle colonie nordamericane. In quelle regioni, intorno al 1775, gli schiavi erano già mezzo milione. Nel corso del secolo furono sbarcati cinque milioni e seicentomila africani. Un milione i morti durante la traversata.
Ormai tutte le nazioni europee che avevano insediamenti coloniali in America disponevano di basi africane e di flotte negriere. Nel golfo di Guinea trafficavano anche danesi e prussiani. La tratta, in una prima fase controllata da compagnie statali, era largamente liberalizzata. Sembra che tra il 1783 e il 1793 le centocinquanta navi negriere di Liverpool abbiano imbarcato trecentomila africani e altrettanti, in tre anni, intorno al 1800.
La tratta e il commercio dei prodotti dell’organizzazione schiavistica del lavoro avevano stimolato lo sviluppo delle marine mercantili, delle banche e delle compagnie di assicurazioni, producevano ricchi profitti, fornivano nuovi mercati alle industrie. In Inghilterra, in Olanda e in Francia erano settori specializzati, gestiti da grandi compagnie. Re e duchi, principi e magistrati, banchieri e notai facevano a gara per collocare il loro denaro presso i grandi mercanti, ottenendo interessi fissi, o per acquistare partecipazioni nelle compagnie commerciali. Imitati da una folla di oscuri borghesi, che investivano i risparmi nelle società che gestivano le imprese dei negrieri e i traffici atlantici. Gli utili ricavati dalla tratta e dal commercio coloniale costituivano una voce importante della formazione dei capitali che stavano lanciando una nuova economia e una nuova società, destinata a far approdare l’Inghilterra, e poi l’Europa, all’età delle macchine e delle fabbriche. In Africa, depauperata dalla tratta atlantica e da quella araba di milioni di abitanti, per lo più giovani, tra deportati, morti nel corso delle razzie, prima dell’imbarco e durante la traversata, le civiltà tribali si erano dissolte.
In questa situazione drammatica il quadro si mise in movimento. Da un lato cominciarono a farsi frequenti le notizie di agitazioni e rivolte delle genti nere d’America e di comunità di schiavi fuggiti dalle piantagioni, avvertite come una minaccia dai coloni. Dall’altro si sentirono le prime voci di dissenso, frutto di una cultura diversa da quella che aveva approvato, o tollerato, lo schiavismo. Tra gli illuministi francesi cresceva la convinzione che fosse una macchia sulla civiltà europea.
Comunque i primi provvedimenti non furono varati in Europa, ma nel Nordamerica, nel corso della rivoluzione: strideva la contraddizione tra la condizione servile e i principi in nome dei quali era stato ingaggiato lo scontro con gli inglesi. Tuttavia il problema dell’emancipazione degli schiavi fu accantonato e l’attacco fu sferrato contro la tratta, senza farlo seguire da misure tali da impedirla realmente. Il primo provvedimento fu approvato nel 1774 dal congresso di Filadelfia, nel quadro dell’abolizione del monopolio inglese del traffico con le colonie: tra le merci boicottate furono compresi gli schiavi. Nel corso del decennio successivo alla proclamazione dell’indipendenza tutti gli Stati del nord proibirono la tratta o le imposero restrizioni. Comunque un buon numero di navi americane continuò a importare neri nelle Antille e nel sud della federazione.
La questione dell’emancipazione era più delicata. Nel nord – dove lo schiavismo serviva solo a fornire cuochi e camerieri alle famiglie benestanti – fu risolta facilmente, nell’ultimo ventennio del Settecento e nei primi anni dell’Ottocento, con provvedimenti di abolizione, o di graduale liberazione. Nel 1804 la schiavitù era scomparsa, o stava scomparendo, in tutti gli Stati settentrionali. Nel sud, invece, i piantatori non si ponevano nemmeno il problema e i liberali ritenevano l’emancipazione pericolosa perché, con un numero di schiavi tanto elevato, avrebbe scosso tutto il sistema economico e sociale.
Tra il 1787 e il 1788 il movimento antischiavista emerse contemporaneamente, e con forza, in Inghilterra e in Francia. L’offensiva abolizionista inglese era guidata da Thomas Clarkson e William Wilberforce. Il primo si impegnò in un’intensa campagna di denuncia degli orrori della tratta, e cominciò a fare presa sull’opinione pubblica. Il secondo lo affiancò con un’efficace azione parlamentare. In Francia gli antischiavisti si raccolsero nella «Società degli amici dei neri». Poi ci fu la rivoluzione. Gli abolizionisti erano ben rappresentati nella nuova classe dirigente francese, tuttavia non riuscirono a imporre tra gli impegni urgenti quello di una rapida pronuncia sulla schiavitù.
Sull’opposta sponda dell’Atlantico, l’altra leva di rivoluzionari, uscita dalla guerra di liberazione delle colonie inglesi, continuava a subire i condizionamenti degli interessi dei piantatori. La questione della schiavitù venne ignorata dalla Costituzione del 1787. La Convenzione federale decise di accantonarla per un ventennio, lasciando impregiudicata la situazione: l’economia di metà del paese strutturata sul sistema delle piantagioni, più di cinquecentomila schiavi, decine di migliaia di nuovi arrivi all’anno, garantiti da un traffico che era ripreso a pieno ritmo. Né c’erano segnali che la tendenza si invertisse spontaneamente. Nel 1793, in Georgia, Elias Whitney inventò la macchina sgranatrice. Consentiva di separare con rapidità le fibre di cotone dai semi, un’operazione che, effettuata a mano, era lenta e laboriosa. Con quella macchina il ciclo produttivo veniva notevolmente accelerato e la quantità di fiocchi che uno schiavo era in grado di lavorare diventava molto elevata. La coltivazione del cotone – materia prima essenziale della rivoluzione industriale inglese – divenne estremamente redditizia: un incentivo all’espansione delle piantagioni e all’utilizzazione massiccia del lavoro degli schiavi.
I giacobini neri
La frattura del sistema si verificò più a sud. Cominciò con una rivolta nella parte occidentale di Hispaniola, Saint-Domingue, una colonia che forniva due terzi del commercio internazionale francese, centro della produzione mondiale dello zucchero e massimo mercato degli schiavi. Da anni una serie di agitazioni faceva traballare il potere dei piantatori. Si intrecciavano la protesta dei creoli, liberi ma privi di diritti civili, e la serpeggiante furia degli schiavi neri, tenuti in condizioni di lavoro e di vita disumane.
Arrivarono le notizie della Bastiglia e dei fatti di Parigi e i creoli tentarono la spallata finale: coccarde rosse della rivoluzione sanculotta, la milizia trasformata in guardia nazionale. Una rapida repressione, qualche timida apertura e conferma della schiavitù. Nelle terre d’oltremare l’utopia della libertà, dell’uguaglianza e della fratellanza non superava la resistenza del pugno di schiavisti che controllava le colonie. E allora arrivò il momento della resa dei conti.
Nell’agosto 1791 l’insurrezione nera investì con furia le piantagioni, devastando e uccidendo. Parigi, impaurita, estese ai creoli e ai neri liberi i diritti civili e inviò un corpo di spedizione. Gli schiavi persero l’alleanza dei creoli, ma la rivolta divenne guerra di liberazione e trovò un capo: Toussaint Louverture, schiavo liberato, figlio di un capotribù africano, autodidatta. Era un autentico rivoluzionario, favorevole a una lotta determinata, contrario alle devastazioni selvagge. Era, si sarebbe detto in Europa, il capo dei «giacobini neri».
Toussaint organizzò i suoi uomini in esercito, si alleò con altri capi guerriglieri, sconfisse più volte i francesi, respinse le proposte degli spagnoli, che speravano di estendere il loro dominio dalla parte orientale a tutta l’isola. Rigettò in mare gli inglesi che, dalla Giamaica, avevano tentato l’invasione per conquistare una nuova colonia e mettere fine a un movimento che minacciava di contagiare tutto l’arcipelago.
Intanto in Francia maturava un quadro nuovo. Con la dittatura rivoluzionaria dei giacobini la questione della schiavitù, imposta dalla rivolta di Saint-Domingue, veniva finalmente affrontata. Nel 1793 la Convenzione dette un colpo alla tratta, eliminando i primi statali alle navi negriere. Era una decisione importante, anche se era stata preceduta da un atto danese del 1792, che aveva stabilito il divieto della tratta dal 1803. A Saint-Domingue il commissario francese proclamò l’abolizione immediata della schiavitù. Il 4 febbraio 1794 la Convenzione estese la decisione a tutti i possedimenti francesi.
Alla fine di quel 1794, caduto Robespierre, lo sbarco di un nuovo corpo di spedizione segnò la ripresa della lotta. Negli anni successivi si sarebbero ripetuti i tentativi francesi di riprendere il controllo della colonia. Ormai, comunque, due risultati erano stati raggiunti. Da un lato la legge giacobina che aveva abolito la schiavitù, confermata nella Costituzione francese del 1795 e ripresa dalle carte costituzionali di molte «repubbliche sorelle»: un precedente importante, insieme al decreto danese e ai provvedimenti varati nel Nordamerica, che segnava un nuovo punto di partenza per il movimento abolizionista. Dall’altro la nascita della prima repubblica nera della storia. Toussaint non avrebbe visto la sua proclamazione. Catturato e deportato in Francia, sarebbe morto in esilio, mentre i suoi compagni riprendevano a combattere, preparando le condizioni dell’indipendenza definitiva, che avrebbe dato alla nuova nazione il nome indigeno di Haiti (1804).
Dalla proibizione della tratta all’abolizione della schiavitù
Nel 1802 Napoleone revocò la soppressione della schiavitù. I neri e le piantagioni erano moneta sonante: non si poteva rinunciare ad essi in nome di principi astratti e ormai tramontati. Le violenze in corso nella colonia fornivano poi un argomento per giustificare la decisione napoleonica e in Francia c’era chi le rinfacciava agli abolizionisti: i neri erano immaturi per la libertà, la loro liberazione scatenava istinti selvaggi.
Erano le stesse obiezioni dei fautori inglesi della schiavitù. Nel 1793, quando era sembrato che il movimento abolizionista fosse a un passo dalla vittoria, era stata proprio la rivolta a Saint-Domingue a spaventare i parlamentari, nonostante gli schiavisti fossero ormai in minoranza nella società della rivoluzione industriale, che preferiva il lavoro salariato a quello servile. E poi l’abolizione giacobina aveva impresso sull’antischiavismo un segno di radicalismo rivoluzionario tutt’altro che gradito ai conservatori. In realtà, al di là delle ideologie, erano in gioco grandi interessi. Sembrava assurdo che si dovesse abolire lo schiavismo quando la tratta produceva guadagni mai raggiunti, quando la rovina delle piantagioni francesi faceva crollare l’offerta e impennare il prezzo dello zucchero, mentre i nordamericani stavano ampliando l’area della colonizzazione e delle piantagioni e si poteva prevedere un’espansione della domanda di schiavi.
Si dovette attendere qualche anno, ma il risultato fu ancora più rilevante di quello che gli abolizionisti avevano sperato, perché il movimento aveva fatto breccia anche negli Stati Uniti. Nel 1806 il Parlamento britannico approvò a schiacciante maggioranza una risoluzione che invitava il governo a prendere «misure efficaci per l’abolizione del commercio africano degli schiavi». Il 2 marzo 1807 un decreto del presidente americano Thomas Jefferson proibì la tratta dal primo gennaio 1808. Tre settimane dopo anche Londra approvò una legge che metteva al bando il traffico degli schiavi, proibendolo alle navi, ai sudditi e ai porti del regno. Poi la tratta fu dichiarata reato anche se praticata da stranieri, la costa africana fu pattugliata per impedirla e venne avviata un’intensa azione diplomatica, fatta di pressioni e trattati bilaterali, perché fosse vietata anche dalle altre nazioni. Nel giro di pochi anni l’Inghilterra si era trasformata da massima trafficante di schiavi nel paese guida di una crociata contro i negrieri.
Il risultato era importante, ma la partita decisiva era ancora da giocare. Intanto occorreva che tutti gli Stati approvassero leggi contro la tratta e prevedessero strumenti di repressione. Ma ciò non era sufficiente. Il problema centrale era costituito dal permanere in aree molto vaste delle Americhe di sistemi produttivi interamente fondati sulla schiavitù. Finché questo nodo non fosse stato sciolto il problema sarebbe rimasto aperto e la tratta, spostandosi sul terreno della clandestinità, avrebbe mantenuto ampie dimensioni.
La fine della schiavitù nei territori britannici arrivò soltanto nel 1833, con un atto – in vigore dal 1834 – che contemporaneamente avviò un processo di graduale emancipazione dei neri liberati. Un altro passo fu compiuto con la seconda abolizione della schiavitù nelle colonie francesi (1848). Ma si dovette attendere l’emancipazione dei neri degli Stati Uniti, con la vittoria nordista nella guerra di secessione (1865), e la fine dello schiavismo a Cuba e in Brasile (1886 e 1888) per interrompere il circuito tra schiavitù e economia delle piantagioni. Ed è solo alla fine del secolo che fu stroncato, a fatica, il ramo della tratta controllato dagli arabi. L’Africa era in ginocchio e ormai preda della spartizione coloniale.
Non si sa esattamente quali siano state le reali dimensioni della tratta. Non si sa quanti milioni di africani, nei quattrocento anni dello schiavismo moderno, siano stati strappati dai loro villaggi per essere portati, come bestie, al di là dell’Atlantico. Un calcolo prudente ipotizza dieci o undici. Non si sa quanti uomini siano stati uccisi durante le incursioni dei razziatori, quanti siano morti lungo le marce di trasferimento, o prima dell’imbarco, o durante la traversata. Certamente altri milioni. Fu una tragedia immane, che investì drammaticamente, in vario modo, la storia di tre continenti e lasciò segni profondi, dal sottosviluppo al razzismo.
Un punto è certo: non si trattò di un incidente di percorso nel quadro di un’evoluzione verso il progresso altrimenti tranquilla e lineare. Al contrario: tratta e schiavitù sono state, con il colonialismo, l’altra faccia dei meccanismi della crescita sociale ed economica dell’Europa.
Alessandro Piccioni









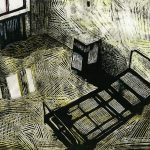
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!