La violenza di Gomorra sui minori
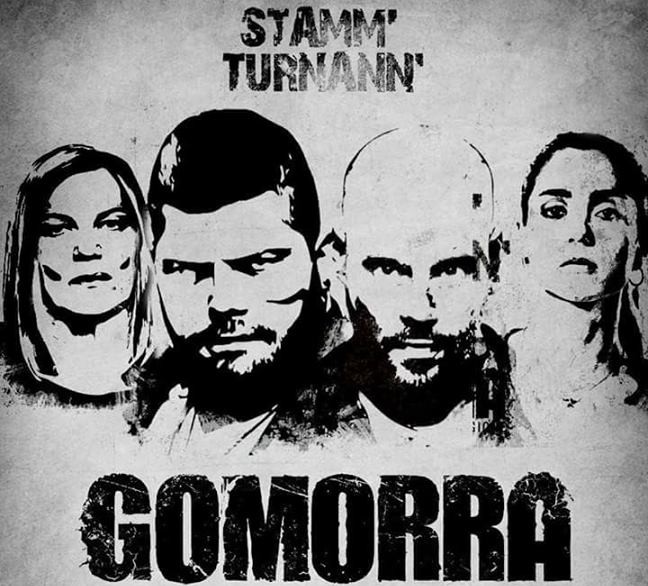
La tesi che qui voglio sostenere è che il fenomeno della serie Gomorra non è stato compreso in tutte le sue implicazioni a mio parere perverse sulla vita dei ragazzini napoletani. Questa presa di posizione non ha nulla a che fare con le polemiche che hanno accompagnato questo argomento, polemiche tutte strumentali a logiche di ordine politico, e sopratutto non intendo criticare le posizioni di Saviano a proposito della situazione napoletana, che in linea di massima condivido; non intendo sopratutto attribuire alla serie Gomorra alcuna responsabilità diretta che voglia stabilire una relazione causale tra i comportamenti violenti dei giovanissimi napoletani e popolarità della serie.Vorrei invece analizzarne il contenuto e la forma in relazione alla acclarata ed incontrollabile invasività che ogni prodotto massmediale di larga fruizione produce inevitabilmente su personalità fragili e vulnerabili. Per questa ragione ritengo colpevole avere un atteggiamento superficiale o ‘tollerante’ di fronte a fenomeni di tale rilevanza, opinione questa peraltro ampiamente condivisa dagli educatori cittadini.
La funzione positiva che il suo autore attribuisce a questa narrazione si basa sulla funzione pedagogica che avrebbe la rappresentazione del male: svelarne la realtà nascosta (i segreti della vita del camorrista, di cui l’autore è profondo conoscitore) sarebbe di per se utile perché farebbe crescere la consapevolezza collettiva della natura del fenomeno. Questa argomentazione, applicata ad un prodotto con le caratteristiche specifiche che vedremo, ha un valore molto relativo se riferita ad un pubblico adulto, e uno totalmente infondato se riferita ad un pubblico di ragazzi che non solo solo deprivati culturalmente ma anche soggetti coinvolti direttamente negli scenari in cui si sviluppa la storia.
La descrizione del male così come viene proposta nella fiction ha delle caratteristiche particolari (che la differenziano tra l’altro da tutte le altre serie simili): la narrazione rimane in maniera del tutto innaturale ostinatamente chiusa all’interno del mondo camorristico lasciando fuori deliberatamente qualsiasi altro punto di vista che metta in qualche forma in discussione quella logica (e questo nemmeno a livello di un dubbio, di una incertezza, di una riflessione privata, non soltanto di prese di posizione concrete che si oppongano o rappresentino quelli che non sono coinvolti perché hanno altri ruoli). Non solo la critica e la opposizione concreta al mondo camorristico ma anche l’introspezione sono aspetti che Saviano tiene fuori dalla narrazione.
L’immagine che ne esce è dunque assolutamente compatta nella sua negatività, né viene lasciata aperta la porta ad una sua valenza metaforica, mancando del tutto qualsiasi profondità psicologica nel racconto che potrebbe suggerire qualche valenza universale dell’animo umano. È questa compattezza che le da una capacità di suggestione molto forte che coinvolge molto lo spettatore che viene catturato dagli sviluppi della trama rendendola particolarmente avvincente; di qui il grande successo di pubblico. È assente dalla fiction anche il ruolo di testimone del narratore (che invece era presente nel film): il racconto diventa decontestualizzato, privo di agganci storici definiti (tutto si svolge in un tempo imprecisato e immutabile, dando l’impressione che quella realtà non possa subire alcuna modificazione: le Vele di Scampia diventano un luogo astratto fuori dal tempo, così come i protagonisti reali del mondo camorristico diventano solo il pretesto per la rappresentazione del male assoluto); la evoluzione del contesto si percepisce parzialmente solo se si passa da una serie all’altra, ma è evidente che questo aspetto della informazione documentaria è volutamente tralasciato.
Tutto assomiglia terribilmente a un “storia sacra del male”, dove l’unico dominatore è un dio cattivo che muove le sue pedine come degli automi al suo comando. Verrebbe da pensare che il suo autore debba sentirsi investito da una speciale missione profetica di cantore del Male in nome del Bene, (indotto forse dalla sua vita forzatamente nascosta e quindi in qualche modo immateriale, cui è costretto – non posso fare a meno di osservare come le sue apparizioni televisive siano sempre circonfuse da un’aura un po oracolare, su cui tra l’altro i conduttori giocano con la complicità del protagonista in maniera esplicita).
Una sceneggiatura così costruita può avere quindi una funzione di informazione molto parziale (già comunque svolta benissimo dal libro e dal film) che comunque non può giustificare la ripetitività della proposta che è invece perfettamente rispondente alla pura logica dell’ampliamento dell’audience.
Non si tratta qui di una critica fatta in nome della tutela dell’immagine della città e nemmeno per attribuire solo alle elites la capacità di giudizio per cui la ‘cruda realtà’ non andrebbe mostrata a tutti, ma di riconoscere che il ricorso a una narrazione così confezionata si limiti piuttosto a essere strumentale a una fruizione ‘ludica’ del prodotto, che fa appello alla soddisfazione delle pulsioni più infantili di un pubblico che cerca storie avvincenti senza davvero curarsi del merito della vicenda rappresentata. Sappiamo come i mass media siano ormai del tutto sbilanciati su questo versante (anche nel comparto più legato all’attualità dove si cerca ossessivamente l’effetto scandalistico della notizia) proprio perché è a quel lato ‘ludico’ del pubblico che ormai fanno riferimento. Quello che rende stridente la cosa in questo caso è l’argomento così legato alla nostra attualità, e in particolare all’attualità della condizione dell’infanzia nei cui confronti molte persone si stanno impegnando quotidianamente e con la sensazione che questi sforzi continuino a scontrarsi con ostacoli quasi invalicabili. È per questo che risulta così deprimente vedere come anche parte di chi si vorrebbe muovere in sintonia con il rispetto dell’infanzia ricada poi negli stereotipi di una comunicazione di massa che fa appello al lato leggero, irresponsabile, distaccato, spensierato del suo pubblico, in una parola appunto ‘ludico’: esattamente quel lato del carattere più regressivo e politicamente passivo che non ha nessuna intenzione di utilizzare quello che viene a sapere della realtà (i suoi contenuti tragici) per cercare di cambiarla sentendosene in quanto in qualche modo responsabile (se non altro per il suo silenzio). L’atteggiamento ludico quando è dominante nell’adulto è il peggior sintomo di una infanzia non risolta e della conseguente incapacità di comprendere le frustrazioni subite e le rivalse attuali sui figli ed i bambini. Una comunicazione che accetti di fare appello al lato infantile del suo pubblico non può illudersi che bastino dei contenuti ‘fedeli alla realtà’’ a far crescere la consapevolezza in chi vi assiste. Non basta dunque ‘rappresentare il male’ per far crescere una consapevolezza critica nei suoi confronti (Saviano per difendere la serie si è spinto a scrivere che sarebbe come criticare Shakespeare per aver scritto Re Lear: la cosa mi ha lasciato sgomento sopratutto per la mancanza di repliche… il povero Mc Luhan si rivolterebbe nella tomba!)
Quando guardiamo la cosa dal punto di vista del pubblico dei bambini e dei giovani napoletani vediamo invece che i suoi effetti non possono che essere considerati deleteri. Per loro vedere rappresentato il male, un male che conoscono benissimo perché lo vivono ogni giorno nella loro vita, in maniera così ripetitiva e senza alternative non può essere qualcosa che a loro serva per migliorare la loro condizione, ma diventa, nonostante le intenzioni siano opposte, una forma di legittimazione, per quanto non voluta, del male.
In un contesto come quello della gioventù napoletana più deprivata (e qui purtroppo siamo di fronte non a delle sparute minoranze ma ad un fenomeno di massa) pensare ad un possibile distacco critico è un non senso per due ragioni: primo, perché i bambini – Gomorra è popolarissima anche tra i bambini delle elementari, non dimentichiamolo – e gli adolescenti sono sempre soli davanti alla TV e non si può contare su una figura adulta che possa filtrarne i contenuti e guidarli in qualche modo alla visione; secondo, perché la potenza del mezzo televisivo di serie, massimamente se ripetuto ossessivamente per anni a cadenze settimanali e a portata di clik, ha una capacità di suggestione assolutamente imparagonabile ad altri mezzi di comunicazione e quindi non si può staccare il messaggio dal mezzo che lo veicola.
La visione della fiction non genera la violenza ma le da un’aura di ‘bellezza nera’, di fascino, che seduce inevitabilmente chi è fragile emotivamente e culturalmente, che aumenta enormemente le possibilità di identificazione; esporre ossessivamente atteggiamenti simili, anche se non genera direttamente una adesione reale, rafforza un immaginario negativo (l’influsso sui ragazzini era così palpabile che l’aver di volta in volta ambientato gli episodi in diversi quartieri della città ha avuto riscontri immediati sui bambini delle nuove zone coinvolte). Si può adottare uno ‘stile’ di successo – c’è una somiglianza impressionante tra gli atteggiamenti degli attori e quelli dei ragazzini – che si esprime in mille sfumature che diventano inevitabilmente modelli di comportamento (provate ad avvicinare un qualsiasi ragazzino napoletano dai sette anni in su e ditegli: “Chi comanda qui? “, sapete come vi risponderà? “Nuie! ” – il grido di guerra dei Savastano!).
Ma sopratutto quando la realtà rappresentata non è un ambiente estraneo e lontano ma è ‘carne viva’ di una città dove ci sono migliaia di ragazzi che possono riconoscere nei personaggi televisivi i loro parenti, amici, conoscenti, vicini di casa, e che agiscono negli stessi luoghi fisici dove loro vivono quotidianamente. Chi di noi resisterebbe all’attrazione di vedere tutte le settimane una storia ambientata sotto casa propria? Nessuno, e tantomeno i nostri ragazzi, che perònon hanno quasi nessuna possibilità di avere un distacco critico nei confronti della storia: li vedono uguali a loro, ma con una terribile aggravante: che i protagonisti della storia, a differenza dei loro parenti ed amici che provano a fare all’incirca le stesse cose, in quel modo sono diventati popolari, li vedono milioni di persone. Ergo, saranno pure delinquenti ma a quanto pare la cosa gode di una grande considerazione in questa società e quindi cosa c’è di più normale che imitarli (almeno negli atteggiamenti, nell’estetica, nello stile); se poi capita di aver voglia di fare qualche bravata allora si sentiranno anche di più nella parte.
Qualcuno potrebbe appellarsi al fatto che narrare il male in fin dei conti non ha mai fatto male a nessuno, come potrebbero dimostrare le favole che pure raccontano di atti violenti; ma ciò non ha alcun fondamento: le favole vengono assimilate utilmente dai bambini perché hanno tre elementi fondamentali che si accompagnano alla loro lettura: la carica emotiva positiva di chi le racconta loro, la possibilità di scegliere quelle che ciascuno predilige in base alla propria sensibilità personale, l’aura fantastica entro cui le vicende ed i personaggi prendono corpo. La televisione sopratutto in casi come questo è invece un mezzo che riproduce ossessivamente nell’immaginario infantile la stessa favola senza lieto fine, senza speranza e che si svolge nel loro ambiente quotidiano in maniera ripetitiva ed impersonale; come quindi non considerarla una forma di violenza?
Non c’è certamente da aspettarsi nulla di buono da un pubblico adulto che non si occupa di cosa i suoi figli guardino alla TV ma lascia quantomeno perplessi un autore che non si preoccupa di chi sia il suo pubblico quando la sua vocazione è così fortemente connotata da un impegno sociale. Come non sospettare che sia in qualche modo irretito suo malgrado da una nascosta ‘volontà di potenza’ di natura psicologica che lo rende cieco di fronte alle conseguenze che la sua scelta di ‘dire la verità’ a tutti i costi’ può avere nei confronti dei più deboli?
In città si sta arrivando inoltre ad un proliferare di casting che reclutano i ragazzini per interpretare questa serie ed altre consimili alimentando l’illusione che si possa fare ‘carriera’ diventando attori di successo. Si arriva così anche al parossismo di poter riconoscere gli attori in quanto vengono reclutati nel loro stesso ambiente, con un cortocircuito mediatico-psicologico del tutto nuovo per cui la figura del criminale virtuale coincide sia con quello reale che con il suo interprete: sono all’ordine del giorno le serate nelle discoteche in cui viene invitato l’attore della serie che viene presentato con il nome del suo personaggio (altro che “The Truman show”, qui siamo ben oltre!).
Il problema in fin dei conti è dunque questo: quanto viene presa in considerazione l’importanza e il dovere di riconoscere la fragilità dell’infanzia e con quanta superficialità viene ignorata la violenza implicita che si esercita nei loro confronti? Dobbiamo allora chiederci in nome di cosa ci arroghiamo il diritto di sottoporli a tutto questo. Può un prodotto di consumo nell’ambito dello spettacolo, in nome del principio del rifiuto della censura preventiva, della ‘libertà creativa’ degli autori, e sopratutto degli ormai enormi interessi economici che hanno operazioni di questa portata, pretendere di ignorare gli effetti che produce su una parte dei suoi fruitori (proprio quelli in nome dei quali si vorrebbe agire)? Ancora una volta è il punto di vista dell’infanzia che viene ignorato. Si tratta di far emergere come anche le operazioni di denuncia sociale possano cadere nella trappola di una visione solo adultocentrica del problema. Questa visione ha ragioni sia culturali che economiche che si basano su una prassi che non è stata mai realmente messa in discussione, e tuttavia ci dovremmo chiedere se non sia l’ora almeno di provare a mettere in campo ragioni diverse, dare un segnale di dissenso, provare a rendere visibile un punto di vista che parta da quella che sarebbe ora di riconoscere come la categoria più oppressa, anche sapendo che la forza che muove questi meccanismi è diventata incontrollabile.
Sollevare questo problema a proposito di un fenomeno tutto sommato marginale come una serie TV può sembrare superfluo o eccessivo vista la preponderanza che questa tendenza assume su mille altri aspetti della vita infantile; io credo invece che questo caso possa essere una occasione per riflettere su come questo punto di vista non sia ancora realmente compreso nella sua portata, proprio perché assistiamo puntualmente ad una sua ‘relativizzazione’ che mostra come si sia in realtà incapaci di coglierne la natura ‘sovversiva’: l’idea che l’infanzia sia una classe oppressa, priva di diritti propri (e di propri portavoce) non assimilabili a quelli degli adulti (di tutti gli adulti), si scontra continuamente con la tendenza a riportare i problemi dell’infanzia, le sue sofferenze specifiche, a quelli più generali dell’efficienza delle istituzioni (carenze di risorse, assenze di intervento, ecc) o della disparità di trattamento (discriminazioni sociali o economiche, sfruttamento dell’immagine, ecc), senza quasi mai porre al centro problema la dimensione di negazione culturale in cui l’infanzia è ancora oggetto. Per questo sollevare le implicazioni che pone dal punto di vista infantile una serie TV, ponendosi già di per se sul piano della incidenza culturale che essa ha sulla vita dei giovani, può essere utile per ripensare al problema generale in una prospettiva più ampia in cui gli aspetti più politici e sociali vengono ricondotti alla loro matrice comune della natura specifica del potere che si esercita sull’infanzia. È su questo terreno del potere (e della sua gestione impositiva saldamente in mano agli adulti) che si dovrebbe iniziare a riflettere se si vuole davvero impegnarsi per un diverso modo di affrontare le relazioni con l’infanzia e l’adolescenza.
Andrea Sola
19/12/2018 https://comune-info.net

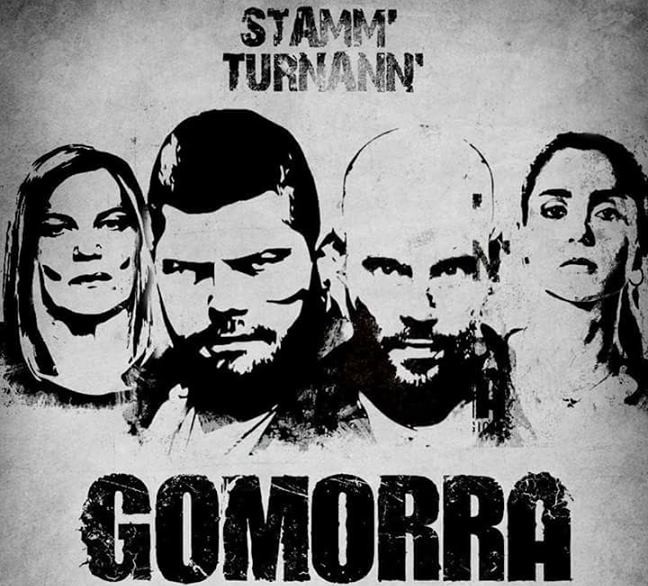








Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!