L’accoglienza in Italia tra diritti impari e un’inclusione sempre più difficile. Oltre le barriere vere e immaginarie, le storie delle persone
La classe politica ormai da tempo delega alle Prefetture la gestione di un fenomeno strutturale.
Jalad è entrato nell’ufficio di Asia, la coordinatrice della struttura CAS in cui è accolto. Il posto è una casa su due piani lanciata nella campagna appena fuori città, abbracciata dalle colline che digradano verso il confine. Da qui a qualche chilometro la vegetazione cambia: il paesaggio inizia a cospargersi di vitigni e gli acini pieni e tondi dell’uva fragola brillano negli intarsi del verde.
Su questo fazzoletto di terra, il sole di inizio ottobre illumina timidamente le prime ore del mattino; durante la notte le temperature si abbassano di molto e all’alba la terra rilascia una frescura profumata di rugiada. Jalad si è messo in quest’aria frizzantina ed è arrivato all’appuntamento con un largo anticipo. Asia lo accoglie, ma non si stupisce della precisione di Jalad. Anzi, sembra quasi aspettarselo. «E’ un’abitudine – mi spiega – alcuni di loro hanno un rispetto reverenziale degli orari. Che l’appuntamento sia con gli amici o con un operatore non fa differenza». Gli sorride, lo invita a entrare: un ragazzo con la pelle scura e i capelli neri, la barba rada e gli occhi un po’ scavati dalla stanchezza. Questa mattina verrà preparato all’audizione per la Commissione territoriale. Sono in arrivo per questo l’avvocato Andrisani e la psichiatra Martina.
Jalad è un richiedente asilo, e la sua storia non è delle più semplici; non ha condiviso il suo vissuto con gli operatori e le operatrici dell’ONG in cui è accolto; da quando è arrivato in Italia, i punti di ascolto e rielaborazione sono per lui il Cento di Salute Mentale di Mongena*, dove Martina lo segue già da alcuni mesi, e il campetto della Comunità Venti, luogo di aggregazione di ragazzi migranti ai tornei di calcetto settimanali. Asia lo accompagna nella stanza accanto all’ufficio e gli chiede di aspettare, alternando le parole a gesti rincuoranti, che si portano dentro tutto il peso di chi ha immaginato tante volte le tribolazioni di una persona costretta a lasciare l’Iran.
«CAS sta per Centro di Accoglienza Straordinaria», spiega Asia. «Jalad è nel nostro CAS da quasi un anno».
La permanenza nei Centri di Accoglienza Straordinaria o CAS dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento dei richiedenti asilo in centri di seconda accoglienza, ma nei fatti queste strutture hanno finito per costituire la principale modalità di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia. «Alcuni nostri ragazzi sono entrati nei nostri appartamenti la scorsa estate: quasi due anni che sono qui. Alcuni di loro non sono stati neanche auditi dalla Commissione. Altri hanno ricevuto un parere negativo e hanno presentato ricorso. E ora aspettano. Questa attesa può durare anni. Che cosa fa una persona sospesa dentro un Paese per due, tre anni, con un permesso di soggiorno temporaneo da rinnovare ogni sei mesi?».
Sempre più strutture di seconda accoglienza vengono dismesse per far spazio al servizio CAS. Il principale modello di accoglienza dei richiedenti asilo dovrebbe essere il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI, ex SIPROIMI, ex ex SPRAR), ma il sistema è stato gradualmente smantellato dai governi di destra degli ultimi sei anni.

Qualche numero
Nel modello CAS, il pro die/pro capite per le persone accolte varia a seconda della capienza del centro di accoglienza, da un minimo di 24€ per centri con capienza fino a 20 posti, a un massimo di 33€ per centri con oltre 300 posti. «L’accoglienza diffusa in piccoli centri è la forma più svantaggiata da un punto di vista economico», sottolinea Asia. «Per questo è tanto più difficile tentare l’accoglienza diffusa se si lavora in centri di accoglienza prefettizi. Da noi, il pro die/pro capite è 26€».
Ventisei euro, in effetti, vanno via in un attimo. «Equivalgono a circa 780 € al mese per ogni ospite. Bisogna però considerare che ogni persona ha diritto a una quota fissa di denaro contante, pari a 2,50€ al giorno. Ogni mese, quindi, bisogna sottrarre circa 75 €, che entrano nelle tasche dei beneficiari dell’accoglienza, agli iniziali 780. Se le persone accolte sono 42, come da noi, allora si dispone di circa 30.000 € al mese. Sembrano tanti! Ma con questa cifra la nostra ONG deve gestire il servizio per intero. Devono rientrarci le spese di vitto e vestiario per gli ospiti, le spese mediche non a carico del Sistema Sanitario; e poi gli affitti, le utenze, le spese di manutenzione degli appartamenti di accoglienza. E gli stipendi per me e per tutti gli altri operatori».
Nei progetti SAI, invece, la spesa pro die/pro capite è di 60€. Si può immaginare facilmente come un maggiore investimento consenta agli enti gestori di assumere più personale, garantendo un presidio più attento delle persone vulnerabili, ma anche di quelle particolarmente brillanti, le cui potenzialità, senza un sufficiente accompagnamento, verrebbero disperse a causa della loro disparità giuridica all’interno di un mercato del lavoro estremamente competitivo.
I vuoti della politica
La differenza tra i due sistemi è radicale: se la progettazione SAI accede al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, ed è di pertinenza dei Comuni, il servizio dei CAS è gestito per via prefettizia.

«Nel caso dei CAS, le Prefetture appaltano la presa in carico delle persone migranti a enti del terzo settore – cooperative, associazioni, ONG, strutture alberghiere…», sostiene Asia. «L’assegnazione di quante persone migranti a quali enti è stabilita tramite partecipazione a bandi pubblici, gare di appalto». Se dunque nel sistema SAI “l’integrazione” delle persone accolte è resa possibile da un lavoro di mediazione tra i Comuni e il territorio, nel sistema CAS non c’è alcun intento di “integrazione”, ma una mera gestione delle persone migranti, spesso in grandi strutture poco radicate nel tessuto sociale in cui si trovano, nei casi peggiori in luoghi di vera e propria ghettizzazione. Le Prefetture, del resto, sono organi amministrativi e non politici: demandando la gestione del fenomeno migratorio alla sfera dell’esecutivo, la classe politica sta rimandando la responsabilità di trattare quello delle migrazioni come un fatto ormai strutturale, di fronte a cui soluzioni provvisorie o rimedi emergenziali non sono sufficienti.
Dal loro arrivo alle successive fasi di permanenza in Italia, i soggetti con cui le persone migranti si interfacciano maggiormente sono le forze dell’ordine. «C’è la polizia di frontiera in fase di intercettazione e identificazione, gli operatori degli Uffici Immigrazione per le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, la polizia di Stato nei CPR»; l’assorbimento della persona migrante dentro i luoghi fisici in cui si esercitano controllo e repressione statali (le Questure, le Prefetture, i Centri di Permanenza per il Rimpatrio) alimenta un immaginario per il quale il migrante non è mai separato dalla sua condizione di regolarità o irregolarità – un immaginario che presta il fianco all’atteggiamento emergenziale con cui ad oggi si gestisce la stragrande maggioranza delle richieste di asilo.
«Il punto – prosegue Asia – è che lavorando nei CAS non si hanno abbastanza risorse per fare tutto. Nel nostro piccolo, noi facciamo quello che possiamo. Due miei colleghi, entrambi con una formazione da insegnanti, sono impegnati nelle lezioni di italiano. Ma spesso non riusciamo a insegnare più di quattro o cinque ore alla settimana: abbiamo troppe cose da fare, e il personale è poco. Ogni volta che siamo costretti a sottrarre un’ora di italiano per un’emergenza sanitaria, per una formalizzazione, per una questione di ordine burocratico, mi sembra di aver fallito un obiettivo».
«L’italiano, da qui si comincia», racconta Sonia, coordinatrice del progetto SAI di Morsacco*. Conoscere l’italiano è a fondamento di un percorso di vera inclusione: la lingua è veicolo immediato di comunicazione, serve a descrivere come ci si sente in ospedale o a spiegare qual è il problema con il conto corrente alle poste. Ma non si tratta solo di questo. La lingua permette agli esseri umani di dare i nomi alle cose in senso ampio: di acquisire le categorie in cui inscrivere il proprio pensare e il proprio fare, di assumere immaginari e percezioni di una collettività per comprenderla, di creare un ponte con le comunità ospitanti. Permettere alle persone accolte di imparare l’italiano mette a loro disposizione uno strumento politico, con cui negoziare la convivenza quotidiana con il territorio, e dunque di appropriarsi di quel territorio.
C’è poi la questione lavorativa. Nel modello SAI, gli enti locali costruiscono progetti di inserimento lavorativo intercettando l’offerta del territorio, ma anche la domanda. «E’ un bilancio continuo tra le competenze, a volte insospettabili, delle persone migranti, e quello di cui il nostro territorio ha bisogno», prosegue Sonia. «Spesso ci arrivano ragazzi che, tra la vita vissuta nel paese di origine e le soste durante la rotta verso l’Europa, hanno lavorato a lungo nell’agricoltura. Agganciandoci a enti territoriali riusciamo a formarli e a collocarli in aziende agricole locali; un nostro ragazzo aveva una lunga esperienza nelle lavorazioni meccaniche e tramite il progetto SAI è stato assunto in un’impesa edile come saldatore».

Ma non si tratta soltanto di questo. E’ anche un bilancio continuo tra quello che si è stati e quello che si vuole diventare. Ragioni storiche e culturali potrebbero aver costretto un ragazzo afghano a diventare un ottimo saldatore mentre sognava di lavorare in cucina. L’inserimento in un progetto SAI dovrebbe creare le condizioni perché queste aspirazioni trovino spazio. «Una buona progettazione dovrebbe includere anche gli slanci e la volontà di sperimentarsi, di cambiare strada, di contraddirsi e ritrovarsi. Tra colleghi ce lo ripetiamo spesso: mai schiacciare le risorse di una persona sul già fatto, mai rinchiudere il futuro di una persona nelle sue esperienze passate».
Ma lavorare su questi obiettivi costa fatica, tempo e denaro. L’inclusione sociale non è mai semplice. Se per il proprio futuro occupazionale i giovani con cittadinanza italiana contano sulla scuola e su un eventuale percorso universitario, le persone migranti non hanno questo canale. Inserirsi dentro le strutture burocratiche, amministrative, occupazionali italiane è complesso se si arriva senza documenti o permessi di soggiorno, con attestati e diplomi che qui non sono riconosciuti. Per l’inserimento lavorativo delle persone migranti occorrono canali appositi. Ma perché siano in grado di garantire davvero l’inserimento, questi canali devono essere in contatto con le realtà del territorio e preparare le persone accolte a quello che il territorio può offrire loro. «Per questo motivo un modello di accoglienza su base prefettizia fatica a funzionare», prosegue Sonia. «Gli enti gestori di strutture CAS non hanno risorse sufficienti per praticare quel radicamento nel territorio che consente alle persone di conoscere lo spazio che le sta accogliendo, di farlo proprio e di restituirgli un pezzetto tramite la partecipazione attiva alla vita della comunità ospitante. Il mutualismo è la chiave dell’integrazione. Tutto il resto è assistenzialismo».
A questo si aggiunge una considerazione: i canali che dovrebbero operare quell’avviamento al lavoro garantiscono anche una forma di tutela delle persone migranti, esposte quanto o più degli italiani al rischio del lavoro irregolare. «La relazione tra il possesso o meno di un permesso di soggiorno e il lavoro irregolare meriterebbe una discussione a parte», afferma Sonia. «Se non hai un permesso di soggiorno valido, non otterrai mai un contratto di lavoro regolare; e viceversa, se lavori in nero, non potrai dimostrare di aver lavorato e verrai escluso da ogni occasione di ottenere un permesso di soggiorno e di “sanare” così la tua situazione giuridica». Progetti di accoglienza come quelli predisposti dagli enti locali tramite i SAI, elaborando percorsi individualizzati, permettono alle persone accolte di accedere a circoli virtuosi di inclusione e di sfuggire al rischio dell’irregolarità.
Lo smembramento consapevole del sistema di accoglienza SAI a favore di modelli emergenziali come i CAS, oltre a supportare una narrazione politica tranquillizzante per quelle frange di cittadinanza ostili all’inclusione sociale e alla convivenza multietnica, ha anche un preciso obiettivo politico, quello di mutilare le persone migranti dei fondamentali diritti di espressione e di inserimento, punti di partenza per sentirsi parte attiva di una collettività.
Investire in modelli di accoglienza che non consentono alle persone migranti di accedere a queste forme di inclusione risponde a un preciso approccio politico all’accoglienza, un approccio basato su continue cesure e su diritti impari, in cui la categoria migrante finisce marginalizzata dalle barriere linguistiche e culturali, dalla condizione di minorità sul posto di lavoro, dalla percezione costante di doversi guadagnare la permanenza in Europa.

Presidi di resistenza
Ci sono molti servizi CAS, specie quelli di ONG realmente impegnate nella causa migratoria, che tentano di fare di più, intessendo un servizio al di sopra dei loro mezzi. Quello coordinato da Asia si sforza di andare oltre l’assistenzialismo a cui è costretta la maggior parte degli enti gestori. Il CAS di Mongena* non è nato in un’ex caserma o in un albergo dismesso. I 42 richiedenti asilo accolti vivono in cinque appartamenti sparsi per la città, secondo un modello di accoglienza diffusa tipico dei SAI.
Gli operatori e le operatrici si sforzano di incastrare l’informativa legale, le lezioni di italiano e gli inserimenti lavorativi dentro la trincea del quotidiano, fatto da accompagnamenti sanitari, relazioni con la Prefettura, comunicazioni istituzionali e distribuzioni di beni di prima necessità. «Anche se la normativa sui CAS ci sta via via prosciugando di ogni risorsa, noi stiamo provando a fare un’accoglienza di senso. Se ogni giorno riusciamo a fare anche solo un infinitesimo di quello che si dovrebbe fare aldilà dello stretto necessario, noi siamo contenti».
Ma il tipo di accompagnamento garantito dai progetti SAI non può essere eguagliato da nessun ottimo servizio CAS. «Non abbiamo abbastanza risorse. Se non ci sono braccia, mani e soprattutto teste capaci di tenere insieme tutta questa complessità, qualcosa sfugge sempre», racconta Asia con un tono rassegnato. La sua espressione si è incupita. Indica la stanza in cui Jalad sta aspettando l’arrivo dell’avvocato. «Lui è stato preso in carico dal CSM solo quattro mesi fa. Quando è arrivato da noi, sapevamo di trovarci di fronte a un ragazzo fragile. Ma abbiamo iniziato a preoccuparci davvero soltanto quando i suoi compagni di appartamento ci hanno detto che aveva smesso del tutto di uscire di casa. Passava molto tempo in camera, dormiva molto. Ero sconcertata. Come abbiamo potuto non vedere quello che stava passando? Se fossimo stati più presenti, se avessimo rappresentato un riferimento, probabilmente Martina sarebbe subentrata molto tempo fa».
Suonano alla porta. Dal piano superiore si sente lo sfrigolio di qualcosa sul fuoco, e l’odore pieno e intenso del masala chai. Martina è arrivata, e dopo pochi minuti ci raggiunge anche l’avvocato e il mediatore. «Vi stavamo aspettando». Jalad si affaccia sentendo il vociare nel corridoio. Dal suo protendersi verso gli altri si percepisce che è un po’ teso. Fa un’inclinazione con la testa, come per rincuorare una parte di sé. Entrano in sala riunioni e chiudono la porta.
*nomi di fantasia.
Rossella Marvulli
30/8/32023 https://www.meltingpot.org/





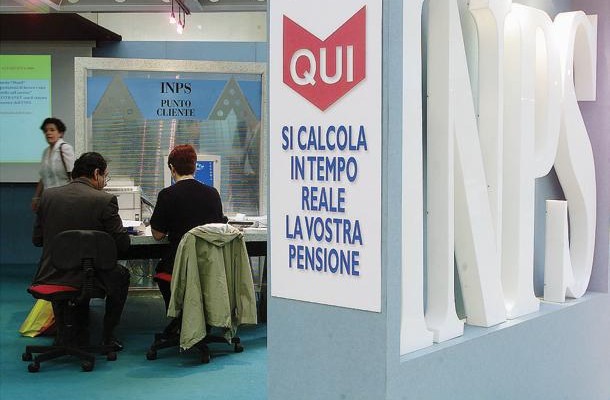




Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!