L’alternativa possibile della Comune di Parigi
I borghesi avevano sempre ottenuto tutto. Sin dalla rivoluzione del 1789, erano stati i soli ad arricchirsi nei periodi di prosperità, mentre la classe lavoratrice aveva dovuto regolarmente sopportare il costo delle crisi. La proclamazione della Terza Repubblica aprì nuovi scenari e offrì l’occasione per ribaltare questo corso. Napoleone III era stato sconfitto e catturato dai tedeschi, a Sedan, il 4 settembre 1870. Nel gennaio dell’anno seguente, la resa di Parigi, che era stata assediata per oltre quattro mesi, aveva costretto i francesi ad accettare le condizioni imposte da Otto von Bismarck. Ne seguì un armistizio che permise lo svolgimento di elezioni e la successiva nomina di Adolphe Thiers a capo del potere esecutivo, con il sostegno di una vasta maggioranza legittimista e orleanista. Nella capitale, però, in controtendenza con il resto del paese, lo schieramento progressista-repubblicano era risultato vincente con una schiacciante maggioranza e il malcontento popolare era più esteso che altrove. La prospettiva di un esecutivo che avrebbe lasciato immutate tutte le ingiustizie sociali, che voleva disarmare la città ed era intenzionato a far ricadere il prezzo della guerra sulle fasce meno abbienti, scatenò la ribellione. Il 18 marzo scoppiò una nuova rivoluzione; Thiers e la sua armata dovettero riparare a Versailles.
Di lotta e di governo
Gli insorti decisero di indire subito libere elezioni, per assicurare all’insurrezione la legittimità democratica. Il 26 marzo, una schiacciante maggioranza (190.000 voti contro 40.000) approvò le ragioni della rivolta e 70 degli 85 eletti si dichiararono a favore della rivoluzione. I 15 rappresentanti moderati del cosiddetto «parti de maires», un gruppo composto da ex-presidenti di alcuni arrondissement, si dimisero immediatamente e non entrarono a far parte del consiglio della Comune. Furono seguiti poco dopo da quattro radicali. I restanti 66 membri – non facilmente distinguibili per le loro doppie appartenenze politiche – rappresentavano posizioni molto variegate. Tra essi vi erano una ventina di repubblicani neo-giacobini (inclusi gli autorevoli Charles Delescluze e Felix Pyat), una dozzina di proseliti di Auguste Blanqui, 17 appartenenti dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori (al cui interno erano presenti sia i mutualisti seguaci di Pierre-Joseph Proudhon che i collettivisti legati a Karl Marx, spesso in contrasto tra loro) e un paio di indipendenti. La maggioranza dei componenti della Comune erano operai o rappresentanti riconosciuti della classe lavoratrice. In 14 provenivano dalla Guardia Nazionale. Fu proprio il comitato centrale di quest’ultima a consegnare il potere nelle mani della Comune, anche se questo atto fu l’inizio di una lunga serie di contraddizioni e conflitti tra le due entità.
Il 28 marzo una grande massa di cittadini si riunì nei pressi dell’Hôtel de Ville e salutò festante l’insediamento della nuova assemblea che prese ufficialmente il nome di Comune di Parigi. Anche se resistette soltanto 72 giorni, fu il più importante evento politico della storia del movimento operaio del XIX secolo. La Comune fece rinascere la speranza in una popolazione stremata da mesi di stenti. Nei quartieri sorsero comitati e gruppi in suo sostegno. In ogni angolo della metropoli, si moltiplicarono iniziative di solidarietà e piani per la costruzione di un mondo nuovo. Montmartre fu ribattezzata «la cittadella della libertà». Uno dei sentimenti predominanti fu il desiderio di condividere. Militanti come Louise Michel funsero da esempio per il loro spirito di abnegazione – Victor Hugo scrisse di lei: «facevi ciò che fanno le grandi anime folli. Glorificavi coloro che vengono schiacciati e sottomessi». Tuttavia, la Comune non visse per impulso di un leader o di poche figure carismatiche. Anzi, la sua principale caratteristica fu la sua dimensione spiccatamente collettiva. Donne e uomini si associarono volontariamente per un progetto comune di liberazione. L’autogestione non fu più considerata un’utopia. L’autoemancipazione venne ritenuta imprescindibile.
La trasformazione del potere politico
Tra i primi decreti di emergenza emanati per arginare la dilagante povertà vi furono il blocco del pagamento degli affitti (era giusto che «la proprietà facesse la sua parte di sacrifici») e la sospensione della vendita degli oggetti – per un valore non superiore ai 20 franchi – che si trovavano presso il monte di pietà. Vennero anche istituite nove commissioni collegiali che avrebbero dovuto sostituire i ministeri esistenti: guerra, finanze, sicurezza generale, educazione, sussistenza, giustizia, lavoro e scambio, relazioni estere, servizi pubblici. In seguito, venne nominato un delegato alla direzione di ognuna di esse.
Il 19 aprile, tre giorni dopo le elezioni suppletive a seguito delle quali fu possibile sostituire 31 seggi rimasti quasi subito vacanti, la Comune redasse la Dichiarazione al popolo francese, all’interno della quale furono conclamati «la garanzia assoluta della libertà individuale, della libertà di coscienza e della libertà di lavoro» e «l’intervento permanente dei cittadini nelle vicende comunali». Venne affermato che il conflitto tra Parigi e Versailles «non poteva terminare con illusori compromessi» e che il popolo aveva «il dovere di lottare e vincere!». Ben più significativi dei contenuti di questo testo – sintesi alquanto ambigua per evitare tensioni tra le diverse tendenze politiche – furono gli atti concreti attraverso i quali i militanti della Comune si batterono per una trasformazione totale del potere politico. Essi avviarono un insieme di riforme che miravano a mutare profondamente non solo le modalità con le quali la politica veniva amministrata, ma la sua stessa natura. La democrazia diretta della Comune prevedeva la revocabilità degli eletti e il controllo del loro operato attraverso il vincolo di mandato (una misura insufficiente a dirimere la complessa questione della rappresentanza politica). I magistrati e le altre cariche pubbliche – anch’essi assoggettati a controllo permanente e alla possibilità di revoca – non sarebbero stati designati arbitrariamente, come in passato, ma nominati a seguito di concorso o di elezioni trasparenti. Occorreva impedire la professionalizzazione della sfera pubblica. Le decisioni politiche non spettavano a gruppi ristretti di funzionari e tecnici, ma dovevano essere prese dal popolo. Eserciti e forze di polizia non sarebbero più state istituzioni separate dal corpo della società. La separazione tra Stato e chiesa fu reputata una necessità irrinunciabile.
Il cambiamento politico non poteva, però, esaurirsi con l’adozione di queste misure. Doveva intervenire ben più alla radice. Bisognava ridurre drasticamente la burocrazia trasferendo l’esercizio del potere nelle mani del popolo. La sfera sociale doveva prevalere su quella politica e quest’ultima – come aveva già sostenuto Henri de Saint-Simon – non sarebbe più esistita come funzione specializzata, poiché sarebbe stata progressivamente assimilata dalle attività della società civile. Il corpo sociale si sarebbe reimpossessato di funzioni che erano state trasferite allo Stato. Abbattere il dominio di classe esistente non sarebbe stato sufficiente; occorreva estinguere il dominio di classe in quanto tale. Tutto ciò avrebbe consentito la realizzazione del disegno auspicato dai comunardi: una repubblica costituita dall’unione di libere associazioni veramente democratiche che sarebbero divenute promotrici dell’emancipazione di tutte le sue componenti. Era l’autogoverno dei produttori.
La priorità delle riforme sociali
La Comune riteneva che le riforme sociali fossero ancor più rilevanti dei rivolgimenti dell’ordine politico. Esse rappresentavano la sua ragion d’essere, il termometro attraverso il quale misurare la fedeltà ai princìpi per i quali era sorta, l’elemento di maggiore distinzione rispetto alle rivoluzioni che l’avevano preceduta nel 1789 e nel 1848. La Comune ratificò più di un provvedimento dal chiaro connotato di classe. Le scadenze dei debiti vennero procrastinate di tre anni e senza pagamento degli interessi. Gli sfratti per mancato versamento degli affitti vennero sospesi e si dispose che le abitazioni vacanti venissero requisite a favore dei senzatetto. Si organizzarono progetti per limitare la durata della giornata lavorativa (dalle iniziali 10 ore alle otto contemplate per il futuro), si proibì, pena sanzioni, la pratica diffusa tra gli imprenditori di comminare multe pretestuose agli operai al solo scopo di ridurre loro le paghe, furono stabiliti minimi salariali dignitosi. Venne sancita l’interdizione al cumulo di più lavori e fissato un limite massimo agli stipendi di quanti ricoprivano incarichi pubblici. Si fece quanto possibile per aumentare gli approvvigionamenti alimentari e per diminuire i prezzi. Il lavoro notturno nei panifici fu vietato e vennero aperte alcune macellerie municipali. Furono implementate diverse misure di assistenza sociale per i soggetti più deboli – compresa l’offerta di vivande a donne e bambini abbandonati – e venne deliberata la fine della discriminazione esistente tra figli legittimi e naturali.
Tutti i comunardi ritennero che la funzione dell’educazione fosse un fattore indispensabile per la liberazione degli individui, sinceramente convinti che essa rappresentasse il presupposto di ogni serio e duraturo mutamento sociale e politico. Pertanto, animarono molteplici e rilevanti dibattiti intorno alle proposte di riforma del sistema educativo. La scuola sarebbe stata resa obbligatoria e gratuita per tutte e tutti. L’insegnamento di stampo religioso sarebbe stato sostituito da quello laico, ispirato a un pensiero razionale e scientifico, e le spese di culto non sarebbero più gravate sul bilancio dello Stato. Nelle commissioni appositamente istituite e sugli organi di stampa apparvero numerose prese di posizione che evidenziarono quanto fosse fondamentale la scelta di investire sull’educazione femminile. Per diventare davvero «un servizio pubblico», la scuola doveva offrire uguali opportunità ai «bambini dei due sessi». Infine, essa doveva vietare «distinzioni di razza, nazionalità, fede o posizione sociale». Agli avanzamenti di carattere teorico, si accompagnarono prime iniziative pratiche e, in più di un arrondissement, migliaia di bambini della classe lavoratrice ricevettero gratuitamente i materiali didattici ed entrarono, per la prima volta, in un edificio scolastico.
La Comune legiferò anche misure di carattere socialista. Si decise che le officine abbandonate dai padroni fuggiti fuori città, ai quali si garantì un indennizzo al momento del ritorno, sarebbero state consegnate ad associazioni cooperative di operai. I teatri e i musei – che sarebbero stati aperti a tutti e non a pagamento – vennero collettivizzati e affidati alla gestione di quanti si erano uniti nella «Federazione degli artisti di Parigi», presieduta dal pittore e instancabile militante Gustave Courbet. A essa presero parte circa 300 scultori, architetti, litografi e pittori (tra i tanti anche Édouard Manet). A questa iniziativa seguì la nascita della «Federazione artistica» che raccolse gli attori e il mondo della lirica.
Tutte queste azioni e disposizioni furono sorprendentemente realizzate in 54 giorni, in una Parigi ancora martoriata dagli effetti della Guerra franco-prussiana. La Comune poté operare soltanto dal 29 marzo al 21 maggio e, per giunta, nel mezzo di una eroica resistenza agli attacchi di Versailles, per difendersi dai quali fu necessario un gran dispendio di energie umane e risorse finanziarie. Inoltre, poiché la Comune non disponeva di alcun mezzo coercitivo, molte delle decisioni assunte non furono applicate uniformemente nella vasta area della città. Esse costituirono, tuttavia, un notevole tentativo di riforma sociale e indicarono il cammino per un cambiamento possibile.
Una lotta collettiva e femminista
La Comune fu ben più degli atti approvati dalla sua assemblea legislativa. Ambì finanche ad alterare energicamente lo spazio urbano, come dimostra la scelta di abbattere la Colonna Vendôme, reputata monumento alla barbarie e riprovevole simbolo della guerra, e a laicizzare alcuni luoghi di culto, destinando il loro uso alla collettività. La Comune visse grazie a una straordinaria partecipazione di massa e a un solido spirito di mutua assistenza. In questo rivolgimento contro l’autorità, i club rivoluzionari sorti con incredibile rapidità in quasi tutti gli arrondissement ebbero una funzione ragguardevole. Se ne costituirono ben 28 e rappresentarono uno degli esempi più calzanti della mobilitazione spontanea che accompagnò la Comune. Aperti ogni sera, essi offrirono ai cittadini la possibilità di incontrarsi, dopo il lavoro, per dibattere liberamente sulla situazione sociale e politica, verificare quanto realizzato dai propri rappresentanti e suggerire alternative per la risoluzione delle problematiche quotidiane. Si trattava di associazioni orizzontali che favorivano la formazione e l’espressione della sovranità popolare, ma anche di spazi di autentica sorellanza e fraternità. Erano i luoghi dove ciascuno poteva respirare l’inebriante possibilità di rendersi padrone del proprio destino.
Tale percorso di emancipazione non prevedeva discriminazioni di carattere nazionale. Il titolo di cittadini della Comune andava garantito a tutti coloro che si adoperavano per il suo sviluppo e gli stranieri avevano gli stessi diritti sociali garantiti ai francesi. Riprova di questo principio di uguaglianza fu il ruolo predominante assunto da diversi stranieri (circa 3.000 in totale). L’ungherese e membro dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori Léo Frankel non solo sedette tra gli eletti della Comune, ma fu anche il responsabile della commissione lavoro – uno dei «ministeri» più importanti di Parigi. Ruolo altrettanto rilevante ebbero i polacchi Jaroslaw Dombrowski e Walery Wroblewski, entrambi autorevoli generali a capo della Guardia Nazionale.
In questo contesto, le donne, pur se ancora private del diritto al voto e, di conseguenza, anche a quello di sedere tra i rappresentanti del Consiglio della Comune, svolsero una funzione essenziale per la critica dell’ordine sociale esistente. Trasgredirono le norme della società borghese e affermarono una loro nuova identità in opposizione ai valori della famiglia patriarcale. Uscirono dalla dimensione privata e si occuparono della sfera pubblica. Costituirono l’«Unione delle donne per la difesa di Parigi e per la cura dei feriti» (sorta grazie all’incessante attività di Élisabeth Dmitrieff, militante dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori) ed ebbero un ruolo centrale nell’identificazione di battaglie sociali strategiche. Ottennero la chiusura delle case di tolleranza, conseguirono la parità di salario con gli insegnanti maschi, coniarono lo slogan «uguale retribuzione per uguale lavoro», rivendicarono pari diritti nel matrimonio, pretesero il riconoscimento delle libere unioni, promossero la nascita di camere sindacali esclusivamente femminili. Quando, alla metà di maggio, la situazione militare volse al peggio, con le truppe di Versailles giunte alle porte di Parigi, le donne presero le armi e riuscirono anche a formare un loro battaglione. In molte esalarono l’ultimo respiro sulle barricate. La propaganda borghese le rese oggetto dei più spietati attacchi, tacciandole di avere dato fuoco alla città durante gli scontri e bollandole con l’epiteto dispregiativo di pétroleuses.
Accentrare o decentralizzare?
La Comune voleva instaurare un’autentica democrazia. Si trattava di un progetto ambizioso e di difficile attuazione. La sovranità popolare alla quale ambivano i rivoluzionari implicava una partecipazione del più alto numero possibile di cittadini. Sin dalla fine di marzo, a Parigi si erano sviluppati una miriade di commissioni centrali, sotto-comitati di quartiere, club rivoluzionari e battaglioni di soldati che affiancarono il già complesso duopolio composto dal consiglio della Comune e dal comitato centrale della Guardia Nazionale. Quest’ultimo, infatti, aveva conservato il controllo del potere militare, operando, spesso, come un vero contropotere del primo. Se l’impegno diretto di un’ampia parte della popolazione costituiva una vitale garanzia democratica, le troppe autorità in campo avevano reso complicato il processo decisionale e tortuosa l’applicazione delle ordinanze.
Il problema della relazione tra l’autorità centrale e gli organi locali produsse non pochi cortocircuiti, determinando una situazione caotica e non di rado paralizzante. L’equilibrio già precario saltò del tutto quando, dinanzi all’emergenza della guerra, all’indisciplina presente tra i ranghi della Guardia Nazionale e a una crescente inefficacia dell’azione governativa, Jules Miot propose la creazione di un Comitato di Salute Pubblica di cinque componenti – una soluzione che si ispirava al modello dittatoriale di Maximilien Robespierre nel 1793. La misura venne approvata, con 45 voti a favore e 23 contrari, il primo maggio. Fu un drammatico errore che decretò l’inizio della fine di un’esperienza politica inedita e spaccò la Comune in due blocchi contrapposti. Al primo appartenevano neo-giacobini e blanquisti, propensi alla concentrazione del potere e, al fine, in favore del primato della dimensione politica su quella sociale. Del secondo facevano parte la maggioranza dei membri dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori, per i quali la sfera sociale era più significativa di quella politica. Essi ritenevano necessaria la separazione dei poteri e credevano che la repubblica non dovesse mai mettere in discussione le libertà politiche. Coordinati dall’infaticabile Eugène Varlin, pronunciarono un netto rifiuto alle derive autoritarie e non parteciparono all’elezione del Comitato di Salute Pubblica. Per loro, il potere centralizzato nelle mani di pochi individui sarebbe stato in netto contrasto con i postulati della Comune. I suoi eletti non erano i possessori della sovranità – essa apparteneva al popolo – e, pertanto, non avevano alcun diritto di alienarla. Il 21 maggio, allorquando la minoranza prese di nuovo parte a una seduta del consiglio della Comune, fu posto in essere un nuovo tentativo di ritessere l’unità al suo interno. Era, però, già troppo tardi.
La Comune come sinonimo della rivoluzione
La Comune di Parigi fu repressa con brutale violenza dalle armate di Versailles. Durante la cosiddetta «settimana di sangue» (21-28 maggio) vennero uccisi tra i 17.000 e i 25.000 cittadini. Gli ultimi combattimenti si svolsero lungo la cinta del cimitero Père-Lachaise. Il giovane Arthur Rimbaud descrisse la capitale francese come una «città dolorosa, quasi morta». Fu il massacro più violento della storia della Francia. Solo in 6.000 riuscirono a fuggire e a riparare in esilio tra Inghilterra, Belgio e Svizzera. I prigionieri catturati furono 43.522. Un centinaio di questi subì la condanna a morte, a seguito di processi sommari inscenati da corti marziali, mentre in circa 13.500 vennero spediti in carcere, ai lavori forzati, o deportati (in numero consistente soprattutto nella remota Nuova Caledonia). Alcuni di essi solidarizzarono e condivisero la stessa sorte degli insorti algerini che avevano capeggiato la rivolta anticoloniale di Mokrani, svoltasi in contemporanea alla Comune e anch’essa schiacciata dalla violenza delle truppe francesi.
Lo spettro della Comune intensificò la repressione anti-socialista in tutt’Europa. Sottacendo l’inaudita violenza di Stato operata da Thiers, la stampa conservatrice e liberale accusò i comunardi dei peggiori crimini ed espresse grande sollievo per il ripristino «dell’ordine naturale» e della legalità borghese, nonché compiacimento per il trionfo della «civiltà» sull’anarchia. Quanti avevano osato infrangere l’autorità e attentare ai privilegi della classe dominante furono puniti in modo esemplare. Le donne tornarono a essere considerate esseri inferiori e gli operai, dalle mani sporche e piene di calli, che avevano osato pensare di poter governare, furono ricacciati nei posti della società ritenuti a loro congeniali.
Eppure, l’insurrezione parigina diede forza alle lotte operaie e le spinse verso posizioni più radicali. All’indomani della sua sconfitta, Eugène Pottier scrisse un canto destinato a diventare il più celebre del movimento dei lavoratori. I suoi versi recitavano: «Uniamoci e domani L’Internazionale sarà il genere umano!». Parigi aveva mostrato che bisognava perseguire l’obiettivo della costruzione di una società radicalmente diversa da quella capitalistica. Da quel momento in poi, anche se per i suoi protagonisti non giunse mai Il tempo delle ciliegie (secondo il titolo del celebre brano composto dal comunardo Jean Baptiste Clément), la Comune incarnò contemporaneamente l’idea astratta e il cambiamento concreto. Divenne sinonimo del concetto stesso di rivoluzione, fu un’esperienza ontologica della classe lavoratrice. In La guerra civile in Francia, Marx affermò che questa «avanguardia del proletariato moderno» riuscì ad «annettere alla Francia gli operai di tutto il mondo». La Comune di Parigi mutò le coscienze dei lavoratori e la loro percezione collettiva. A distanza di 150 anni, il suo rosso vessillo continua a sventolare e ci ricorda che un’alternativa è sempre possibile. Vive la Commune!
Marcello Musto è Professore di Sociologia presso la York University di Toronto. Le sue pubblicazioni, tradotte in oltre venti lingue, sono disponibili su www.marcellomusto.org.
18/3/2021 https://jacobinitalia.it






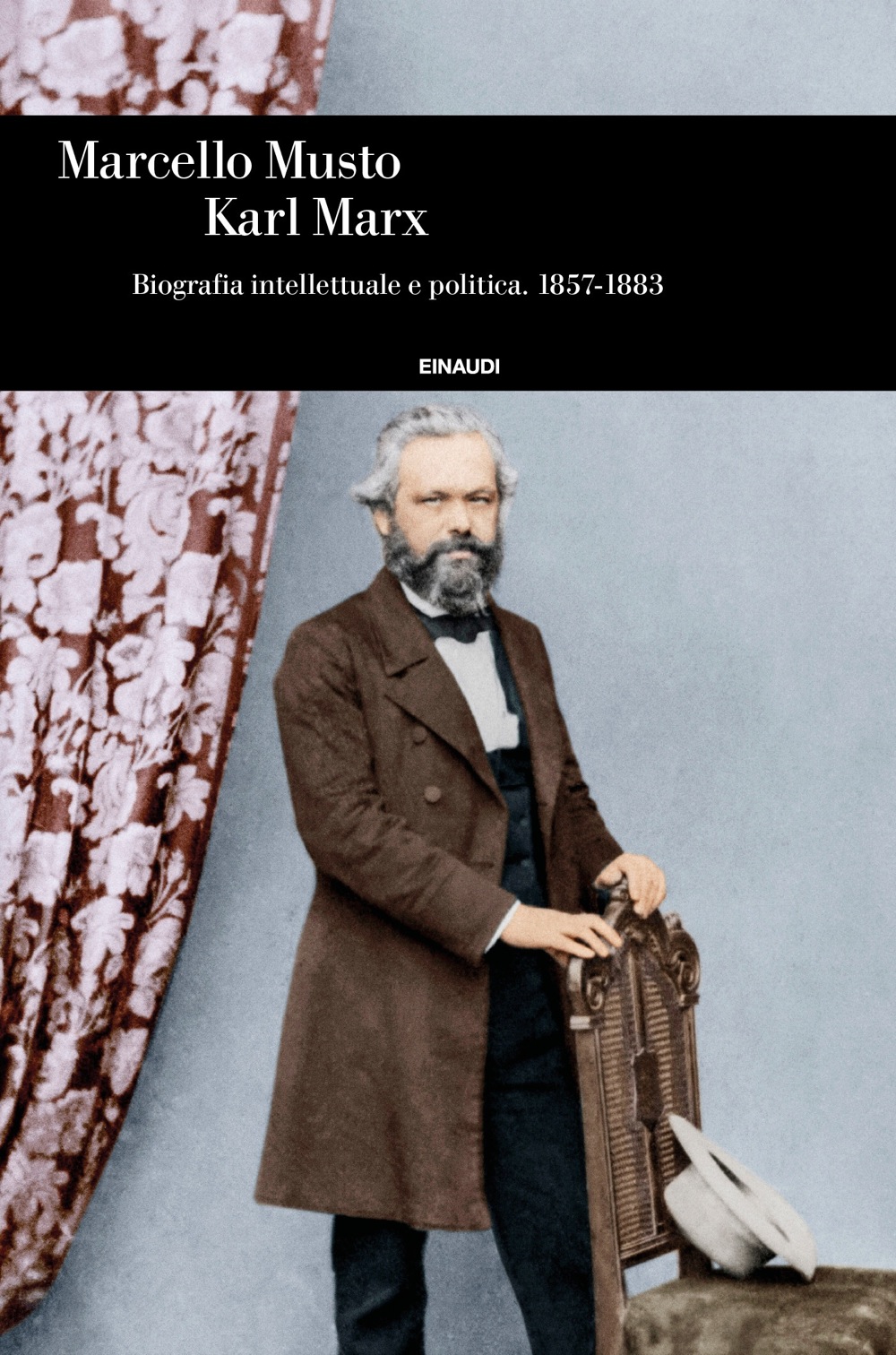



Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!