“L’anima in fabbrica”: storie e lotte dei preti operai

Le vicende dei preti operai italiani sono legate con un tratto indelebile alla fase di intensa contestazione emersa nella società e nel cattolicesimo tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento. Nella Chiesa italiana, l’intreccio tra rinnovamento suscitato dal Concilio vaticano II e spinte provocate dai rivolgimenti studenteschi e operai del Sessantotto contribuì a orientare le scelte di alcuni preti verso il lavoro in fabbrica, portandoli a vivere il proprio sacerdozio in forme molto diverse da quelle tradizionali: mantenersi con il proprio lavoro manuale, abitare in case popolari e abbandonare i segni dell’appartenenza clericale furono le tracce più evidenti di una volontà di rottura che era insieme politica e religiosa. L’intenzione largamente condivisa dai preti operai, per quanto diverse fossero le motivazioni individuali, puntava infatti a rovesciare il modello sacerdotale appreso durante il periodo della formazione sacerdotale e, insieme a questo, a mettere in discussione quella che era ritenuta una Chiesa dai forti connotati gerarchici e autoritari, come pure un’organizzazione sociale basata sulla diseguaglianza funzionale al mantenimento del sistema di potere del capitalismo industriale.
Se l’utopia di un mondo nuovo, con l’avvento di una società fondata sulla giustizia e di una comunità cristiana ispirata alla radicalità evangelica, trainò l’impegno di questi sacerdoti nel “lungo Sessantotto”, sarebbe fuorviante ridurre la loro esperienza collettiva a questo intenzionale progetto di riforma e alle turbolenze della stagione della contestazione. Uno sguardo più largo e più in profondità permette di considerare le dinamiche di lungo periodo nelle quali si inserirono i preti operai e le influenze portate dal loro radicamento in un particolare territorio, ma anche il ruolo delle reti di contatti in Italia e internazionali, le trasformazioni nelle forme della loro spiritualità e i cambiamenti nell’autocoscienza avvenuti a livello sia individuale che collettivo. Proprio l’analisi delle linee di confine lungo cui si mossero – tra cattolicesimo e movimento operaio, tra riforma religiosa e rivoluzione sociale, tra militanza politica e riflessione teologica – mostra l’originalità delle storie degli oltre trecento preti operai italiani e l’esigenza di proporre ricostruzioni storiche attente non soltanto alle uniformità, ma ancor più alle innegabili differenze rilevabili nel movimento dei sacerdoti al lavoro.
Lo studio di Giuseppina Vitale conferma ora quanto sia fruttuosa la ricerca condotta tenendo conto della molteplicità di attori, di luoghi e di motivazioni, ma anche quanto sia necessario concentrarsi su uno spazio e un tempo ben definiti per individuare le ragioni della forte carica conflittuale presente nell’esperienza dei preti operai e le ricadute di lungo periodo che la loro azione ha avuto sia nelle singole realtà locali, sia nel cattolicesimo italiano. L’analisi di una generazione di preti operai attivi negli anni del post-Concilio in zone sottoposte già in precedenza a consistenti fenomeni di industrializzazione, come la Lombardia e l’Emilia Romagna, ha permesso così di restituire in tutto il loro spessore vicende che sono indicative delle tensioni che hanno attraversato la Chiesa in epoca contemporanea, sia al suo interno, sia nel suo rapporto con la società. Proprio per restituire la complessità di quelle vicende, Vitale ha seguito all’indietro i fili di quelle storie, riannodandole alle prime esperienze condotte da don Bruno Borghi a Firenze e da don Sirio Politi nella darsena di Viareggio e, soprattutto, in Francia e in Belgio, dove all’inizio degli anni Cinquanta un centinaio preti lavorava manualmente. Nonostante quei precedenti (duramente condannati dalla Santa Sede in due riprese, nel 1954 e poi, in maniera all’apparenza definitiva, nel 1959) siano rimasti riferimenti molto vaghi e inconsapevoli sullo sfondo delle scelte quotidiane dei preti operai italiani nel post-Concilio, è esistito uno stretto legame tra le diverse generazioni di sacerdoti che lavorarono manualmente: inconsapevole, infatti, non significa irrilevante. La possibilità di svolgere un’occupazione manuale era stata infatti concessa nuovamente al clero nell’ottobre 1965 proprio a seguito dell’inesausta attività di convincimento condotta verso i padri partecipanti al Concilio da alcuni dei protagonisti di quella prima stagione che avevano continuato a lottare per la ripresa del lavoro operaio dei preti.
Ad accomunare le diverse generazioni di preti operai, vi era anche la percezione dell’inadeguatezza delle istituzioni ecclesiastiche di fronte ai cambiamenti innescati dalla modernizzazione sociale e culturale. La risposta doveva essere il rinnovamento della Chiesa o, meglio, il ritorno alle radici dell’esperienza cristiana per una missione che poteva essere una “partenza senza ritorno”, come scrivevano Henri Godin e Yvan Daniel in La France pays de mission?, il libro pubblicato nel 1943, testo di riferimento di tutti i preti operai, in Francia, in Italia e altrove. In questa ottica, la secolarizzazione era considerata una sfida per la Chiesa, non la premessa dell’annichilimento del cristianesimo nelle società moderne. Se condivisa era una simile lettura della crisi del cristianesimo, diverse furono le spinte che portarono i preti a lavorare manualmente e le forme assunte dalla loro militanza, prima e dopo il Concilio. In linea generale, tra i preti al lavoro tra gli anni Quaranta e Cinquanta fu più frequente l’iniziale motivazione religiosa (conoscere il proletariato per annunciarvi il Vangelo), seguita da una rapida presa di coscienza della strutturale situazione di ingiustizia della vita in fabbrica e poi l’approdo all’impegno sindacale. In coloro che invece – di qua e di là delle Alpi – cercarono un’occupazione manuale dopo il Vaticano II prevalsero ragioni che erano certamente spirituali e pastorali, ma anche immediatamente politiche. Anzi, proprio la scelta di caricare le richieste di aggiornamento della riflessione teologica e di rinnovamento delle strutture ecclesiastiche di una forte valenza politica, orientata alla realizzazione della giustizia economica e alla liberazione sociale dei lavoratori, caratterizzò l’impegno dei preti operai che svolsero anche per questa loro forte proiezione politica un ruolo trainante nella contestazione cattolica progressista postconciliare.
L’identificazione con la classe operaia non significava soltanto la volontà di inserirsi nel movimento dei lavoratori, al quale era riconosciuto il ruolo di “motore della storia”, ma voleva provocare la Chiesa sulla necessità di un cristianesimo vissuto “fuori del tempio”. Come mostrato dalle scelte compiute dai preti operai emiliani e lombardi, la rottura con quegli aspetti del cattolicesimo considerati frutto delle incrostazioni del passato era il primo passo per raggiungere coloro che erano lontani dai più consueti luoghi della presenza ecclesiastica (a iniziare dalle parrocchie), ma ancor prima richiamava la necessità di coerenza tra Vangelo annunciato e impegno cristiano. Le accuse al conservatorismo dei fedeli, le denunce contro le relazioni intessute dalle istituzioni ecclesiastiche con i centri di potere economico, l’adesione ai movimenti contro la guerra in Vietnam o per il mantenimento della legge sul divorzio erano scelte che collocavano nettamente nell’area politica di sinistra i preti operai che, da parte loro, avevano risolto il dilemma intorno al dovere dell’unità politica dei cattolici, ancora continuamente richiamato in quegli anni dall’episcopato italiano: costeggiare le posizioni del Partito comunista e anche dei gruppi della sinistra extraparlamentare era parte dell’identità operaia che i preti al lavoro avevano costruito attraverso successivi strappi, e non senza contraddizioni, per rompere con la più consolidata identità sacerdotale cattolica. L’intenzione era superare la concezione largamente diffusa che vedeva il presbitero come “alter Christus” e, per questo, uomo separato dagli altri. Il muro da abbattere tra Chiesa e proletariato (già evocato dal cardinal Suhard nei primi anni Quaranta, all’inizio dell’esperienza della missione operaia a Parigi) passava attraverso la rinuncia a quelli che erano considerati i privilegi sociali e religiosi della condizione sacerdotale e, ancor più, ribaltava la coscienza del prete che, scegliendo di lavorare a fianco degli operai, non soltanto si schierava “con loro”, ma più radicalmente diventava “come loro”.
Cambiare il sacerdozio diventava la pietra di paragone della volontà della Chiesa di riformare sé stessa: il prete non doveva più essere considerato il rappresentante del sacro in un mondo profano da cristianizzare, ma il testimone del gesto di donazione incondizionato di Dio all’umanità realizzato attraverso l’incarnazione in Gesù, il carpentiere di Nazareth disposto a morire per gli altri. Il prete non era colui che esercitava un magistero e aveva una funzione socialmente riconosciuta, si limitava ad amministrare i sacramenti o, secondo il Concordato, svolgeva compiti di ufficiale di stato civile, ma colui che con la sua vita mostrava un’altra immagine di sacerdote e di Chiesa. Un prete senza potere presumeva una Chiesa ugualmente povera, dove avrebbe dovuto prevalere la dimensione comunitaria su quella gerarchica, come pure l’impegno con gli “ultimi” sulle relazioni di vertice. La lotta per una Chiesa “popolo di Dio” era la stessa condotta dai preti operai per una società fondata sulla giustizia sociale e sulla partecipazione politica di tutti i cittadini, da realizzare “qui e ora”, con uno scivolamento continuo tra discorso religioso e discorso politico. Gli avversari da combattere erano allo stesso tempo i difensori dei tradizionali assetti di potere ecclesiastico e i sostenitori del sistema borghese capitalistico, gli uni e gli altri ritenuti colpevoli della subalternità nella quale era costretta in Italia, come a livello mondiale, la classe operaia.
Quanto la lettura delle dinamiche di sviluppo delle società industrializzate nel secondo dopoguerra proposta dai preti operai fosse debitrice di un operaismo fortemente segnato dalle categorie marxiste era evidente, oggetto per questo dei ripetuti richiami dei vescovi italiani e della curia vaticana. Meno evidenti furono invece le divisioni che attraversarono il collettivo italiano dei sacerdoti al lavoro (formatosi nel 1969), differenze emerse sia nelle periodiche riunioni nazionali, sia a livello locale. La puntuale ricostruzione che Giuseppina Vitale propone, sulla base di originali ricerche d’archivio e di interviste con alcuni dei protagonisti di quelle vicende, permette di seguire il frastagliato profilo di alcuni gruppi di preti operai e di superare letture univoche di un fenomeno numericamente limitato, ma molto articolato al suo interno. Dalla ricerca emergono la generale autoconsapevolezza dei preti operai, il ruolo di netta frattura politico-religiosa che questi “spezzoni di Chiesa nella classe operaia” intendevano svolgere e l’assunzione di modalità linguistiche e argomentative direttamente influenzate dalla comune militanza sindacale. Affiorano però anche i caratteri specifici coltivati da ogni gruppo locale e il diverso grado di coinvolgimento nelle organizzazioni dei lavoratori, come pure il differente atteggiamento che ogni prete operaio tenne di fronte ai vescovi e le divergenti scelte in occasione dei più acuti momenti di conflittualità sociale e di scontro con la gerarchia cattolica.
Come molti altri protagonisti della stagione della contestazione cattolica progressista negli anni del post-Concilio, i preti operai intesero cambiare la Chiesa per trasformare la società e rivoluzionare i rapporti di produzione capitalistici per riformare il cattolicesimo. Seguendo i percorsi individuali dei sacerdoti al lavoro in Italia negli anni Sessanta e Settanta, è però possibile considerare anche quanto la loro vicenda non possa essere esaurita nel dissenso postconciliare, pur essendo influenzata in maniera strettissima da questo movimento ed essendone parte non marginale. La contemporanea appartenenza alla classe operaia e alla comunità cristiana, al ruolo di lavoratori e, insieme, alla condizione di preti della Chiesa cattolica, lasciò continuamente questi sacerdoti in un equilibrio incerto e non risolto, a tratti ambivalente. La loro ostinata rivendicazione della “doppia fedeltà” si tradusse non tanto nei sospetti di inaffidabilità nei loro confronti circolanti tra i fedeli e, per motivi opposti, tra i compagni di lavoro, quanto in una “doppia debolezza” di fronte all’incrinarsi di alcuni dei riferimenti fondanti la loro identità.
La crisi del lavoro operaio e la crisi del sacerdozio, sempre più evidenti dagli anni Settanta, attraversarono e scossero il collettivo dei preti operai, con esiti individuali anche molto differenti. Sia per coloro che lasciarono il sacerdozio, sia per chi rimase nel ministero sacerdotale, l’impressione fu di aver vissuto una battaglia “contro” e alla fine di essere stati messi “fuori”: ai margini del mondo cattolico e anche – ormai cassaintegrati, licenziati o pensionati – fuori del mondo operaio. Dagli anni Ottanta, il faticoso ripensamento della propria identità da parte di molti preti operai ha rappresentato il punto di condensazione visibile della parallela crisi del lavoro operaio e del ministero sacerdotale. Il prete operaio può essere allora considerato il “prete della crisi”: crisi del sacerdozio, crisi del cristianesimo, ma anche crisi del lavoro operaio e dell’industrialismo, segnali della fine o, meglio, della trasformazione della società industriale di massa del Novecento. I sacerdoti che avevano scelto di lavorare manualmente avevano tentato una risposta al conflitto tra Chiesa e modernità, con esiti molto ridotti rispetto alle aspettative, e non soltanto per la limitata adesione del clero a questa forma particolare di ministero. Come per molti altri “uomini di frontiera” della stagione postconciliare, la fuoriuscita dai luoghi più consueti del cattolicesimo ha rappresentato per i preti operai più un’occasione di personale maturazione spirituale e politica che un contributo alla strutturale trasformazione dei rapporti di forza all’interno della Chiesa, all’orientamento in senso progressista della politica vaticana oppure al definitivo superamento nel cattolicesimo di modelli ecclesiologici basati sulla prevalenza degli elementi gerarchico-clericali.
«Ho mescolato come ho potuto l’aroma dell’incenso e la puzza della fabbrica», scriveva un prete operaio ripensando alla sua esperienza di lavoro in officina. Il lavoro manuale non era stato un espediente per dare un’“anima alla fabbrica”, come i cappellani del lavoro prima di loro avevano tentato. In modo spesso inaspettato, era stata l’occasione per molti preti operai per ritrovare l’“anima in fabbrica”, tanto da ridare un senso alla personale esperienza di fede e indicare una

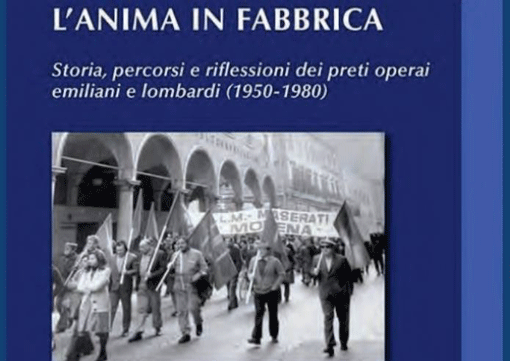







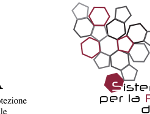
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!