L’atroce limbo dei campi libanesi
Reportage dalle terre in cui centinaia di migliaia di profughi palestinesi convivono con i poveri e i siriani, nuovi reietti del Medio Oriente
Quello che si para davanti a chi entra dentro un campo profughi palestinese in Libano non è un inferno. Perché poco c’è della «sofferenza di non poter più amare», citando Dostoevskij, e ancora meno della condizione «di chi ha cessato di sperare», rispolverando Cronin. Semmai, varcando le soglie di queste cittadelle della vergogna per il diritto internazionale e per i suoi falsi discepoli, sembra di entrare in un limbo, un «atroce limbo» come lo definì Pasolini. Dove le uniche cose che rimangono sono proprio l’amore e la speranza.
Se qualcuno volesse rendersi conto davvero del significato profondo della resistenza di un popolo dovrebbe venire qui. In questi templi eretti alla fuga forzata e all’attesa senza fine, dove ormai i palestinesi vivono in coabitazione con le fasce più povere della società libanese e con i nuovi reietti del Medio Oriente, i profughi siriani fuggiti in massa a partire dal 2011.

Dodici campi profughi sparsi su una striscia di terra lunga 250 chilometri e larga al massimo 60. A ridosso delle città principali: Tripoli, Beirut, Baalbek, Sidone, Tiro. Fuori, ma non troppo. Così come la storia, o meglio i suoi epigoni, hanno deciso di collocare il popolo palestinese. In un limbo. Catastrofico, disumano, atroce.
L’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni unite che dal 1948 si occupa dei profughi palestinesi, ne censisce 300mila. Ma la realtà parla di almeno il doppio. Di tutti i luoghi della diaspora, il paese dei cedri è forse il più difficile per questi rifugiati giunti ormai alla quarta generazione. Più difficile della Giordania, dove i palestinesi sono stati naturalizzati. Più difficile della Siria, dove pur senza cittadinanza hanno pieni diritti civili.
In Libano, infatti, i palestinesi non hanno accesso alla sanità pubblica, né all’istruzione statale. Non possono pagarsi le rette per frequentare le università private più prestigiose e anche se riescono a laurearsi in un ateneo pubblico, nella maggior parte dei casi poi non potranno esercitare la loro professione. Fuori dai campi, infatti, la legge vieta ai palestinesi di svolgere una cinquantina di lavori, tra cui avvocato, medico, farmacista, ingegnere.

Il risultato è un tasso di disoccupazione che sfiora l’80%, in un paese dove l’inflazione in cinque anni si è mangiata il 90% dei salari e la crisi economica ha triplicato le persone senza lavoro: dall’11% del 2019 al 29,6% dello scorso anno. Per i profughi, insomma, adesso la concorrenza si gioca anche sul terreno degli impieghi informali, in nero, pagati poco e male.
E la sopravvivenza si regge sui pur insufficienti servizi messi a disposizione dall’Unrwa, su cui pende il criminale taglio dei finanziamenti da parte degli Stati uniti e della maggior parte dei paesi occidentali. Una decisione che, stando a quanto dichiarato dal direttore dell’Agenzia Onu in Libano Sigrid Kaar, porterà a non poter sostenere già da questo mese il 65% delle famiglie palestinesi nel paese.
Le uniche opportunità sono quelle offerte dalle associazioni locali che riescono, spesso grazie alla cooperazione con partner internazionali, a garantire servizi di formazione e professionalizzazione. È il caso, ad esempio, dei progetti «Made in Shatila» e «Made on Border» che l’Arci empolese valdelsa e l’Arci Toscana (è insieme ai loro operatori che siamo entrati nei campi profughi all’inizio di marzo) svolgono a fianco di Beit Atfal Assomoud, la principale organizzazione sociale palestinese in Libano.

«In due anni, grazie a questi progetti – spiegano le referenti, Sarah Saleh e Hind Maraka – siamo riuscite a formare circa 150 donne nel ricamo tradizionale palestinese in dieci campi. Attraverso il centro di ricamo di Shatila si è creata una rete che permette di commercializzare i prodotti e garantisce alle artigiane un’entrata economica. Allo stesso tempo diffondiamo la cultura palestinese, manteniamo vive le nostre origini e rafforziamo la speranza del ritorno».
Azioni che rischiano, tuttavia, di essere una goccia in un mare in tempesta. Proprio Shatila, uno dei primi campi a essere realizzati nella periferia ovest di Beirut e il più conosciuto per il massacro perpetrato nel settembre 1982 dalle milizie falangiste sotto l’occhio vigile dell’esercito israeliano, un mare in tempesta lo è davvero. Ormai la densità abitativa è insostenibile.
«Qui vivono circa 50mila persone – spiega Ashwak Al Sahaabi, assistente sociale nel centro servizi gestito da Beit Atfal Assomoud – di cui più della metà non sono palestinesi. Le necessità sono in continuo aumento, ma non è possibile riuscire a far fronte alle richieste».

Dentro questo centro vengono offerti gratuitamente servizi dentistici, di supporto psicologico e di assistenza sociale, servizi scolastici per bambini da tre a sei anni, recupero per giovani non alfabetizzati. C’è un asilo nido sul tetto dello stabile, mentre nelle aule durante il pomeriggio si organizzano laboratori di disegno, ballo, fumetto. Ogni mese vengono accolte 500 famiglie, ma non basta. Perché subito fuori dall’ingresso di questo edificio si scatena la lotta per la sopravvivenza.
A testimoniare una situazione allo stremo ci sono le matasse di fili elettrici sospese. Allacci di fortuna che spesso si intrecciano alle tubature idriche e che provocano ogni anno decine di morti, specie tra i bambini che giocano per strada. Il sovraffollamento rende il campo sempre più verticale, con le abitazioni che crescono in altezza e allungano le ombre sui suoi vicoli stretti. I manifesti dei martiri degli ultimi mesi a Gaza, in Cisgiordania e al confine tra Libano e Israele costellano le pareti esterne delle case, mentre la disperazione cresce.
Come le ferite del cuore si stiano allargando ben oltre le necessità del corpo lo spiega bene Reem El Bikai, giovanissima operatrice del Centro di salute e di orientamento familiare di un altro campo profughi, quello di Beddawi.
«Il genocidio a Gaza sta avendo enormi ripercussioni psicologiche sui profughi palestinesi – racconta – Attualmente stiamo seguendo 150 famiglie nel centro di supporto psicosociale. Molte persone hanno parenti e amici nella Striscia e le notizie che arrivano sono drammatiche. C’è un senso di colpa diffuso per le atrocità che stanno vivendo i nostri fratelli e le nostre sorelle. Ma l’impatto peggiore lo scontano i bambini, messi di fronte alle immagini dei loro coetanei uccisi e alla sofferenza dei genitori».
Quasi una storia che si ripete per questo campo incastonato nella periferia nord di Tripoli e per i suoi bambini. Una storia di morte e di paura. Qua, infatti, si riversò la maggior parte degli orfani provenienti da Nabatieh e Tal El Zaatar, colpiti negli anni Settanta dai feroci massacri della guerra civile libanese. Nelle sue strade adesso si torna a respirare l’angoscia di un nuovo massacro in atto. Tra i banchi di frutta e i carretti dei venditori di manakeesh, nelle comitive di studenti all’uscita dalle scuole dell’Unrwa, sotto gli sguardi vigili dei miliziani armati che sovrintendono alla sicurezza.

Stesso clima teso aleggia dentro un altro campo, distante da Beddawi appena una decina di chilometri verso il confine siriano. Si tratta di Nahr El Bared, uno dei più grandi di tutto il Libano e l’unico – insieme a quello di Ain Al-Hilweh, nel sud – a essere direttamente controllato dall’esercito libanese. Entrarci non è semplice: serve l’autorizzazione per chi non è residente e l’accesso avviene solo attraverso dei check point dove i militari passano al setaccio anche le biciclette. Tutto è cominciato nel 2007, quando le forze libanesi distrussero buona parte del campo per combattere una cellula di Fatah Al-Islam. E ancora non è finito, visto che a oggi un terzo di questo esteso agglomerato rimane un cumulo di macerie e non tutti dei 25mila sfollati di allora sono rientrati.
Il ricordo di quando Nahr El Bared era un punto di riferimento commerciale per i villaggi vicini vive ancora nella mente degli abitanti. Accorrevano da tutta l’area per acquistare frutta, verdura e ogni tipo di prodotto nei negozi del campo perché l’assortimento era vastissimo e i prezzi buoni. Mentre adesso sulle ampie strade si affacciano market spogli e polverosi.
Non ha perso il carattere, però, questo campo affacciato sul Mediterraneo. Poco distante dal grande murales di Arafat, all’altezza dell’incrocio tra i due viali che dividono l’area abitata in quattro, una carcassa di auto giace con gli sportelli aperti e delle casse attaccate alla radio. C’è una piccola folla assiepata intorno ad ascoltare gli ultimi aggiornamenti da Gaza. È come se quello stare insieme dicesse che nonostante tutte le catastrofi l’umanità non muore, nonostante la distanza non svanisce il senso di appartenenza.
È Fahmi Mousse, supervisore dei campi del nord per Beit Atfal Assomoud, a spiegarlo: «Tenersi aggiornati su ciò che sta avvenendo – dice – è straziante, perché il dolore di chi sta sotto le bombe è il nostro dolore. Ieri come oggi. Ma il nostro è un popolo che è costretto a essere forte, non abbiamo scelta».
Fahmi vuole mostrarci i laboratori per i training professionali, che la sua associazione organizza nel campo. A fianco del centro servizi sono stati allestiti dei container: in uno si insegna taglio e messa in piega per aspiranti parrucchieri, in un altro i futuri idraulici fanno pratica con lavandini e scarichi, in un altro ancora si mostra come far funzionare e allestire un pannello fotovoltaico.
«Dare un’opportunità di crescita e autonomia ai ragazzi e alle ragazze nei campi – afferma – è un lavoro decisivo. Senza prospettive per loro non c’è futuro per nessuno. E il futuro è l’unica opzione che il nostro popolo si può permettere». L’unica e la più importante.
Marco Pagli, giornalista e scrittore, collabora con quotidiani locali, riviste cartacee e online su temi di economia dei territori e politica locale e internazionale. È autore di due libri sulla storia di Empoli e della Valdera.
15/3/2024 https://jacobinitalia.it/




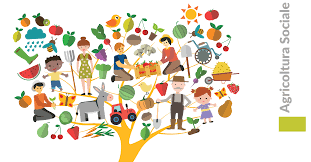





Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!