Le (false) promesse delle politiche attive del lavoro
La diminuzione delle tutele nel rapporto di lavoro è stata presentata, dai primi anni 2000, come una scelta poco impattante sul lavoratore in quanto si prometteva una tutela maggiore e più efficace nel “mercato” del lavoro. In questo modo, si diceva, l’impresa avrà meno vincoli e potrà rispondere meglio alle sfide della competitività senza i lacciuoli derivanti da una legislazione protettiva del lavoratore che impedirebbe una risposta organizzativa in tempi rapidi; d’altra parte, il lavoratore, fuori dall’azienda, non sarebbe stato lasciato solo in quanto lo avrebbero preso in cura i servizi per l’impiego, sia attraverso una riforma della tutela contro la disoccupazione involontaria, sia soprattutto accompagnandolo in un processo di aggiornamento e miglioramento professionale al fine di renderlo appetibile alle “nuove” esigenze dell’impresa e, dunque, facilmente ricollocabile.
In questo senso diventava centrale la formazione professionale che non doveva più essere svolta sulla base dei tradizionali sbocchi, ma essere innovativa nel senso di intercettare i bisogni formativi e le qualifiche professionali di ultima generazione (soprattutto collegata a lavori in cui è forte un utilizzo avanzato dell’informatica e della tecnologia), intrecciando oltretutto l’offerta professionale con le esigenze territoriali.
I passaggi attraverso i quali si è flessibilizzato il lavoro, dall’aumento delle tipologie contrattuali atipiche all’ampliamento della possibilità del ricorso a rapporti a tempo determinato al lavoro somministrato, sono stati effettivamente accompagnati da riforme dei Centri per l’impiego, costituzione di Agenzie per l’impiego o per le politiche attive come l’Anpal. In particolare, quest’ultima, è il “prosieguo” di Italia Lavoro S.p.A., nata alla fine degli anni 90 con il compito specifico di sviluppare progetti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
Dal 2001 e sino a tutto il 2015, la Società ha operato quale ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, attuando interventi di politica attiva del lavoro, per poi essere trasformata in ente dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, prendendo la denominazione di ANPAL Servizi. Dunque, è su questa società che si è pensato di assegnare un ruolo di primo piano nella gestione delle politiche attive del lavoro ed anche quelle collegate, successivamente, al Reddito di Cittadinanza.
Senonché, si è facilmente rilevato che una gran parte delle inefficienze delle politiche attive è imputabile alla circostanza che vi sono troppi livelli in cui esse si articolano. È ben noto infatti che, in maniera viepiù significativa a seguito della riforma del Titolo V della Carta costituzionale, gran parte delle competenze sono incardinate nelle Regioni e Province autonome, le quali rivendicano grandi spazi di autonomia, quando non l’esclusività della competenza in materia (analizzano lo sviluppo di plurime esperienze a livello territoriale P.G. Bresciani, P.A. Varesi (a cura di), Servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro. Le buone pratiche locali, risorsa per il nuovo sistema nazionale, Franco Angeli, Milano, 2017), e che il più delle volte attuano interventi sulla base di indicazioni e, soprattutto, di relativi finanziamenti dell’Unione Europea.
In questo contesto, è facile immaginare quanto possa essere difficile solo pensare, ad esempio, che l’Anpal possa promuovere, coordinare e vigilare i programmi formativi destinati alle persone occupate e disoccupate o svolgere attività di assistenza con riferimento alle Regioni e ai Centri per l’Impiego. Anche volendo andare a vedere i risultati raggiunti dai propri navigator (la cui efficacia pare ancora navigare in alto mare) si capirebbe ben presto quanta fatica essi facciano a muoversi in un coacervo di soggetti e interessi.
A complicare il quadro, va poi ricordato lo spazio occupato dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, organismi di natura associativa istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che scelgono di aderirvi, e che rispondono a logiche difficilmente coordinabili considerato che le azioni formative finanziate dai Fondi qualificano lavoratrici e lavoratori in sintonia con le strategie dell’impresa, riducendo a ben vedere il livello di efficacia dell’intervento.
Ad una molteplicità di soggetti, con le criticità appena accennate, si somma poi il susseguirsi di interventi stabiliti da normative nazionali e regionali, che inseguono esigenze impellenti piuttosto che una linea organica di interventi. L’elenco sarebbe lungo ed esulerebbe dalla riflessione di sistema che qui ci si pone; basti solo pensare, oltre alla ricordata istituzione dei Navigator, all’Assegno di ricollocazione che “sostituisce” il “Contratto di ricollocazione” che il legislatore aveva introdotto solo (!) alcuni mesi prima con d.lgs. n. 22 del 2015.
Oggi l’Assegno di ricollocazione costituisce senza dubbio una misura di politica attiva del lavoro (v. artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 150 del 2015 e delibere dell’Anpal), ma che ha subito varie “vicissitudini” essendo stata recentemente sospesa per alcuni, ma non per tutti (sulla vicenda si rinvia a AA.VV., Il nuovo corso delle politiche attive del lavoro: l’assegno di ricollocazione, in G. Canavesi, E. Ales, La tutela per la disoccupazione nelle trasformazioni del lavoro, Eum, 2020, p. 71 ss.).
Nella sostanza tale misura può essere considerata l’attualizzazione di uno strumento presente fin dagli anni sessanta del secolo scorso negli Stati Uniti d’America: una sorta di outplacement in quanto i percettori di Naspi (da almeno quattro mesi) possono rivolgersi al Centro per l’Impiego o ad un soggetto privato accreditato per i servizi al lavoro e beneficiare di un servizio di assistenza finalizzato alla ricerca di nuova occupazione con la previsione che l’ente prescelto, se riesce a ricollocare al lavoro la persona, riceve un importo calcolato in base al tipo di contratto.
A prescindere dalla efficacia di una tale misura, quel che qui preme rilevare è che la vicenda non fa che confermare quanto sia “effimera” la strada che di volta in volta si percorrere e come l’introduzione di nuove misure, anche a distanza di pochissimo tempo, aumenti gli aspetti di criticità e complessità che rendono gli strumenti poco appetibili. Per altro verso, la spinta quasi compulsiva a intervenire sulla disciplina attesta l’assenza di una vera e propria visione sistematica e progettuale, essendo piuttosto il legislatore in balia delle esigenze via via contingenti.
In un’ottica funzionalista, da un lato, se si assumesse non la mera logica di mercato (a maggior ragione in un mercato del lavoro come quello italiano in cui la forbice fra domanda e offerta di lavoro è amplissima), ma una logica di tutela della persona disoccupata, si dovrebbe pensare ad un maggior ruolo dello Stato nella offerta di occasioni di lavoro utilizzando egli stesso una esuberante forza lavoro che non trova allocazione per indirizzarla in servizi dedicati al bene comune (valorizzano il nesso tra politiche attive del lavoro e “bene comune” P. Grasselli, C. Montesi (a cura di), Le politiche attive del lavoro nella prospettiva del bene comune, Franco Angeli, Milano, 2010); dall’altro a fronte della constatazione che le offerte formative svolte in gran parte dalle Regioni o loro enti sono il più delle volte tardive rispetto a bisogni in continua evoluzione, andrebbe ripensata quella tipologia di contratti che vanno sotto il nome di contratti di lavoro formativi ovvero a causa mista.
In questo senso, la riflessione andrebbe spostata sulla effettiva utilità del contratto di apprendistato c.d. professionalizzante in quanto sembra lasciare troppo spazio ad un suo uso “fraudolento” dei diritti del lavoratore e che poco incide sulla effettiva elevazione in conoscenze e tecniche se non altro in relazione alla durata (tendenzialmente di anni e non di poche settimane). Se è vero che, per l’acquisizione di competenze medie quando non basse, è nell’azienda che si riesce ad impartire quelle nozioni che rendono adeguato il lavoratore alle mansioni che si chiedono, è cosa nota che essa normalmente avviene sul campo e nel giro di poco tempo.
In una sorta di paradosso, dovrebbe essere invece il Contratto di apprendistato di alta specializzazione a dover essere maggiormente spinto e supportato in quanto qui sì il collegamento (per esempio tra scuole di alta specializzazione o dottorati di ricerca universitari e imprese) potrebbe giustificare l’istituto.
Nella realtà, invece, il collegamento tra formazione di elevata qualità che tendenzialmente solo al di fuori dell’Azienda e segnatamente nell’Università e nei Centri di ricerca si può trovare, il Contratto di apprendistato di terzo tipo sembra essere il meno utilizzato ponendo la necessità di una riconsiderazione organica vuoi delle misure di protezione universalistica, vuoi di percorsi che permettano al “pubblico” di rispondere al bisogno di lavoro, vuoi offrendo alle imprese uno strumento contrattuale che sia effettivamente indirizzato a collegare il sapere con la concretizzazione applicativa delle imprese.
Oltre a ciò, appare ineludibile un’analisi a largo spettro dei risultati di “riforme” e interventi normativi, che sembrerebbero avere dimostrato l’insostenibilità e l’inefficacia di una logica eminentemente mercantilistica e localistica, che ha finito per porre al centro i bisogni degli operatori economici e istituzionali coinvolti più che la tutela (in termini di formazione professionale) delle persone in cerca di occupazione. Sembrerebbe, infatti, ormai evidente che non è il mercato il luogo idoneo a garantire le giuste risposte alle domande di formazione; né i livelli di regolazione regionale e territoriale appaiono necessariamente dotati dell’angolo visuale più adatto ad individuare prospettive e orizzonti da seguire, in un approccio che leghi le esigenze della produzione con i bisogni di formazione e lavoro.
La stagnazione della domanda aggregata e l’insufficiente utilizzazione della capacità produttiva porta le politiche di stimolo all’occupazione basate su incentivi fiscali ad essere inefficaci e dannose per quanto riguarda gli effetti strutturali di medio periodo che tali politiche rischiano di determinare.
È noto che la maggioranza delle imprese non domanda più lavoro rispetto al suo fabbisogno. Nel sistema ci sono imprese che catturano la domanda estera o che operano in settori protetti (l’esempio di scuola è il comparto farmaceutico) le quali possono essere più sensibili ad alcune politiche attive, ma fino ad un certo punto in quanto non assumerebbero personale “a prescindere” e quindi anche per loro gli incentivi portano ad un incremento dei margini di profitto abbassando il costo del lavoro. È il tema della allocazione dei profitti derivanti dalla riduzione della spesa del personale: come noto in Italia i “risparmi” non vengono utilizzati per investimenti e potenziamento della capacità produttiva quanto portati a rendita. Per quanto riguarda le imprese a basso valore aggiunto è risaputo che è connaturata la scelta di pagare il meno possibile la forza lavoro e non risultano evidenze di un utilizzo degli incentivi per aumentare la capacità produttiva e generare nuova occupazione. Ecco perché la mera decontribuzione non porta il sistema delle imprese a scegliere di investire in ricerca, sviluppo e formazione dei propri dipendenti, mentre uno sviluppo dell’apprendistato di alta formazione, in collegamento, con le Università potrebbe dare un vero contributo all’aumento della competitività e al lavoro di qualità (anche in termini di aumento del personale).
In un momento storico come quello attuale, in cui l’emergenza sanitaria si è incaricata di svelare l’imprescindibile necessità di una visione e di un intervento statale forti, solo una politica industriale di più elevato ed ampio profilo sarebbe in grado, per propria essenza, di programmare e porre in essere le soluzioni di sistema necessarie ad uscire dalle situazioni di crisi.
Antonio Di Stasi
29/11/2020 https://www.eticaeconomia.it







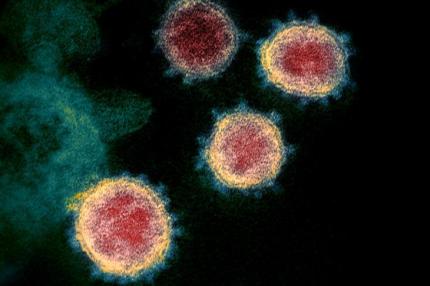


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!