L’economia di guerra non salverà il capitalismo europeo
Poco tempo fa Mario Draghi, rivolgendosi ai commissari dell’UE, ha lanciato un grido d’allarme – fate qualcosa! (https://volerelaluna.it/commenti/2025/02/28/draghi-noi-e-langoscia-quotidiana-che-ci-pervade/) – di fronte alle prospettive inquietanti dell’economia europea.
Il rapporto sulla competitività, che era stato redatto sotto il suo coordinamento, indicava tre prospettive di rilancio: provare a colmare il divario nella ricerca tecnologica nei confronti di USA e Cina, in particolare rispetto all’intelligenza artificiale; costruire un piano congiunto per la decarbonizzazione, da un lato, e la crescita della competitività, dall’altro, in modo che uno sviluppo troppo rapido e rigido della prima non andasse a impattare negativamente sulla seconda; e, infine, finanziare un imponente riarmo, definito diplomaticamente difesa, per attivare una forte domanda pubblica. La debolezza delle proposte era tutta nel fatto che i capitali privati europei da molti anni non vengono investiti nell’industria del continente, ma migrano, nella misura di 500 miliardi di euro nel solo 2024, oltre Atlantico nel paradiso valutario, finanziario e fiscale del dollaro.
La Commissione europea, stimolata a fare qualcosa purchessia, ha agito sull’unica leva che può in qualche misura controllare: togliere i vincoli sul debito pubblico – quelli fissati dal trattato di Maastricht – per permettere una forte spesa in campo militare ai diversi stati che formano l’Unione (150 miliardi di euro che possono essere attinti dai fondi comuni e altri 650 miliardi di possibile debito pubblico nazionale). Ora sorprendentemente tutti scoprono che le nazioni europee si muovono in ordine sparso per potenziare i loro eserciti senza costruire una improbabile difesa comune: in primo luogo la Germania ha ottenuto con un artificio istituzionale di far approvare dal Parlamento della scorsa legislatura, ormai sostanzialmente decaduto, una modifica costituzionale che ha rimosso il vincolo del debito pubblico e permetterà un gigantesco piano di riarmo (circa 400 miliardi di euro) e un forte investimento nelle infrastrutture (altri 500 miliardi di euro). Nel 1933 Hitler avviò un piano analogo rimilitarizzando la Germania, dopo la sconfitta nella Prima guerra mondiale e il trattato di pace particolarmente oneroso, e costruendo il grande sistema autostradale tedesco: al suo apogeo l’impegno militare nazista costituì il 6% del PIL. Per avere un confronto con la situazione attuale, basti pensare che in Europa la sola Polonia, ad esempio, spenderà quest’anno il 4,7% del PIL in armamenti e che il presidente polacco Tusk ha dichiarato di voler superare il 5% portando gli organici dagli attuali 200 mila militari polacchi fino a 500 mila; progetta inoltre l’addestramento obbligatorio per tutti i cittadini maschi.
Oggi attraverso tutti i giornali e i media siamo sommersi da statistiche, più o meno credibili, sulla diffusione di armi in Europa e sulla consistenza dei vari eserciti. Ad esempio, secondo il Military Balance dell’International Institute for Strategic Studies (Iissad) oggi l’Europa (compresa l’Ucraina) vanta 2milioni e 670mila militari di professione, rispetto ai 2 milioni della Cina, al milione 300 mila degli USA e al milione 130 mila della Russia. Essa dispone di 8642 carri armati (più di Cina e Russia messe insieme, più di tre volte degli USA); possiede più di 2000 aerei da combattimento rispetto ai 1200-1400 dei russi o degli americani o dei cinesi; è in grado di schierare 18465 pezzi d’artiglieria che sono il doppio circa di quelli cinesi e più di tre volte quelli americani o russi. L’Europa è dunque già la parte più militarizzata del mondo e si accinge a rafforzare questo suo discutibile primato. Ad oggi e prima di ogni futuro sviluppo, secondo Stefano Cingolani che lo scrive sul Foglio, la spesa militare europea è già cresciuta di più del 50% dal 2014, anno di sostanziale inizio della guerra in Ucraina. Tuttavia, come ha affermato Mario Draghi, nel 2023 solo il 4,5% della spesa militare dell’Unione europea è stata di ricerca e sviluppo rispetto al 16% americano.
Osservando, però, seppur da profani le due terribili guerre che si stanno oggi combattendo in Europa o nel vicino Medio Oriente, sembra di poter dire che molti degli armamenti tradizionali che sono stati protagonisti nei conflitti del secolo scorso, siano oggi spodestati da strumenti nuovi, come i droni e i missili a lunga gittata, e da supporti logistici diversi, come le reti digitali alimentate da satelliti che volano negli strati bassi dell’atmosfera. Appare, dunque, paradossale, ma forse neanche troppo, che questi nuovi strumenti più sofisticati richiedano in ultima istanza un forte apporto sul campo dell’arma più tradizionale, come la fanteria. Sappiamo, infatti, che in modo analogo, molti degli strumenti digitali più avanzati, che stanno rivoluzionando il nostro modo di lavorare e di comunicare, richiedono alla base un forte lavoro umano di immissione, di revisione e di controllo dei dati. E d’altra parte è sotto gli occhi di tutti il fatto che in questi conflitti il coinvolgimento della popolazione civile è sempre più pesante. Ciò che emerge drammaticamente dalla guerra in Ucraina e da quella in Palestina è la necessità per ognuna delle parti che combattono di poter godere di un consenso significativo da parte della propria popolazione e, per converso, la volontà di fiaccare la resistenza della popolazione del nemico. Accanto alla potenza delle armi, dunque, le nazioni in guerra utilizzano ampiamente strumenti propagandistici e di manipolazione dell’opinione pubblica locale e internazionale. Forse è solo la conferma del noto detto di von Clausewitz a proposito del senso politico della guerra, ma certo questi conflitti di oggi, anche se non sono arrivati, finora, all’ecatombe nucleare, sembrano richiedere un numero drammatico di vittime civili. Probabilmente è questo allora il significato dei sorprendenti pronunciamenti bellicisti di molti intellettuali e giornalisti, anche qui nel nostro paese, a favore della riscoperta e della rivalorizzazione dei sentimenti guerreschi tra la popolazione civile (https://volerelaluna.it/controcanto/2025/03/17/il-coraggio-di-disertare/): cercano di prepararci, noi cittadini, al sacrificio che dovremmo affrontare nel caso di un coinvolgimento in una qualche futura guerra.
Il rafforzamento in termini moderni delle forze armate europee richiede, dunque, una mobilitazione pseudoculturale e, soprattutto, l’acquisizione di nuove tecnologie. Scrive Draghi nel suo rapporto che «tra la metà del 2022 e la metà del 2023, il 78% della spesa totale per gli appalti [di carattere militare] è andato a fornitori non UE, di cui il 63% è andato agli Stati Uniti». Questo significa che l’aumento della spesa militare per l’acquisizione di nuovi strumenti tecnologici non alimenterà, se non marginalmente, la produzione europea di armi, ma favorirà la crescita delle industrie belliche americane e di altri paesi: l’effetto moltiplicatore sul PIL di tale spesa, dunque, che già di per sé non è particolarmente elevato, perché si alimenta dell’unica domanda statale, sarà ulteriormente ridotto a causa dell’importazione dall’estero. Si può quindi affermare che i piani di riarmo dei singoli paesi europei avranno scarso effetto sul rilancio dell’economia, almeno fintanto che non si determini un ulteriore sviluppo bellico che coinvolga direttamente l’Unione europea.
Illustrando il suo rapporto ai parlamentari italiani, Mario Draghi ha utilizzato uno stile discorsivo e pedagogico, forse tenendo conto del livello di preparazione dell’uditorio: ha detto esplicitamente che in Italia si è scelto volutamente di tenere bassi i salari per favorire la competitività delle nostre merci sui mercati internazionali. Il quadro internazionale di crisi del processo di globalizzazione e di ripresa di una politica di imposizione di dazi e di protezioni dei mercati interni richiede adesso un cambio di paradigma. Bisogna dunque ridare più importanza al mercato interno per sostenere la nostra economia che verrà penalizzata sui mercati internazionali. Naturalmente Draghi non ha proposto di alzare i salari e di assumere nel pubblico impiego per alimentare la domanda interna, ma ha giustificato la proposta europea di riarmo e implicitamente la riconversione del settore industriale verso la produzione bellica, come si sta già esplicitamente facendo in Germania, dove, ad esempio, lo stabilimento Volkswagen di Osnabruck verrà riconvertito da Rheinmetall alla produzione militare.
La spesa militare in Italia è oggi l’1,57% del PIL: con il piano europeo essa dovrebbe crescere fino al doppio, passando dagli attuali 33,5 miliardi annui a 65 miliardi di euro. In Italia ci sono circa 165 mila militari di professione: per metà si tratta di ufficiali e sottufficiali; l’altra metà è costituita dai soldati. Nel 2022 secondo la Corte dei conti il 65,7% della spesa è stata per il personale, il 17,6% per le esercitazioni e solo il 16,7% per l’armamento. Dati meno aggiornati, ma sufficientemente credibili, ci dicono come sono strutturate le forze armate italiane: tra gli ufficiali di grado superiore ci sono 480 generali (di cui 50 di corpo d’armata) che determinano un rapporto di 1 generale ogni 378 militari; se si considerano tutti gli ufficiali si ha un rapporto di 1 ufficiale ogni 6-7 militari. Attualmente 12 mila militari italiani sono impegnati in missioni presso paesi esteri con un impegno finanziario non indifferente, finalizzato al pagamento della trasferta. Inoltre, bisogna considerare che nel nostro paese ci sono altri 160 mila tra carabinieri e guardie di finanza, a dimostrazione che dal dopoguerra la priorità è stata data al controllo del territorio nazionale, più che alla cosiddetta difesa dei confini che probabilmente era affidata nei fatti ai militari americani di stanza nelle numerose basi presenti sul nostro territorio. Finora dal Ministero delle Difesa è emersa la proposta di un incremento di 40 mila unità per l’esercito e di 9 mila per la Marina. Quindi, a un osservatore profano, questa struttura delle forze armate italiane appare attualmente poco adatta a sostenere un impegno bellico purchessia, anche solo come forza di reale deterrenza, schierata a protezione di aree critiche, come quella che vanno immaginando alcuni politici e militari europei.
Più “brillante” sembra essere la situazione dell’industria militare italiana: essa è raggruppata in Leonardo, soprattutto, e in Fincantieri, per quanto riguarda l’armamento navale. Leonardo, come tutte le industrie militari europee, ha il vento in poppa: dall’inizio dell’anno i suoi titoli sono cresciuti del 68%, mentre dall’inizio della guerra in Ucraina nel 2022 l’aumento è stato del 529% portando la capitalizzazione di borsa a 25 miliardi di euro. Sulla base dei risultati del 2024 il CDA ha proposto un incremento del dividendo per gli azionisti del 90% rispetto all’anno precedente: il Tesoro è il primo azionista col 30% delle azioni. Per il 2029 Leonardo prevede un incremento del 24% per gli ordini (pari a 26 miliardi di euro), del 24% dei ricavi (pari a 24 miliardi) e del 70% dei profitti (pari a 2,8 miliardi). Il progetto industriale di Leonardo, in collaborazione con Thales (Francia), comprende anche la produzione tra due o tre anni di un primo numero di 18-20 satelliti militari; sono in progetto anche joint venture con Rheinmetall (Germania) per la produzione di carri armati e con Baykar (Turchia) per la produzione di droni.
Se si guarda, però, il quadro generale dell’economia europea e italiana la situazione appare molto preoccupante. Nella sua presentazione del rapporto ai parlamentari, Draghi si è soffermato sul tema dell’energia. Ha segnalato come l’Europa sia il più grande consumatore al mondo di gas per produrre energia: per questo, ma lui non l’ha detto, il rapporto con la Russia era fortemente funzionale per l’industria europea e l’interruzione della fornitura diretta l’ha nettamente penalizzata. Così in Europa, tra settembre e febbraio, il prezzo del gas naturale all’ingrosso è aumentato in media di oltre il 40%, con punte di oltre il 65%. Di conseguenza anche i prezzi dell’elettricità all’ingrosso sono aumentati nei diversi Paesi europei, e continuano a essere 2-3 volte più alti dei prezzi negli Stati Uniti. Questo problema è ancora più netto in Italia, dove, come scrive Draghi, i prezzi dell’elettricità all’ingrosso nel 2024 sono stati in media superiori dell’87%, rispetto a quelli francesi, del 70% rispetto a quelli spagnoli, e del 38% rispetto a quelli tedeschi. In Italia il gas rappresenta circa il 50% del mix elettrico nazionale, mentre esso è meno del 15% in Spagna, dove è stata attuata una forte riconversione verso il solare e l’eolico, e meno del 10% in Francia, dove una fetta consistente dell’energia proviene dal nucleare. Anche la Germania, come l’Italia, ha invece, una forte dipendenza dal gas come fonte energetica, al punto che nel quarto trimestre del 2024 ha accresciuto ancora il suo consumo del 5,7%. In Italia, inoltre, pesa moltissimo la tassazione: nel primo semestre del 2024, l’Italia risultava il secondo Paese europeo con il più alto livello di imposizione e di prelievi non recuperabili per i consumatori elettrici non domestici.
Costi dell’energia così alti penalizzano evidentemente le aziende rispetto ai concorrenti stranieri e mettono a rischio non solo i settori tradizionali dell’economia, ma anche lo sviluppo di nuove tecnologie che utilizzano, ad esempio, i data center, i quali richiedono, infatti, un altissimo consumo di energia. Anche per questo aspetto, come per la difesa i paesi europei si muovono, però, in ordine sparso senza far valere il fatto di essere il maggior acquirente sul mercato internazionale: è un’ulteriore conferma che l’UE non ha realizzato nessuna reale integrazione funzionale tra le diverse imprese nazionali, ma si è limitata a permettere una mobilità sul controllo dei pacchetti azionari, motivata non solo dalla ricerca di profitto, ma anche dal perseguimento di maggiori esenzioni fiscali. In Italia, in particolare, la produzione industriale è diminuita nel 2024 del 3,5% segnando una contrazione che si va prolungando dopo la parziale ripresa del dopo Covid: i consumi interni sono in diminuzione e le esportazioni verso l’estero dei tradizionali prodotti della filiera alimentare dovranno fare i conti con la politica dei dazi che, a partire dagli USA, rischia di investire tutto il mondo.
In Europa lo sviluppo capitalistico dal secondo dopoguerra si è costruito sui consumi di massa e, in particolare, sul settore dell’auto: Germania, Francia, Italia, Spagna sono stati grandi produttori. Con la caduta del muro di Berlino i produttori dell’Europa occidentale hanno iniziato a delocalizzare gli impianti nei paesi dell’est (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria) che sono progressivamente entrati nell’Unione europea. Di fronte alla progressiva saturazione del mercato occidentale la delocalizzazione ha raggiunto i paesi asiatici e la Cina, in primo luogo, che è diventata velocemente un nuovo grande mercato. Tuttavia, le capacità di innovazione di processo e di prodotto dei produttori europei si sono via via ridotte: il passaggio dal motore a combustione interna a quello elettrico è stato continuativamente ritardato, mentre si è cercato di produrre, invece, soprattutto veicoli di alta gamma, proprio mentre i consumatori interni sono stati penalizzati dal blocco dei salari e dall’inflazione, come ha riconosciuto Draghi per quanto riguarda l’Italia. La grande polarizzazione sociale e la forte concentrazione della ricchezza prodotte dal neoliberismo globalista, da un lato, hanno ristretto i mercati nazionali e, dall’altro, hanno indotto una sorta di strabismo strategico dei gruppi dirigenti che hanno immaginato un grande, ma inesistente mercato del lusso. Ad esempio, la mega industria che doveva produrre un’enorme quantità di batterie per le auto elettriche in Norvegia è già fallita perché si è orientata alla costruzione di un tipo di batteria troppo costoso che, di conseguenza, non ha avuto mercato. I cinesi, all’opposto, hanno scelto di produrre auto economiche che utilizzano batterie a basso costo e si preparano a invadere il mercato europeo, se non dovranno subire dei dazi troppo elevati e se l’Europa non ritarderà ulteriormente la costruzione di una rete per la ricarica delle batterie per difendere così, attraverso questi ritardi, la produzione locale ormai obsoleta.
Dunque, molte, forse troppe contraddizioni si stanno addensando sull’Europa dal punto di vista militare, politico, energetico ed economico: soprattutto non si vede una regia comune che sia in grado di affrontare tutti questi problemi, nonostante gli appelli e i consigli di Mario Draghi. È probabile, inoltre, che lo scontro tra i paesi capitalistici più o meno democratici oppure più o meno oligarchici si accentui ulteriormente nel prossimo periodo coinvolgendo gli stessi stati europei. Diventa, quindi, urgente, per chi crede nella possibilità di andare contro e oltre questo sistema socioeconomico, che ci sta portando alla distruzione dell’ambiente, alla guerra tra i popoli e al tracollo dell’economia e della società, riprendere un confronto per definire, almeno a grandi linee, un’alternativa proponibile.
Si è parlato negli ultimi tempi del manifesto di Ventotene: esso è proprio un esempio importante di come anche pochissime persone, costrette al confino e isolate dalla società, di fronte a eventi catastrofici e all’apparente mancanza di alternative ravvicinate, abbiano saputo immaginare lo stesso una strada credibile d’uscita dalla catastrofe europea degli anni ’40 del secolo scorso.
Riccardo Barbero
31/3/2025 https://volerelaluna.it






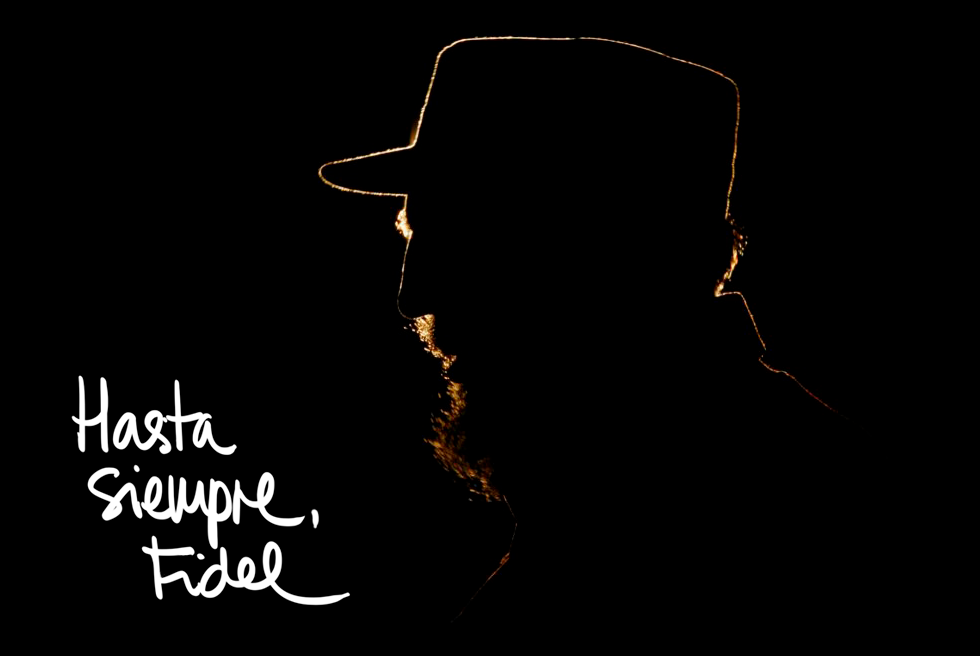
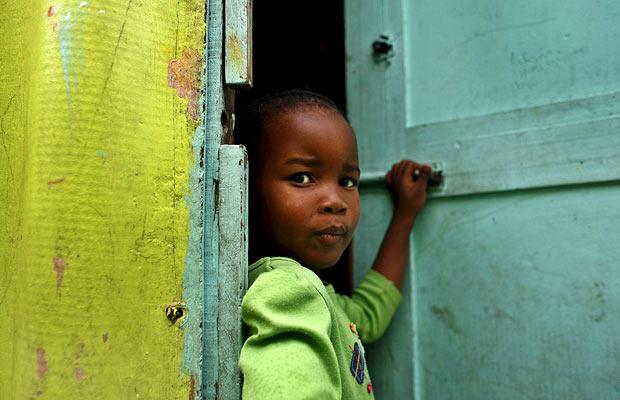


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!