Lingue e linguaggi della violenza, dal privato al pubblico
Non è molto comune riflettere sulla lingua che usiamo tutti i giorni. Di solito la pensiamo come un utile strumento, che ci permette di indicare le cose, riferire le nostre volontà e desideri, riferirci al passato o al futuro, nominare le persone – cose di questo tipo. Riflettiamo poco sul fatto che veniamo al mondo e la lingua e il linguaggio sono già lì; la lingua “madre” è un deposito di forme culturali che non abbiamo scelto, che troviamo già fatta e nella quale impariamo a esprimerci e a nominare il mondo che abbiamo intorno. Oltre a quello verbale, impariamo anche un linguaggio che non si serve solo delle parole, dette o scritte, ma anche di gesti, immagini, simboli. Possediamo molto poco della lingua e del linguaggio nel quale nasciamo e cresciamo, perché per l’uso quotidiano ne usiamo una piccola parte, negoziata con altrǝ e con la cultura intorno a noi; il nostro lavoro o i nostri studi ci portano a conoscere altre parti della lingua, altre forme di linguaggio, ma questo non fa che aumentare la consapevolezza di una potenzialità espressiva infinita delle lingue e dei linguaggi.
Ora domandiamoci: una lingua, un linguaggio, sono violenti oppure possono essere usati come violenza? E anche violento, violenza non sono parole da negoziare, da contrattare con altri e altre per arrivare a un significato condiviso? Oppure esso dovrebbe essere evidente di per sé, ed eventuali divergenze sono solo una mancanza di consapevolezza in qualcunǝ?
Forse pensare alla lingua e ai linguaggi non come strumenti, attrezzi per “fare” qualcosa ma come ambienti nei quali nasciamo, cresciamo per poi scoprire di trovarci più o meno a nostro agio, aiuterebbe a comprendere meglio anche il fenomeno della violenza, e particolarmente della violenza di genere. L’ambiente linguistico italiano è sessista? È cioè connotato dalla presenza di termini, espressioni e strutture linguistiche – della grammatica e dei “modi di dire” – discriminanti per genere? Senza dubbio sì.

C’è ancora, nei praticanti l’italiano, una chiara difficoltà a nominare correttamente ruoli e professioni dei soggetti diversi per genere dal maschile; proverbi, luoghi comuni, insulti sono depositi di cultura discriminante continuamente ripetuti come innocui intercalari; i media generalisti sono pieni di formule linguistiche e più in generale simboliche offensive verso i corpi femminili o non conformi al gusto imposto dal maschile tradizionale; l’arsenale retorico sessista è sempre pronto a giustificare o minimizzare i fenomeni di gender gap, soffitto (o precipizio) di cristallo, violenza domestica e di genere, e lo scarso finanziamento di tutte quelle istituzioni, pubbliche o private, nate con lo scopo di occuparsi di questi fenomeni e di chi ne è vittima.
Questo ambiente non può che essere riflesso e alimentato da una formazione pubblica scarsissima su questi argomenti. L’impreparazione dei corpi di polizia e forze armate che dovrebbero per prime saper affrontare situazioni di violenza, denunciate o meno, è ormai proverbiale. I e le giornalistǝ sembrano per la maggior parte non rendersi conto della necessità sociale di aggiornare il loro linguaggio a nuove soggettività, a diverse sensibilità.
In genere gli ordini professionali sembrano impermeabili a quelle esigenze di nominazione e indicazione corrette e volute con pieno diritto da una complessità nella quale pure lavorano quotidianamente. Tanto per fare due esempi, si continua a lasciare che vada in giro una concezione sbagliata tanto delle “quote rosa” quanto del “politically correct”: le prime sono definite come ingiustificate iniquità, invece di essere considerate un tentativo a posteriori per rimediare a una discriminazione già avvenuta; il secondo è preso per una formula censoria e impositiva quando invece è nato per liberare il linguaggio da tante formule dannose e insensibili a realtà non normate.
Inutile aggiungere che, in tutte queste circostanze, la formazione di politicǝ di professione, su questi argomenti, è quantomeno carente. A prescindere dal partito di appartenenza – come dimostra la prassi politica di altri paesi – un minimo di riguardo e rispetto, nel linguaggio e nei modi, su certe questioni, dovrebbe far parte della dotazione minima anche del e della più polemicǝ e “maleducatǝ” tra politicǝ e degli amministratorǝ nazionali e territoriali. Invece in Italia non solo la situazione non è questa, ma va di moda e da molti anni una sostanziale denigrazione della formazione politica, compresa quella riservata a linguaggi e argomenti che coinvolgono soggettività emergenti e corpi non conformi alla norma sociale. Questo è un vero motivo esclusivamente ideologico per trascurare, da destra come da sinistra, il minimo di accortezza politica – fosse anche solo per tattica, per un fine pragmatico – necessaria alla preparazione su un qualunque argomento di genere. Le poche personalità capaci di un linguaggio rispettoso proveniente da esperienze personali non possono che costituire, per ora, altro che felici eccezioni.
Conseguenza diretta di questa generale impreparazione è che il discorso politico è pesantemente inquinato, tossico: non si contano le strumentalizzazioni (soprattutto da destra) di argomenti come aborto, “famiglia naturale”, moralità e decoro; il benaltrismo ormai è assurto a metodo dialettico lecito; la particolarizzazione dei dibattiti, in modo da segregare le soggettività che rivendicano diritti come marginali, minoritarie, trascurabili, è continua; il perenne tono allarmistico riservato a “emergenze” del tutto inventate per distrarre dalla realtà delle situazioni, delle storie, delle vita in gioco (il gender!) è prassi abituale.
A queste ultime emergenze inventate possiamo tranquillamente unire quei “discorsi sui discorsi” altrettanto inquinati da ignoranza, e non solo politica: lo spettro della “censura del politically correct” sbandierata in ogni occasione ci si vuole sentire liberi di insultare, la minaccia inventata alla libertà di espressione, la sequenza infinita di “sono solo parole” e “volevo dire che” utili a chi intanto ha provocato danni proprio con le sue espressioni.
L’importanza di una formazione continua e popolare, che cominci dalla scuola per continuare anche nelle professioni, è chiaramente visibile nelle conseguenze della sua assenza: una lingua e un linguaggio discriminanti, istituzioni sorde o perse in pratiche inutili, scarsa rappresentanza politica per le soggettività non cisetero, media generalisti che nella maggior parte dei casi rinforzano tutto questo apparato oppressivo. Dal privato al pubblico, dal personale al sociale, non c’è alcuna separazione, alcun confine: l’ambiente culturale rimane lo stesso, e da quei linguaggi si imparano le diverse forme oppressive di cui poi si diventa strumenti. La violenza di genere è già lì, e non imparando a riconoscerla e a nominarla, continuiamo a riprodurla in ogni parola, in ogni gesto.
Lorenzo Gasparrini
1/3/2021 https://www.intersezionale.com

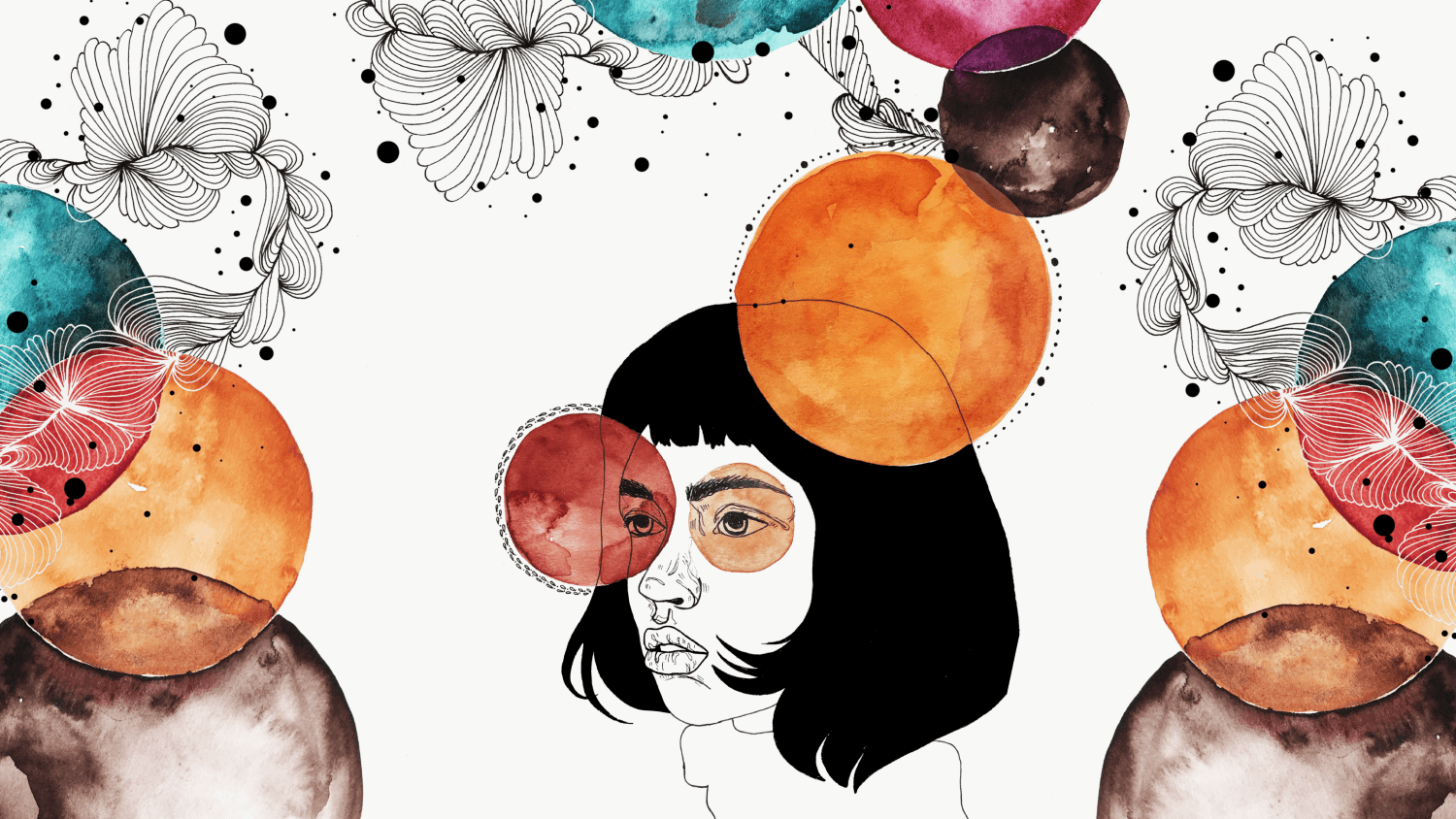








Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!