ll conflitto memoriale
Il dibattito su come decidiamo di ricordare il passato non è mai stato così attuale, e allo stesso tempo così frustrante, pieno di cortocircuiti storici
La storia, per definizione, non si cambia. Il modo in cui decidiamo di ricordarla, invece, evolve in base alle necessità del presente e contribuisce a formare il futuro. L’evoluzione della memoria collettiva a volte è talmente lenta da essere quasi impercettibile, scorre come un’acqua cheta sotto i ponti del dibattito pubblico. Altre volte, invece, accelera e si manifesta squarciando il presente come una pioggia di meteoriti. Negli ultimi mesi stiamo vivendo il secondo scenario. Il totale rovesciamento di senso a cui stiamo assistendo segnala un testacoda memoriale che schiaccia lo stomaco da quanto è vorticoso.
Fino a poco tempo fa, la battaglia memoriale sul significato della Resistenza, per esempio, seguiva uno schema collaudato. La destra italiana, che storicamente fatica a riconoscersi nell’eredità della Resistenza, usa le foibe come strumento storico per la propria battaglia politica, come scrissi nel 2020. Giorgia Meloni, come da copione, ha appena rivendicato il ruolo della destra nel rompere una presunta «congiura del silenzio» (riecheggiando l’ennesima fiction Rai sul tema) mentre annunciava la prossima apertura di un Museo delle Foibe a Roma. Altrettanto logico è vedere i militanti di estrema destra di Do.Ra celebrare le vittime delle foibe con rito fascista a Varese, mentre gli stendardi della Xa Flottiglia Mas (emblema della lotta antipartigiana nazifascista nel periodo 1943-45) sventolano alle celebrazioni delle foibe a Trieste. Questo fa parte del conflitto memoriale per come siamo stati abituati a conoscerlo negli ultimi decenni. Il vittimismo dei «vinti» suona familiare in modo desolante, come il ritornello di una canzone già sentita mille volte.
Negli ultimi tempi, invece, si stanno verificando alcune strumentalizzazioni della storia talmente orwelliane da confondere e lasciare spaesati, marcando un cambio di passo che era difficile (ma non impossibile) prevedere. La Germania era considerata come l’esempio da seguire per quanto riguarda la memorializzazione del passato – specialmente dell’Olocausto – e per avere adottato politiche memoriali che a livello culturale, architettonico, e storico, tracciavano la linea da seguire per ammettere le nostre colpe e imparare dai nostri errori in modo da non commetterli mai più (Nie wieder, si diceva). Invece, in nome della giustissima lotta all’antisemitismo il dibattito pubblico tedesco si sta avvitando su sé stesso con effetti opposti a quelli che ci si aspettava. In maniera straniante, proprio la memoria dell’Olocausto impedisce alla Germania di vedere e di ammettere cosa Israele sta facendo in Palestina, perchè se solo gli ebrei possono vantare il ruolo di vittime, non possiamo certo immaginarli come carnefici. Il risultato è che l’accusa di antisemitismo viene lanciata come una mannaia verso chiunque osi mettere in discussione lo sterminio operato da Benjamin Netanyahu e dallo Stato di Israele, inclusi cittadini israeliani critici del regime. Come è possibile che la Germania abbia tenuto viva la memoria dell’orrore nazista e la vergogna dell’antisemitismo per poi usare questa memoria come un’arma per escludere tutte le vittime che non siano gli ebrei? Il messaggio univerasle della memorizzazione dell’Olocausto è stato ridotto a un discorso asfittico, unicamente anti-antisemitico che trasuda islamofobia e in cui anche la destra radicale europea si ritrova a meraviglia, da Le Pen a Meloni fino all’AfD. Si può dire che abbiamo davvero imparato qualcosa dalla storia se la nostra memoria ci impedisce di vedere quando si ripete? La memoria dell’Olocausto viene ora usata, in un preoccupante cortocircuito storico, per ignorare se non giustificare gli orrori in Palestina, e le ginocchia tremano per il senso di vertigine.
Per rimanere alla cannibalizzazione della memoria della Seconda guerra mondiale, la Russia si è distinta negli ultimi anni per un incredibile ribaltamento di senso storico. Come se il paese di Putin avesse qualcosa a che fare con l’Unione Sovietica di Stalin, sta spingendo sul mito della Grande Guerra Patriottica per costruirsi un’improbabile crediblità antifascista e accusare tutti i propri nemici di essere dei «nazisti». Il fatto è che il regime di Putin non è un vero e proprio regime fascista, ma ne condivide moltissimi elementi: il nazionalismo esasperato, il razzismo, la mancanza di libertà di informazione e di espressione, i metodi autoritari di repressione del dissenso. Eppure, quando i neofascisti italiani si sono riuniti per l’annuale saluto ai camerati ad Acca Larentia, la Russia ha accusato l’Italia di favorire la rinascita del nazismo nella pretesa di preservare la «genuina memoria storica». In maniera ancora più grottesca e sconsiderata, questa posticcia identità «partigiana» e anti-nazista della Russia è stata usata come clava per giustificare l’invasione dell’Ucraina, descritta come covo di nazisti (nonostante il presidente ucraino Zelensky, ad esempio, sia ebreo).
In questa nebbia memoriale si mischiano le vittime e i carnefici, si prendono i lembi della storia tirandoli dalla propria parte finchè la tela si strappa. Cadiamo all’indietro, ognuno col proprio brandello in mano, senza capirci, persi. A forza di stabilire l’equazione «foibe = Auschwitz», a forza di discriminare i palestinesi in nome dell’anti-antisemitismo fino a censurare espressioni artistiche e libertà d’espressione in nome della ragion di Stato, a forza di travestire qualsiasi guerra come una caccia ai nazisti, abbiamo finito per creare dei nuovi mostri. A forza di tirarla in ballo per calcoli elettorali e/o semplicemente per vincere una baruffa social, abbiamo logorato la memoria della Seconda guerra mondiale al punto da deteriorare anche il simbolo più potente della nostra memoria collettiva, il richiamo ultimo contro l’odio: i campi di concentramento nazisti. Niente di strano, a questo punto, nel vedere Elon Musk prima fare sue teorie del complotto antisemitiche e poi andare in visita ad Auschwitz.
In questo contesto, come dimostrano le immagini del ministro Gennaro Sangiuliano, non ha nessun senso andare a chiedere ai nostri politici se si sentono antifascisti. Dimostrare che il governo Meloni è anti-antifascista o, addirittura, fascista, non serve a nulla. Non c’è pistola fumante che possa comprometterne il successo elettorale. Crediamo davvero che, se gli italiani avessero davanti agli occhi l’inconfutabile evidenza che il governo Meloni (o Fratelli d’Italia) può essere definito fascista, le persone cambierebbero idea in massa e darebbero improvvisamente il loro voto ad altre forze politiche? Siamo proprio sicuri che lo svelamento, l’abbassamento della maschera, non sarebbe semplicemente l’inizio di una nuova, e ancor più terrificante, fase politica?
Ecco allora che servono delle bussole in questo contesto memoriale ormai in cortocircuito, per tenere la rotta e non farci travolgere dal ribaltamento di senso. Due libri pubblicati di recente aiutano. Il primo è Le statue giuste, scritto da Tomaso Montanari per Laterza. L’altro è L’antifascismo e il suo contrario scritto da Luca Casarotti e pubblicato da Alegre. Proprio Casarotti si chiede: «Se nell’antifascismo si trova un po’ di tutto, tranne il fascismo, cosa mai andrà cercando fuori dall’antifascismo chi fa così tanta fatica a starci dentro?». Si può riassumere in questa domanda gran parte del dibattito memoriale italiano degli ultimi decenni, ma anche la sua fase attuale in cui la destra prova a tirare la Resistenza dalla sua parte, dopo averla depurata da ogni anti-fascismo e quindi di ogni senso.
L’antifascismo è diventato la principale spina nel fianco di questa stagione culturale: siccome è divisivo, e scaturisce da «una parte» di coloro che combatterono la guerra civile nel 1943/1945 (guardacaso, i «partigiani»), allora bisogna dismetterlo in nome dell’unità nazionale, della «memoria condivisa». Lavoro in Portogallo dove proprio quest’anno si celebrano i cinquant’anni dalla Rivoluzione dei garofani che pose fine a quasi mezzo secolo di regime autoritario di destra. Il 25 Aprile, data della rivoluzione del 1974, viene presentato dalla destra portoghese come divisivo, e date alternative vengono proposte come nuovi pilastri dell’identità nazionale dato che nell’antifascsismo alcuni proprio non si rivedono. Questa storia mi suona talmente familiare che mi provoca laceranti déjà-vu: continuo a voltarmi indietro per capire il domani.
Come dice Casarotti, «siccome c’è chi non è mai stato antifascista, o ha smesso di esserlo per meglio accomodarsi nelle seconde e nelle terze repubbliche, invece di chiedere conto a costoro si pretende che chi si ostina con l’antifascismo smetta di farlo, perché altrimenti ne avrebbe l’esclusiva». In questo spirito di rovesciamento della storia e inquinamento della memoria, si può capire allora come la Resistenza sia tornata, paradossalmente, a essere invocata anche dalla destra italiana. Un mito, scrive Casarotti, improvvisamente «buono anche a destra, come un sacrario dell’occidente a cui fare visita per rinfocolare lo spirito dello scontro di civiltà». Ma si tratta di una Resistenza come santino, come parola vuota, senza antifascismo come una Cola zero senza zucchero. Casarotti spiega come questo rovesciamento sia possibile. In pratica si confonde l’antifascismo storico, ovvero «l’insieme delle attività di opposizione al regime dittatoriale di Mussolini e volte al suo rovesciamento», con l’antifascismo come dottrina politica che si cristallizza nella Costituzione. Quesa confusione permette di terminare il ragionamento dicendo che non si può fare militanza antifascista oggi dato che il fascismo è stato sconfitto. Negare l’attualità dell’antifascismo o dire che non serve più a niente è una posizione intellettualmente antistorica che piega i simboli a una certa lettura della storia.
Ma il piano simbolico è tutt’altro secondario, come ricorda Montanari. Anzi, è al centro di un conflitto che arde proprio perché scatena un dibattito sul senso del passato per legittimare il presente e costruire il futuro. Nel suo libro sull’uso pubblico della storia nella forma di memorializzazione architettonica e odonomastica, sono molte le pagine che ruotano intorno alle vie, piazze, dipinti, statue e monumenti che portano nell’oggi la memoria del fascismo. Lanciandosi in una disamina storica dell’anti-antifascismo italiano da Craxi a oggi passando per Berlusconi, Violante, Ciampi e il giorno del ricordo, Montanari cita Filippo Focardi e la sua riflessione sul fatto che la Repubblica italiana di oggi sia stata fondata sulla necessità di superare la Costituzione. In altre parole, l’Italia di oggi, e il suo dibattito attuale, discendono da quella urticante necessità di liberarci dell’antifascismo che si manifestò con chiarezza negli anni Ottanta. Quarant’anni dopo possiamo dire che il cerchio si sia chiuso. Così, «un’Italia che non ha ancora un giorno che commemori le vittime del fascismo, né gli oltre 500.000 africani uccisi dal colonialismo italiano, celebra solennemente le circa 5.000 vittime delle foibe». E finalmente, con la Resistenza depurata dall’antifascismo, il 25 Aprile può finalmente diventare la «festa di tutti» (e, quindi, di nessuno).
Il dibattito su come decidiamo di ricordare il passato non è mai stato così attuale, e allo stesso tempo così frustrante, dato che non solo ci troviamo davanti tantissimi segni e simboli che sono sopravvissuti al fascismo, ma continuiamo ad aggiungerne di nuovi. Lasciare tutto com’è, semplicemente, non è possibile. Mettere mano a questo patrimonio tossico non è solo possibile, ma doveroso, dato che esprime un desiderio essenziale: «Vogliamo vivere in una Repubblica che riconosce e celebra il dissenso democratico, e non il consenso fascista; le vittime, e non i carnefici; i valori della Costituzione, e non quelli del colonialismo razzista. Che condanna, e non esalta, la violenza di Stato».
Ma come fare? Le soluzioni che Montanari elenca per quanto riguarda le statue, su una scala discendente di desiderabilità, sono: «La risemantizzazione in loco; la musealizzazione con segnalazione perenne del vuoto rimasto nello spazio pubblico; la musealizzazione con cancellazione della memoria nello spazio pubblico; la rimozione e conservazione in deposito; la distruzione». Ripartiamo da qui per immaginare un futuro dove i simboli da cui siamo circondati riflettano il messaggio che vogliamo fare nostro, e non il suo contrario. Ripartiamo, per esempio, da un giorno in cui ricordare le vittime del colonialismo italiano: «Quando questo giorno sarà entrato nel calendario civile nazionale italiano, e le scuole, le università, le fabbriche si fermeranno nel ricordare che ‘questo è stato’, e che l’abbiamo fatto noi italiani, allora potremo dire che si è fatto davvero un passo avanti nella riscrittura del tempo pubblico, l’altra dimensione dello spazio collettivo in cui viviamo, e che vogliamo profondamente cambiare».
Il ribaltamento di senso a cui stiamo assistendo vuole ritrarre come simbolo della cancel culture il movimento di opinione e protesta che chiede di riscrivere lo spazio pubblico e i suoi segni. La realtà è che questo movimento «non intende cancellare la storia, ma al contrario veglia perché la storia, tutta intera, non sia dimenticata, falsificata, strumentalizzata a favore del potere presente». Come si diceva all’inizio, la storia, per definizione, non si cambia. Di conseguenza, la vera posta in gioco non è il passato ma il futuro che vogliamo costruire. Per farlo, serve una bussola, e i libri, come sempre, aiutano a tenere la rotta.
Luca Manucci è un ricercatore. Fa parte del gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki. Si occupa di populismo, fascismo e memoria collettiva, temi su cui ha un blog.
14/2/2024 https://jacobinitalia.it/


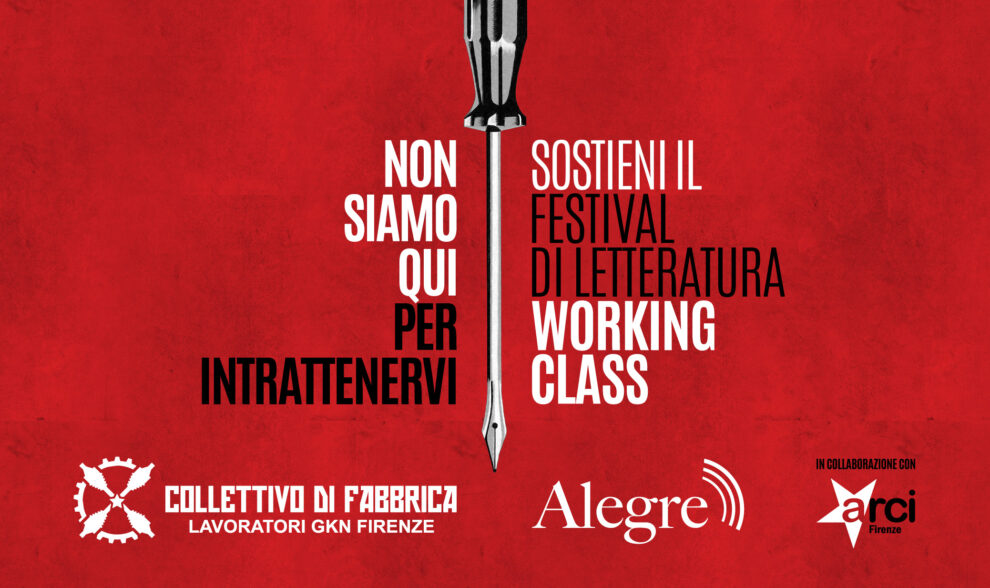








Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!