M. Sul pianeta terra in relazione alla cosa blu

Ho passato mesi ad aspettare prima la primavera poi l’estate, nella speranza, cieca, che la luce e il profumo delle stagioni mi restituissero il coraggio di riprendere a scrivere, di togliere la sordina ai pensieri scomodi, a quelli grigi, neri, persino quelli felici. E solo adesso, per davvero, comprendo l’antica abitudine di Tenco di scrivere canzoni soltanto quando era triste, perchè quando era felice, beh, usciva. Così, ecco il primo freddo pungente di Novembre (che, nel bene e nel male, è sempre stato il “mio” mese…) ecco la danza della fiamma nel camino, la pioggia fitta di questa mattina, a ricordarmi che è il momento; quell’inverno gelido, analitico ed esistenziale che aspettavo, finalmente, è arrivato. O che, forse, credevo di aspettare, mentre – silenziosamente- in realtà lo sceglievo. Ma se ciascuno, scegliendo per sé, sceglie per tutti gli uomini e, scegliendosi, afferma il valore della propria scelta, e se nessuno può scegliere il male, giacché ciò che scegliamo per noi è sempre il bene e non può essere diversamente che per gli altri, quello strano magone che avvertivo prima – angoscia della libertà allo stato pre-riflessivo – non ha più motivo di rimanere qui, aggrappato al torace: riesco già a sentirlo abbandonare i muscoli, liberare i polmoni dallo sforzo di pompare un’aria greve, e scivolare via del tutto, nel sonno, che è il miglior antidoto contro il tempo che conosca.
Davvero sto scegliendo di scrivere rinunciando al mio rito di fine giornata? Nel dubbio meglio accendere il tubo. Che cosa ho paura di dire, di dirmi? Conosco la sana arrendevolezza nel convincermi a pronunciare o a scrivere ciò che so e che mi spaventa, e che dunque ho paura di ammettere; conosco l’animalesco meccanismo di difesa che mi spinge a scacciare i pensieri più disincantati senza affrontarli, come se – nascondendoli in un remoto angolino della mia mente – potessi privarli del loro contenuto di verità. Ma come cantano i My Bloody Valentine: “no more sorry”. Niente più scuse. La vita, proprio come il Tempo, sfugge e si diverte a sfiorarmi le dita impedendomi di afferrarla: ed io, goffa e buffa, correndo mi affretto a cercare di raggiungerla, fino a che, nell’affanno, mi limito a seguirla a passo svelto per le strade più incerte e imprevedibili. Lascio che mi guidi e, nel mentre delle brevi soste che mi concedo, tutto lo sconforto e l’angoscia di non riuscire ad afferrarla mi assale e mi lascia lì, piccola e immobile, incastonata nell’ambra della mia aprassia. E’ tardi. E’ e sarà sempre troppo tardi. (Ha ragione Dottor Manhattan…) Eppure so di non dovere arrendermi a questa sensazione di irrimediabile immobilità, di rinuncia di senso. Il medesimo fatto che nulla, in fondo, abbia un senso è il corretto presupposto per la libertà di costruirne uno proprio, di inventarlo. L’altrettanto casuale e insensato accidente dell’intelligenza costituisce il mezzo di questa possibilità. A sua volta, tuttavia, tale accidente comporta una profonda responsabilità. E di fatti, la Storia umana da sempre procede per errori. Tutto ciò che appartiene al possibile è realizzabile. E il pensabile rientra nell’ambito del possibile. Ma cosa pensare? E sulla base di quali riferimenti se bisogna ricostruirli? Quale voce ascoltare? Perchè? Perchè così, non va. Cieco chi non lo vede, stolto chi non lo pensa. Dunque, che fare? Demolire le radici del negativo, e lasciare poco altro… Decostruire per ri-costruire. Altrimenti non avrebbe senso – e di fatti non ne ha. Ma, ahinoi, ne abbiamo bisogno. E’ il prezzo, senza sconti, del dono gratuito ma anaffettivo della Natura: lasciarci liberi di giocare col mondo, concederci il privilegio di scegliere un destino e morire con lui. E se l’esistenza precede l’essenza, essa precede Anche il politico, l’economico e tutto ciò che è oramai avulso dal disincanto dei sorrisi autentici ma non beffardi; ecco quale voce ascoltare.
E’ il terzo giorno di primavera ma qui, nella mia testa, è ancora inverno. Un inverno diverso, e di gran lunga peggiore di quello che mi ero scelta, che mi vede anzi incastrata tra le macerie delle certezze che continuano a crollare inesorabili, tutte, al passo dell’analisi esistenziale. Era troppo prepotente, quasi tracotante, l’intento di contraddire l’insegnamento di uno dei Maestri, ed eccomi qua, che sopravvivo a stento ad una guerra che ho dichiarato io stessa. In realtà, insieme a Friedrich, anche Moore e i My bloody Valentine continuano ad avere ragione, e a guardarmi – rispettivamente dalla libreria e dalla scrivania – fissi e severi. Ed io, che non ho nulla, voglio solo dormire, morire, dormire e morire, e svegliarmi che sono fioriti tutti i ciliegi.
Come al solito non so da dove cominciare. Quando si tratta di riprendere questo esercizio di autoterapia, forse l’unico (e l’ultimo) che ho trattenuto, è sempre così. Mi sembra di avvertire il fantasma del medesimo disagio di quando, a circa dieci anni, costretta dalle norme sociali di questa merda di paese, mi accingevo alla prima confessione uscendone in lacrime. In questo caso, però, non è prevista assoluzione, e si darebbe il caso che abbia già pianto – abbondantemente ed inutilmente. Farlo ancora non servirà, ma scrivere sì, e non per confessarmi, nonostante esiti ogni volta che mi ritrovo a volerlo fare, come se dovessi. E in effetti devo, ma per me. Chi avrebbe mai pensato che sarebbe stato così difficile volersi bene? Non c’è forza né coraggio maggiore, a questo mondo, che ritrovarsi soli con sé stessi a raccogliere i cocci di una scommessa perduta, di un progetto fallito, un sogno svanito, una certezza distrutta. Quanta volontà, quanta tenacia nel rialzarsi, chiudere i cieli e ricominciare per la propria strada… Sarà che nell’ultimo periodo mi è capitato di doverlo fare continuamente – pertanto sono stanca – ma questa, credo sia la volta definitiva, nonché la più dolorosa. Cosa dico, lo è. Senza ombra di dubbio. L’ho sempre saputo.
Dovrei chiedermi scusa un milione di volte, ma per ottenere quale perdono? Il mio?, e di nuovo accettare i miei mostri, cedere al compromesso di conviverci, di amarli, addirittura? Se lo canta anche Morrisey, è forse giunto il momento per me di combatterli dentro e fuori, di imboccare il sentiero e decapitare i tulipani, recidere le loro radici dalla mia testa. Ma nel momento (che dura oramai da anni..?) in cui, realmente, non riconosco alcuna forma coerente di purificazione, in che modo redimermi? Dev’essere la Luna che, piena e gialla, proprio ora viene a rischiarare la logica del mio sentiero, a rivelarne calcoli e termini e passaggi, a ricordarmi che la matematica – come la vita – contempla l’impossibilità degli esiti, e sembra che anch’io, sospesa nel suo iperuranio stellato, riesca a vedermi dall’alto della sua prospettiva inconfutabile: sono lì, schiena ricurva e gambe penzoloni, sul cornicione all’ottavo piano del palazzo dell’assurdo, seduta sul punto cieco della rivolta, che ripeto al freddo e al vuoto “aprée moi le deluge”; sono qui, che mi vedo scegliere,il male e non riesco a frenare l’adrenalinico formicolio di questo strano orgoglio che sale e cresce e si fa beffa della mia morale.
Dovrei chiedermi scusa, ancora, per essermi ritrovata questa mattina davanti al camino a versare le ennesime e medesime lacrime di un anno fa; per “l’insolente promessa sciocca vacua solenne di bastare a sé” che non riesco a mantenere; per aver barattato ancora una volta il mio sesso per una manciata di tenerezze; per essermi svegliata della stessa fragilità dello stelo dei semi germogliati per sbaglio in inverno; per la banalità di illudermi di fare la differenza, di cambiare le carte in tavola alla comparsa del fantasma della stima che ho di me, e che subito si dilegua se ripenso allo scorso pomeriggio, alla meccanicità dei gesti, compresi quelli inaspettati, ai miei modi imbarazzati ed imbranati, ai silenzi rimasti sospesi tra la mistificazione di una convenzione e l’altra. Dovrei chiedermi scusa per i baci recitati e quelli vissuti, e per aver pianto di nuovo, stasera, accanto al camino, davanti ad una verità che probabilmente conoscevo già, ma soprattutto per aver impacchettato metà della mia, stupida, delle solite ermetiche metafore, stupide, di tutta risposta. Dovrei chiedermi scusa per aver sottovalutato la sua intelligenza grazie alla quale forse avrà capito già, e per il silenzio che ovviamente ne segue e che mi sarei dunque dovuta aspettare; e perché non vedo l’ora che sia domani per mischiare l’amarezza alla vodka liscia e dimenticare o ridere del prezzo della logica che pago col sarcasmo di una poesia: “mi svolazzano i capelli dal finestrino; son fumo, cozze fuori stagione”.
Non è vero che non farò nulla, “come sempre”. Aggiungerò ancora un po’ di calce e mattoncini color terra cotta al muro che ho dentro. Lo contemplerò recitando sarcastica e isterica una preghiera che conosco e che ripete “non importa, non importa”. Mi tatuerò in testa una poesia della Plath, che è come pregare di nuovo, e ossequiare al mio personalissimo rito in celebrazione di una nuova piccola fine, una nuova piccola morte. Eppure non sa soddisfare la mia devozione; quella delle quattro e cinque del mattino a scavarsi l’anima col cacciavite (pur sapendo di non averne alcuna) per trovare le parole – esercitare la loro forza – e dare un nome al vuoto insondabile, quello attorno al quale è costruito il muro, e riempirlo di un volto di cui non aver più paura, né sensazione.
Sono le due e quarantacinque di un lunedì qualsiasi di un inverno, il mio, che festeggia il suo primo anno di aridità. E’ dolce e silente nella maniera solenne in cui alcune piccole cattedrali sconsacrate sfoggiano le proprie rovine alla scenografia perfetta dei cieli bianchi d’europa. Ha il sapore di un’abitudine nuova, ma in qualche modo prevista: bocca asciutta e amara reduce di calici e calici di rancore liquido. Ora sono le quattro e quindici, di un altro lunedì, dello stesso inverno, stessa aridità. Nessuna volontà e capacità di dormire; solo questo mozzicone inutile, che alle quattro e quindici brucia e sporca le pareti azzurre della camera e dei miei polmoni.
C’è chi dice si debba aspettare, senza alcuna fretta e con costante pazienza, il momento adatto per rompere il silenzio. Il mio è lungo di mesi. Troppi, a giudicare dalla violenza degli istantanei impulsi che, pure se rari, con impeto improvviso talvolta bussano alla mente trovandomi sistematicamente impreparata; e il mio silenzio non è che la paralisi che sopraggiunge all’ennesimo dei momenti fuggiti. Per questo lo assecondo, lascio che taccia, senza neppure la voglia di cercare parole che so non troverei. Curiosamente, è lo stesso per la vita non scritta. Questa grande “calma” è lunga di mesi. Pochi, a giudicare da quel che ricordo. Dev’esserci stato in effetti un momento, pure se abbastanza recente e non realmente significativo o determinante, in cui ho deciso di abbandonare quell’inutile fatica di cercare di essere felice. E da allora non c’è stata mattina o pomeriggio d’inverno senza che ciascun singhiozzo soffocasse nel cuscino o nella cenere. Dunque questa grande calma mi accompagna, e io lascio che mi guidi, quieta e sola, nella convinzione che sia comunque meglio di qualsiasi ulteriore via illusoria. Ma nel frattempo è vero che attendo si trasformi in qualcos’altro: quella imperturbabilità, magari, in cui consiste l’unica forma di felicità possibile; l’assenza “almeno” di passioni. E se pure mi sembra di farne a volte esperienza, dev’essere perché mi inganno di pensare di sperimentarla, dal momento che non potrebbe spiegarsi altrimenti il motivo per cui a questa (presunta) non segua necessariamente quella pure di dolore – della quale esperienza, invece, sono sì sicura. Allora spero che arrivi, e non solo per assaporare finalmente una serenità nuova e vera e lontana dall’adrenalina dei rancori; ma soprattutto, per liberarmi dall’ultimo rigurgito del passato, e restituirmi un futuro per il quale non dover pagare.
Martina e la Cosa Blu.
L’errore è proprio questo. Ritrovarsi alle due e mezza di notte, dopo un’intera giornata di lavoro, a riesumare dalle pieghe della memoria a breve termine tutti quei pensieri perfettamente lucidi – quelli che dicono “scrivimi!” – ignorando il loro silenzio così come li ignoro alle volte in cui affiorano senza permesso, noncuranti degli stati d’animo, del tempo costretto dalle necessità, del flusso veloce che mai la mia penna riesce ad inseguire. Eppure me lo devo, questo sforzo. Io non sono sul pianeta Trillafon. (Non più, almeno…) Io sono qui sulla Terra. E se penso di esserci capitata per caso, come tutti, ma di averla ormai scelta, mi viene da ridere – sebbene senta che mi si bagnano gli occhi. Io sono qui, sulla Terra, e la vedo per quella che è, malgrado gli Altri – quelli che sanno – mi vedano vederla distorta dalla mia lente blu. Potrei istupidirmi a spiegare come, di fatto, la mia prima e sostanziale divergenza con il mondo (e/con gli Altri) consista nell’evidenza per la quale il mondo in realtà appaia variamente colorato ma sia essenzialmente blu – e pertanto come sia la lente variopinta del mondo a far sì che gli Altri non lo vedano blu. Ma è noto come vadano a finire le cose per chi indica la luna quando gli Altri guardano il dito. Inoltre non è questo il caso. Qui si tratta di raccontare il mondo per come lo sento, dunque per come effettivamente è. E qui viene il punto, il momento, in cui ammetto di non biasimare quelli che sul pianeta Trillafon sono convinti a rimanerci perchè il fatto è che non è granché accogliente la Terra. In particolar modo quando si è stati altrove pure rispetto al pianeta Trillafon, nel momento in cui si torna sulla Terra, inizia la Nausea: una Nausea terribile, permanente a tal punto che ci si abitua presto al sapore e lo si confonde con quello della propria bocca e si finisce per sentire come un affanno totale che dal petto abbraccia lo sterno e poi tutto il corpo, articolazione dopo articolazione, fino ai capelli e alle unghia dei piedi. Poco fa, poco prima che chiudessi il tubo, devo aver ingoiato un paio di lacrime ed è stato davvero strano perché ricordavo un sapore del tutto diverso, salato ma puro, come quello dell’acqua dei fiumiciattoli o dei piccoli laghi in prossimità del mare, invece di questo gusto amaro che all’improvviso ho sentito entrarmi in bocca, come quando dopo aver sniffato bamba dal naso scende alla gola e finalmente la senti e quasi ti disgusta. E’ lì e la riconosci. Quello è il momento in cui sale, la Nausea. C’era già prima: sostava borbottante sulla bocca dello stomaco già lo scorso venerdì sera; si è nascosta nella tasca del pigiama il sabato seguente; si è annidata nella sporcizia degli angoli sul fondo del secchio d’acqua sporca dove oggi inzuppavo e sciacquavo lo straccio; poi stasera è venuta fuori senza travestimento né invito. La sentivo brontolare di sottofondo dal centro della cassa toracica già alla prima birra poi dev’essermi come uscita dall’orecchio o da una narice ed entrata negli occhi ed ecco appiattiti tutti i colori, ecco il mondo spogliato delle sue sembianze, nudo, ed io con lui. Nuda. La Nausea è per me forse il freddo misto al profondo imbarazzo di sentirsi e sapersi nudi. E, come e più di un anno fa “è quasi il primo mese di primavera, ma qui, nella mia testa, è ancora inverno”.
di Martina Patriarca




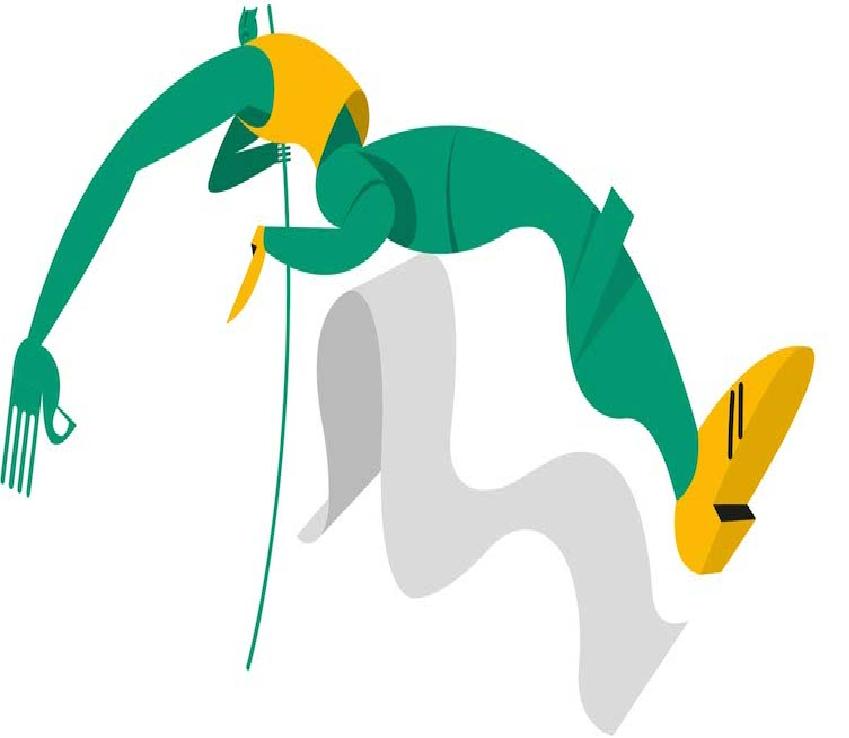





Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!