Maschilità che uccide
Quando si pensa al contributo che l’approccio teorico di genere può portare alla comprensione del fenomeno dell’omicidio, il pensiero corre veloce a quegli episodi che nel dibattito pubblico vengono definiti, non sempre propriamente, femminicidi. Si tratta – come ci insegna la sociologa femminista Diana H. Russel – di quelle uccisioni di donne perpetrate da uomini prodotte dalle disuguaglianze tra i generi e nelle relazioni che, tra questi, sono presenti nella società.
Volendo provare a “spacchettare” il concetto parliamo, dunque, di quegli episodi fortemente caratterizzati da una componente misogina o di possesso, da un senso di affermazione e legittimazione del potere e della superiorità maschile e dei presunti diritti che ne derivano, o da una pulsione sessuale – talvolta sadica – nei confronti delle donne.
Il contributo dell’approccio di genere in termini di messa a punto del concetto di femminicidio è indubbiamente di grande rilievo, per ragioni sia analitiche che politiche: come sostenuto dalla stessa Russel, “non ci si può mobilitare contro qualcosa che non ha un nome”.

Tuttavia, come spiego nel mio ultimo libro Interazioni fatali. Uomini e donne che uccidono in Italia (Il Mulino, 2024), il genere costituisce anche una lente analitica ben più ampia ed estremamente utile nello studio del fenomeno dell’omicidio più in generale.
Già diverso tempo fa, del resto, la criminologia femminista ha vigorosamente sostenuto che il contributo conoscitivo di questa prospettiva teorica è di particolare rilievo non solo per comprendere al meglio i diversi delitti perpetrati dagli uomini contro le donne – su cui si concentrano molti lavori sviluppati con questo approccio –, ma la criminalità più generalmente intesa; dunque, anche quella in cui le vittime sono gli uomini, o in cui le donne commettono reati. Lo stesso si può dire passando dall’approccio femminista a quello più ampio di genere, e dalla criminalità generalmente intesa alla specifica osservazione dell’omicidio.
Due semplici esempi possono illustrare quanto appena detto. Consideriamo, in primo luogo, gli omicidi per futili motivi: quelli consumati tra persone sconosciute o quasi – praticamente sempre uomini –, in cui la violenza letale esplode feroce e del tutto improvvisa per ragioni assolutamente triviali: una scarpa sporcata durante una notte di movida – è avvenuto in qualche episodio di cronaca molto trattato dai media –, uno sguardo di troppo, un urto fortuito, un parcheggio conteso, un apprezzamento non gradito a una donna, l’ordine in cui si viene serviti in un bar.
Qual è il filo rosso che lega questi diversi eventi catalizzatori? Una concezione fortemente virilista della maschilità, che prevede una sfrenata esaltazione di alcune sue caratteristiche stereotipate: coraggio, rispetto, onore, reputazione, difesa del gruppo di riferimento, senso di possesso e dovere di protezione nei confronti delle donne che ne fanno parte.
Va anche considerato che gli uomini utilizzano le risorse materiali e simboliche di cui dispongono per manifestare nelle interazioni quotidiane la loro appartenenza al genere maschile, sottolineando marcatamente la distanza da tutto ciò che è femminile.
Il ricorso alla violenza – e, quindi, anche all’omicidio – per risolvere una disputa tra uomini per banalissimi motivi non è altro che uno dei possibili modi per farlo, fortunatamente rarissimo: si tratta di una strategia generalmente impiegata quando non si dispone di altre “fonti” di maschilità (ad esempio, rispetto al modello di maschilità egemone nelle società occidentali contemporanee, autorità, indipendenza, successo economico), o in contesti in cui la valutazione di adeguatezza della maschilità risulta particolarmente severa, e quindi le altre “fonti” non risultano sufficienti. Parliamo di un modello di maschilità largamente definito, rafforzato e riprodotto dalla cultura patriarcale.
Passiamo ora a considerare il secondo esempio di omicidio in cui la prospettiva di genere risulta essere utile: i casi in cui sono le donne a uccidere, e non come reazione a una pregressa violenza maschile nei loro confronti. In quest’ultima circostanza, si registrerebbero infatti molte delle dinamiche proprie di tanti casi di femminicidio. Risultano di particolare interesse i casi che vedono come vittime i partner intimi e le figlie e i figli, i due bersagli privilegiati della (rarissima) violenza letale femminile.
Secondo la studiosa Vickie Jensen, per comprendere questi crimini è necessario partire dalle disuguaglianze economiche, politiche e sociali che le donne affrontano quotidianamente. Queste condizioni di svantaggio vanno a ridurre le opportunità, il potere e lo status di cui molte donne dispongono. Il risultato è far sentire alcune di loro economicamente e socialmente intrappolate, in primo luogo all’interno del nucleo domestico.
Le gravose aspettative sociali legate al ruolo di moglie e soprattutto di madre – proprie del modello culturale patriarcale – rendono la gestione quotidiana della famiglia e l’educazione dei figli un ulteriore carico su questo senso di intrappolamento e isolamento. Si tratta, tra l’altro, di compiti svolti senza alcuna remunerazione e che non beneficiano di un particolare riconoscimento sociale, essendo dati ampiamente per scontati.
Tante mogli e madri che hanno la principale, se non totale, responsabilità dei figli e delle figlie devono poi accontentarsi – nel caso siano impiegate nel mercato del lavoro – di occupazioni poco o per nulla prestigiose, malpagate e prive di grandi opportunità di carriera. In queste situazioni di scarse opzioni sociali e di vita, potenzialmente caratterizzate da frustrazione, stress e rabbia, le conseguenze possono ricadere – nei casi più estremi, e per fortuna davvero rari – sul partner o sui figli e le figlie, in quanto cause e simboli dell’oppressione subita dalle donne immediatamente percepibili e spazialmente più vicini. Alcuni degli omicidi di questo tipo commessi da donne possono dunque essere letti utilizzando uno sguardo di genere.
L’approccio di genere, infine, si rivela prezioso anche a livello di classificazione del fenomeno dell’omicidio, consentendo di tratteggiare quattro tipi di delitti tra loro ben distinti: uomini che uccidono uomini, uomini che uccidono donne, donne che uccidono uomini, donne che uccidono donne. Le caratteristiche intra-tipo sono in parte simili, e quelle infra-tipo abbastanza eterogenee, da inquadrare per dare conto delle molteplici situazioni in cui un omicidio può consumarsi. Uomini e donne infatti uccidono, e vengono uccisi, in circostanze e per ragioni molto diverse.
Le donne, come già detto, si indirizzano in primo luogo contro le due figure a cui la struttura sociale di genere le lega maggiormente: i partner, in quanto mogli o compagne, i figli e le figlie in quanto madri. Gli uomini, invece, hanno una platea di potenziali vittime decisamente più variegata, anche in virtù della loro presenza tanto nelle attività lecite della vita quotidiana, quanto in quelle illecite.
Le donne, inoltre, sono principalmente uccise da partner o ex, con un ulteriore richiamo, quindi, al ruolo di mogli o compagne. Gli uomini, invece, da conoscenti e sconosciuti. Se si osservasse l’uguaglianza di genere solo attraverso la lente analitica dell’omicidio, dunque, il nostro paese risulterebbe ancor più conservatore di quanto già non sia nei fatti, con le donne fortemente schiacciate sui loro ruoli tradizionali.
Riferimenti
R. W. Connell, Masculinities, Cambridge: Polity Press, 1995.
C. Corradi, C. Marcuello-Servós, S. Boira, S. Weil, Theories of Femicide and their Significance for Social Research, Current Sociology, 64(7), 975–995, 2016.
K. Daly, M. Chesney-Lind, Feminism and Criminology, Justice Quarterly, 5(4), 497–538, 1988.
V. Jensen, Why Women Kill: Homicide and Gender Equality, London: Lynne Reiner, 2001.
M. S. Kimmel (a cura di), Changing Men: New Directions in Research on Men and Masculinity, Newbury Park: Sage Publications, 1987.
J. W. Messerschmidt, Masculinities and Crime: Critique and Reconceptualization of Theory, Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1993.
Per approfondire
Lorenzo Todesco
Interazioni fatali. Uomini e donne che uccidono in Italia, Il Mulino, 2024.
28/1/2025 http://www.ingenere.it
Imamgine: Credits Unsplash/Samy METHNANI





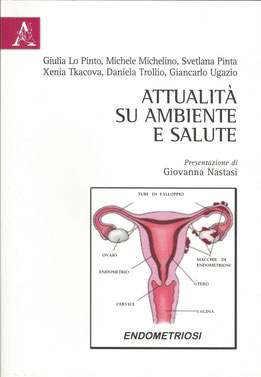




Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!