Mesarvot: noi rifiutiamo! Intervista agli attivisti israeliani contro l’occupazione
Mesarvot, una parola ebraica che significa “noi rifiutiamo”, è anche il nome di una rete di attivisti israeliani contro l’occupazione della Palestina. Il loro scopo è quello di sostenere gli obiettori di coscienza, i refusenikim (sing. refusenik), di fronte all’obbligatorietà della leva militare, facendo del rifiuto non una semplice scelta individuale o privata, ma un vero e proprio atto politico per contribuire alla fine dell’occupazione e dell’oppressione del popolo palestinese
Fin dalla sua fondazione, lo Stato d’Israele ha fatto dell’esercito il suo principale strumento di sopravvivenza. Tutti i cittadini e tutte le cittadine hanno l’obbligo di prestare servizio militare. Servire nell’esercito è un passaggio indispensabile nella vita di ogni persona israeliana, ed è anche il percorso necessario per essere considerati meritevoli e conformi sia alla società sia al mondo del lavoro. Inoltre, in Israele quello del soldato è considerato uno status perenne. Oltre alla durata del servizio militare, che varia in funzione dell’età e del sesso, chi ha già adempiuto al proprio compito continua a essere un riservistae, quindi, richiamato a combattere [Questo meccanismo, detto “miluim”, prevede che una persona possa essere richiamata entro una certa età, e che periodicamente, compia delle esercitazioni.]
Dal 1967 milioni di palestinesi vivono sotto l’occupazione militare e molte sono le forme di sofferenza e ingiustizia causate dall’esercito israeliano: dalla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza alle numerose restrizioni e confische di terre imposte ai palestinesi in Cisgiordania. L’esercito, in quanto esecutore materiale di queste politiche di occupazione, dipende dalla coscrizione obbligatoria di molte persone chiamate a servire nei suoi ranghi. Di fronte a questa rigida imposizione e alle sue tragiche conseguenze, molti uomini e donne scelgono di rifiutare il servizio militare per non essere complici dell’occupazione e non obbedire a ordini di natura repressiva e aggressiva contro civili: un rifiuto pagato con l’umiliazione e il carcere. Alcuni obiettori fanno riferimento a diversi progetti di sostegno e solidarietà, che negli anni sono stati oggetto di repressione e discriminazioni. Uno di questi gruppi di attiviste e attivisti si è riunito in Mesarvot, un collettivo che ha tra i suoi obiettivi principali quello di opporsi pubblicamente a questo sistema di reclutamento e all’uso criminale dell’apparato militare israeliano in Palestina.
Abbiamo avuto modo di parlare con degli attivisti del collettivo Mesarvot, essi stessi refusenikim, per conoscere meglio il loro progetto, ma soprattutto per comprendere quali siano le conseguenze politiche, economiche e sociali del rifiuto del servizio di leva in Israele. Yeheli, il coordinatore del progetto, ci parla in generale della figura del refusenik e delle attività del loro collettivo.
«I refusenikim esistono da sempre, da quando nel 1948 venne fondato l’esercito regolare dello Stato d’Israele. Questo fenomeno crebbe molto dopo la Nakba e ancora di più durante la guerra in Libano e durante la seconda Intifada. Il progetto Mesarvot, invece, nasce alla fine del 2015 ed è un gruppo molto eterogeneo: non proveniamo tutti dallo stesso background sociale o ideologico e rispondiamo a diversi indirizzi politici. Sicuramente ciò che ci unisce è un’ideale pacifista che si concretizza nella scelta di non prendere parte al processo d’oppressione dei palestinesi. Rivendichiamo il fatto che il nostro rifiuto sia una precisa scelta politica: siamo contro l’occupazione e se c’è qualcuno che sceglie di non servire nell’esercito, noi lo appoggiamo. Non chiamiamo refusenikim solo coloro che finiscono in prigione per aver respinto la chiamata alle armi, ma anche coloro che sono stati dispensati dal servizio dopo essere riusciti a dimostrare una qualche disabilità mentale che gli garantisse un’esenzione ufficiale. Infatti, è possibile essere esentati principalmente per ragioni di salute mentale, anche perché è il modo più facile da parte dell’apparato militare per screditare l’atto del rifiuto, negandone il valore politico. Il nostro compito immediato è quello di sostenere e supportare tutti gli obiettori condannati e imprigionati, dando loro assistenza legale anche in caso di ricorsi. L’obiettivo principale è quello di garantire una costante copertura mediatica sulle discriminazioni e le accuse che si perpetrano nei confronti dei refusenikim, oltre che sugli abusi dell’esercito, organizzando manifestazioni e campagne di solidarietà».
L’attivismo di Mesarvot tocca profondamente i nervi fragili della società, poiché il servizio militare è ancora visto come un aspetto fondante dell’identità israeliana. Di conseguenza, l’obiezione e il rifiuto di servire nell’esercito sono atti disapprovati e criminalizzati. Rifiutare il servizio militare è una scelta che condiziona tutta la vita sociale e lavorativa di una persona.
Tuttavia, se da un lato il rifiuto rappresenta una grande sfida che rischia di essere vissuta in solitaria da queste persone nel momento del processo e della prigionia, dall’altro lato sembra essere uno strumento potente che permette di sollevare a gran voce la resistenza all’occupazione. I tentativi del Governo di disinnescare questo fenomeno d’opposizione sono molteplici e variano a seconda della classe sociale o dell’etnia di appartenenza del refusenikim.

Continua Yeheli: «In generale, le principali conseguenze sono di tipo morale e sociale, che vanno anche a toccare il campo lavorativo. Se sei figlio di un cittadino di “serie B” la tua vita è segnata per sempre dal rifiuto a servire nell’esercito. Per chi proviene dalla classe media, rifiutare il servizio militare equivale a perdere diverse opportunità lavorative o d’istruzione, come borse di studio universitarie. Ad esempio, ci sono molte persone che, dopo aver preso servizio nel reparto di intelligence, riescono poi ad avere molte opportunità lavorative soprattutto nel mondo dell’High Tech. Per quanto riguarda invece le classi più deboli della società israeliana, come etiopi, russi e mizrahim (i discendenti da ebrei del Medio Oriente, del Nord Africa, dell’Asia centrale e di parti del Caucaso) rifiutarsi è molto più rischioso e compromettente. Le persone tra i nostri militanti che hanno la possibilità di rendere pubblica e politica la loro scelta sono quelli che provengono da ambienti finanziariamente più solidi. Quindi essere un refusenik dichiarato è a sua volta un privilegio legato alla classe sociale: esistono molte persone che non possono dire no perché appartengono a gruppi subalterni. Spesso con gli israeliani provenienti da fasce economiche più deboli, che non potrebbero permettersi per questioni economiche di servire nell’esercito, viene usato come strumento persuasivo “il capitale simbolico”, legando, quindi, il servizio militare a una questione d’onore e di difesa della patria».
Questa ricattabilità economica e sociale, stretta a doppio nodo alla dimensione militare dello Stato d’Israele, rimarca anche quel passaggio storico da una società in cui i principi ideologici del sionismo erano il principale propulsore di un’identità culturale, storica e religiosa, a una società ultraliberista, i cui effetti continuano a riflettersi nell’apparato militare. «Il sionismo è stato chiaramente scavalcato dal liberismo e se prima le figure di alto profilo militare provenivano dai kibutzim o i moshavim ed erano hilonim (laici), adesso questi ruoli vengono ricoperti da sionisti religiosi o coloni».
Vi è, inoltre, una differenza di trattamento a seconda dello status accordato al refusenikim: l’obiettore di coscienza e considerato diversamente rispetto a colui che ha ottenuto una esenzione. Mentre chi non viene riconosciuto né in quanto obiettore, né in quanto destinatario di una esenzione (per lo più medica) è il refusenik per antonomasia, “il traditore”, disprezzabile dalla società e condannabile al carcere. Di fatto, il rifiuto di arruolarsi senza l’approvazione dell’esercito è un reato punibile.
«Se si riesce a ottenere un’esenzione medica, che, in mancanza di patologie accertate può essere solo di carattere mentale, spesso grazie all’aiuto di un medico bendisposto a certificare tale disabilità, allora è possibile evitare il servizio militare senza incorrere in gravose conseguenze. Se invece non ci si riesce ci si può dichiarare obiettori di coscienza. A quel punto si verrà giudicati da una commissione esaminatrice del Centro di reclutamento, chiamata a valutare la possibilità di attribuire lo status di obiettore. Il problema è che la scelta della commissione è fortemente arbitraria e discrezionale, poiché non esistono delle linee guida ufficiali per determinare chi possa essere considerato obiettore di coscienza e in base a quale standard. Il risultato è che difficilmente si verrà riconosciuti in quanto obiettori di coscienza. Nel caso in cui non si ottenga questo riconoscimento, si viene convocati nuovamente da una commissione di fronte alla quale si potrà dichiarare ulteriormente il proprio rifiuto di servire l’esercito. Da quel momento cominceranno una serie di periodi di carcerazione: si comincia con un periodo che va dai 10 ai 21 giorni. Trascorso questo primo periodo, si viene convocati un’altra volta al Centro di reclutamento dove, se ci si rifiuta nuovamente di arruolarsi, si viene incarcerati per diversi mesi, finché l’esercito non deciderà di congedarci. Il tempo minimo prima della fine della pena è di 80 giorni.”
Sembrerebbe una strategia efficace, atta a colpire dritta al cuore il sistema di militarizzazione generalizzata e a scalfire e incrinare un meccanismo apparentemente solido che muove gli ingranaggi dell’occupazione armata. Tuttavia, come ribadisce Yeheli, la ribellione dei refusenikim è attaccabile su vari fronti. «È difficile determinare il numero preciso dei refusenikim e restituire quindi la reale portata di questo movimento. Basti pensare che se da un lato vi è una parte di attivisti che proviene da situazioni di minor ricattabilità e si sente libera di rendere pubblica la sua voce, esiste un sommerso di persone che teme di esporsi pubblicamente».

Poi è arrivato il 7 ottobre e tutto si è fermato.
«Ovviamente da quel giorno viviamo nella paura. Il livello di odio e di violenza è salito tantissimo negli ultimi mesi, anche nei nostri confronti. Riceviamo molti attacchi pubblici e minacce. Anche protestare e diventato ancora più difficile e il livello di repressione è sensibilmente salito. L’essere un oppositore o un obiettore è ancor di più uno stigma che attira invettive e scatena aggressioni di varia natura. È molto difficile prendere voce pubblicamente, perché è vero che la maggioranza è contro il Governo perché si ritiene tradita da esso, ma è altrettanto vero che la società israeliana si è spostata ancora più a destra. L’opinione pubblica è contro Netanyahu, ma essere contro il Governo non significa esser contro la guerra. Tante persone che la pensavano come me sono state profondamente spezzate dagli episodi del 7 ottobre e hanno cambiato idea. Il gruppo è diventato più piccolo. Prima del 7 ottobre avevamo condotto una campagna contro l’occupazione dei territori palestinesi, accompagnata da un appello, a cui era seguita l’occupazione di una scuola. Riuscimmo ad ottenere le firme di 280 persone, che per noi è un numero molto alto perché significa mettere il proprio nome e cognome in mano alle Forze di Difesa. Stavamo per far partire altre tre campagne politiche che siamo stati costretti a rimandare. Anche io in questo momento ho difficoltà a trovare una soluzione. So soltanto che la soluzione non è quella militare. Penso che, prima di tutto, dobbiamo costruire una contronarrazione che vada oltre la criminalizzazione e la disumanizzazione reciproca».
Molte di queste campagne politiche portate avanti dagli attivisti e dalle attiviste di Mesarvot vedono la collaborazione di molti palestinesi e di drusi (una delle poche etnie non ebraiche chiamate a servire nell’esercito). «Molti nostri collaboratori drusi sono anche attivisti a titolo personale in Cisgiordania, per esempio a Masafer Yatta, (nel Governatorato di Hebron, è una delle zone più calde in cui hanno luogo violenti attacchi militari contro civili palestinesi). Per esempio, uno degli ultimi episodi verificatosi ad un nostro attivista, un ragazzo di 17 anni, è avvenuto proprio in un villaggio nella Valle del Giordano. Il ragazzo, riconosciuto come uno dei nostri, è stato preso da alcuni coloni, tratto in un luogo isolato e picchiato senza pietà. Pensavo fosse morto e non sapevo cosa avrei detto al padre. Fortunatamente è ancora vivo».
Essere un israeliano di sinistra, un attivista, un refusenik equivale a essere emarginato, schernito, isolato e aggredito.
«Anche se è molto difficile da amare, questa è anche casa mia. Sono nato qui e non saprei dove altro andare. E purtroppo tutte queste contraddizioni le vivo quotidianamente. Sono stato arrestato diverse volte, ho perso molti amici in questa guerra lunghissima, vivo nella costante consapevolezza di essere sotto controllo. Ho perso degli amici anche il 7 ottobre. È come se la realtà stesse collassando in maniera inesorabile: non possiamo manifestare, non possiamo opporci e allo stesso tempo le informazioni più importanti passano attraverso il megafono del Governo. Viene così a mancare una voce che non sia fatta solo di demonizzazione e terrore verso i palestinesi e che non abbia come sola e unica soluzione una guerra all’ultimo sangue. Dobbiamo fare i conti con la realtà: ci sono due popoli e nessuno dei due se ne andrà. Cacciare uno dei due popoli con la forza non è solo immorale ma anche impossibile. La questione è: quanto sangue dovrà ancora esser versato?».
Daniela Galiè
22/12/2023 https://www.dinamopress.it/
Immagine di copertina di Edo Ramon, Refusing to Occupy, 2016, da Flickr


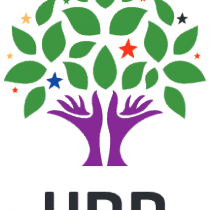







Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!